DEL SILENZIO E DEL RISO
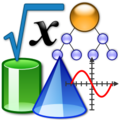
Chiamato a pronunciarsi sul paradosso di Zenone, il cinico Diogene di Sinope non disse nulla, si alzò in piedi e si mise a camminare.
Le fonti non dicono se i presenti scoppiarono a ridere, oppure se considerarono imbarazzante o addirittura irriverente il suo comportamento; fatto sta che, nonostante la grande popolarità di cui Diogene godeva, non credo che i presenti considerassero il camminare una confutazione del famoso paradosso. Del resto Diogene era noto per essere lui medesimo un paradosso vivente, per le sue stranezze (viveva in una botte e non giudicava disdicevole masturbarsi in pubblico) e anche per le sue battute fulminanti.
I paradossi logici svolgevano un ruolo essenziale nella cultura greca pre filosofica, così come – in epoca ancora precedente – lo scioglimento dell’enigma. Il paradosso di Zenone continuò a essere ritenuto inconfutabile da un punto di vista logico fino ai nostri giorni più o meno e secondo alcuni i paradossi logici (non solo questo ma anche gli altri di Zenone, meno famosi ma altrettanto importanti) sono inconfutabili e basta. Secondo altri, non lo sono perché scritti in modo tale da non esserlo, dal momento che la loro formulazione serviva ad altro e cioè ad allenare la mente a ragionare. In rete si trovano molti siti che discutono sui molti tentativi di confutazione ma anche di adesione all’idea della inconfutabilità.
Personalmente trovo suggestivo e geniale il ragionamento di Bertrand Russell (è una confutazione oppure no?), che sostiene la seguente tesi che riporto nella sua enunciazione e non nelle sue formule matematiche (calcolo infinitesimale) che peraltro si trovano facilmente in rete. Due insiemi possono essere divisibili in infinite parti ma questo non esclude che uno dei due sia più grande dell’altro. Abbandoniamo momentaneamente il filosofo inglese.
De Ruggiero, nella sua monumentale Storia della filosofia, prende invece sul serio il gesto compiuto da Diogene e lo considera come una vera e propria confutazione.
Il primo a cimentarsi, in epoca filosofica, con il paradosso di Zenone fu nientemeno che Aristotele. La sua argomentazione è la seguente: esiste uno stato potenziale del movimento ed esiste il movimento in atto. Sul piano potenziale il ragionamento di Zenone era inconfutabile e quindi la distanza fra Achille e la tartaruga poteva essere suddivisa in segmenti sempre più piccoli all’infinito; ma questo non era più valido se dallo stato potenziale si passava al movimento in atto. In apparenza, tale ragionamento sembra avere tutti i crismi del buon senso, ma apre almeno tanti problemi quanti ne risolve. La sua argomentazione potrebbe essere considerata come la spiegazione logica e argomentata del comportamento di Diogene di Sinope: camminare è movimento in atto. Aristotele dunque, nella sua confutazione, introduce surrettiziamente il concetto di esperienza o di potenza in atto per confutare un’argomentazione di tipo logico, il che era considerato da molti un trucco, almeno ai tempi suoi. Personalmente ritengo che la scienza sperimentale abbia radicalmente mutato le cose, ma so altrettanto che molti filosofi non sarebbero d’accordo e mi tirerebbero le orecchie. Tuttavia, se stiamo parlando di Aristotele e cioè di un tempo in cui il metodo sperimentale era di là da venire, la confutazione del nostro appare inconsistente. Perché allora Aristotele usa tale argomento piuttosto grossolano? Lasciamo per il momento la domanda in sospeso e rivolgiamoci di nuovo al contesto del paradosso di Zenone e anche di Diogene di Sinope.
Uno dei nodi del problema sta nella possibilità o meno di considerare il paradosso di Zenone un’argomentazione di tipo sofistico. Lui e altri proprio a quella corrente filosofica vengono di solito ascritti, ma Giorgio Colli, per esempio, avanza dei dubbi che sono venuti anche ad altri. Il contesto è quel momento assai fertile ma anche avvolto più di altri in una sottile nebbia, nella storia del pensiero greco. Gorgia, molto probabilmente, non era un sofista, ma un uomo sgomento di fronte a un’evidenza sconvolgente. Come gli antichi che si dedicavano allo scioglimento dell’enigma, egli riteneva che la verità fosse alla portata degli esseri umani, ma che essa non andasse cercata per quella via (l’enigma e la sua decifrazione), ma tramite la dialettica, che per lui era l’arte di condurre il discorso e non ciò che viene subito in mente a noi che siamo post hegeliani. Di fronte ai paradossi del linguaggio e constatato come con esso si può sostenere qualsiasi cosa e anche il suo contrario, Gorgia comprese che neppure per quella via e forse per nessun’altra la verità fosse alla portata degli umani. Non solo: quanto più si era abili nel condurre il discorso, tanto più si correva il rischio di finire in argomentazioni e paradossi che allontanavano dalla verità altro che raggiungerla! La sofistica è l’arte del paradosso, ma non credo che Gorgia lo fosse e infatti recenti studi affermano proprio questo: manca in lui il compiacimento (tipico dei sofisti) di rivoltare la frittata a proprio piacimento. In Gorgia e nei sui amici è lo sgomento a prevalere. Partiti lancia in resta alla ricerca della verità, scoprono la menzogna! Con Gorgia svanisce definitivamente l’illusione di possedere la Sofia, cioè la Sapienza: da quello scacco nacque un lavorio intermedio del pensiero che sfocerà nella filo-sofia e darà vita alla setta degli amanti di Sofia: i filosofi.
Con Aristotele siamo già nel pieno dell’epoca filosofica, ma la filosofia è ancora giovane e come tutti i giovani è anche un po’ arrogante. Non mi riferisco qui all’età anagrafica di Aristotele e alla sua personale arroganza, che tuttavia un po’ emerge nella confutazione del paradosso di Zenone. Il nostro non se ne cura perché pensa che si tratta di argomentazioni che non vanno resuscitate. Mi pare persino di sentirlo parlare e dire in sostanza a suoi discepoli: Ancora con queste sciocchezze della Sofia, degli enigmi e dei paradossi? La sua argomentazione infatti è un po’ tirata via, come quando non si dedica troppa importanza a una cosa, altrimenti si sarebbe accorto di avere introdotto in una confutazione logica un argomento esperienziale che non poteva essere usato: e infatti non mi risulta che qualcuno abbia preso sul serio la sua confutazione, probabilmente neppure lui stesso, così rigoroso nel porre limiti e barriere alle enunciazioni.
Torniamo a Diogene di Sinope. Di fronte all’aneddoto che lo riguarda, così come di fronte agli altri, alcuni dei quali notissimi (oltre al vivere in una botte, la lanterna con cui cercava l’uomo, ma anche la sua risposta fulminante a chi gli chiedeva dove abitasse “sono un cittadino del mondo” risposta assai sorprendente per quell’epoca) mi sono chiesto più volte per quale motivo siano giunti fino a noi. Può essere che il buon Diogene sia stato così sfortunato da vedere distrutte tutte le sue opere, ma se anche così fosse e se potessimo dunque ipotizzare, come in un romanzo fantastorico, che il nostro Diogene fosse in realtà un gigante del pensiero le cui opere si sono perse, tranne poche battute qui e là, rimarrebbe comunque il mistero di capire per quale motivo qualcuno ha ritenuto tali aneddoti da conservare. Le fonti sono incerte anche sulla scrittura: dei presocratici rimangono dei frammenti scritti, alcuni anche assai estesi e dunque di per sé non può essere questo il motivo della scarsità di fonti, anche perché sappiamo che il nostro godeva di grande popolarità. Se qualcosa ci arriva da quei tempi così remoti, dobbiamo sempre venerare con commozione colui o colei che si sono presi cura di quel frammento o di quel libro perché lo hanno ritenuto significativo, senza ulteriore speculazione sulle loro ragioni. Arrivati così fino a noi possiamo leggere gli aneddoti e le citazioni con i nostri occhi e domandarci se non ci sia sfuggito qualcosa. Eccome se andava trasportato nei millenni fino a noi l’aneddoto! La portata del gesto compiuto da Diogene mi sembra assai rilevante, ma la sua grandezza non va cercata a mio avviso nel camminare, ma nel “non disse nulla.” Rimanendo in silenzio, Diogene ha compiuto un gesto filosofico di enorme portata: da un lato ha reso evidente l’inconsistenza del paradosso sul piano fattuale, dall’altro ha indicato il limite del linguaggio. Solo nel silenzio poteva essere mostrata la confutazione; e con un gesto allusivo, non verbale. La Sofia non era del tutto scomparsa, ma poteva mostrarsi e risuonare solo così.
L’aneddoto riguardante Diogene di Sinope me ne ricorda un altro, analogo e precedente. Siamo nel settimo secolo e Talete, mentre guarda il cielo, cade in un fosso. Una fanciulla tracia, che assiste alla scena, scoppia a ridere e lo prende in giro. Il riso svolge in questo aneddoto la stessa funzione del silenzio nell’altro. Ridere è un gesto che sta ai confini del linguaggio, come ci sta il silenzio. Al di qua il linguaggio esiste come codice e casa dell’umano, al di là si affaccia come allusione a ciò che esisterebbe anche senza di noi. L’umano abita una soglia e un precario confine, in equilibrio precario ed esposto a cadere fuori di esso, o al suo interno vivendolo però come codice. Forse l’eterna diatriba fra il linguaggio come codice o il linguaggio come eco di qualcosa che lo trascende ha una spiegazione logica nell’essere gli umani sulla soglia e dunque destinati a cadere da una parte o dall’altra, oppure a tenersi in equilibrio, come un pendolo. Non abitiamo il mondo (ci stiamo troppo poco), così come non abitiamo il linguaggio, ma stiamo sul confine.
La genialità di Bertrand Russell, con il quale concludo questo discorso forse un po’ strampalato, sta però nell’esempio che sceglie per dimostrare la sua ipotesi matematica che ripeto qui: due insiemi possono essere divisibili in infinite parti ma questo non esclude che uno dei due sia più grande dell’altro. Dopo essersi servito della matematica e del calcolo infinitesimale per dimostrare la sua tesi, Russell per renderla comprensibile e alla portata di tutti, sceglie un esempio letterario da un romanzo inglese assai noto e sperimentale per l’epoca in cui fu scritto:
Tristran Shandy vuole scrivere la propria biografia. La sua vita e la sua biografia sono due insiemi distinti e divisibili ciascuno in parti, infinitesime. Shandy comincia il suo lavoro e dopo un anno di tempo ha descritto i primi due giorni della sua vita …
