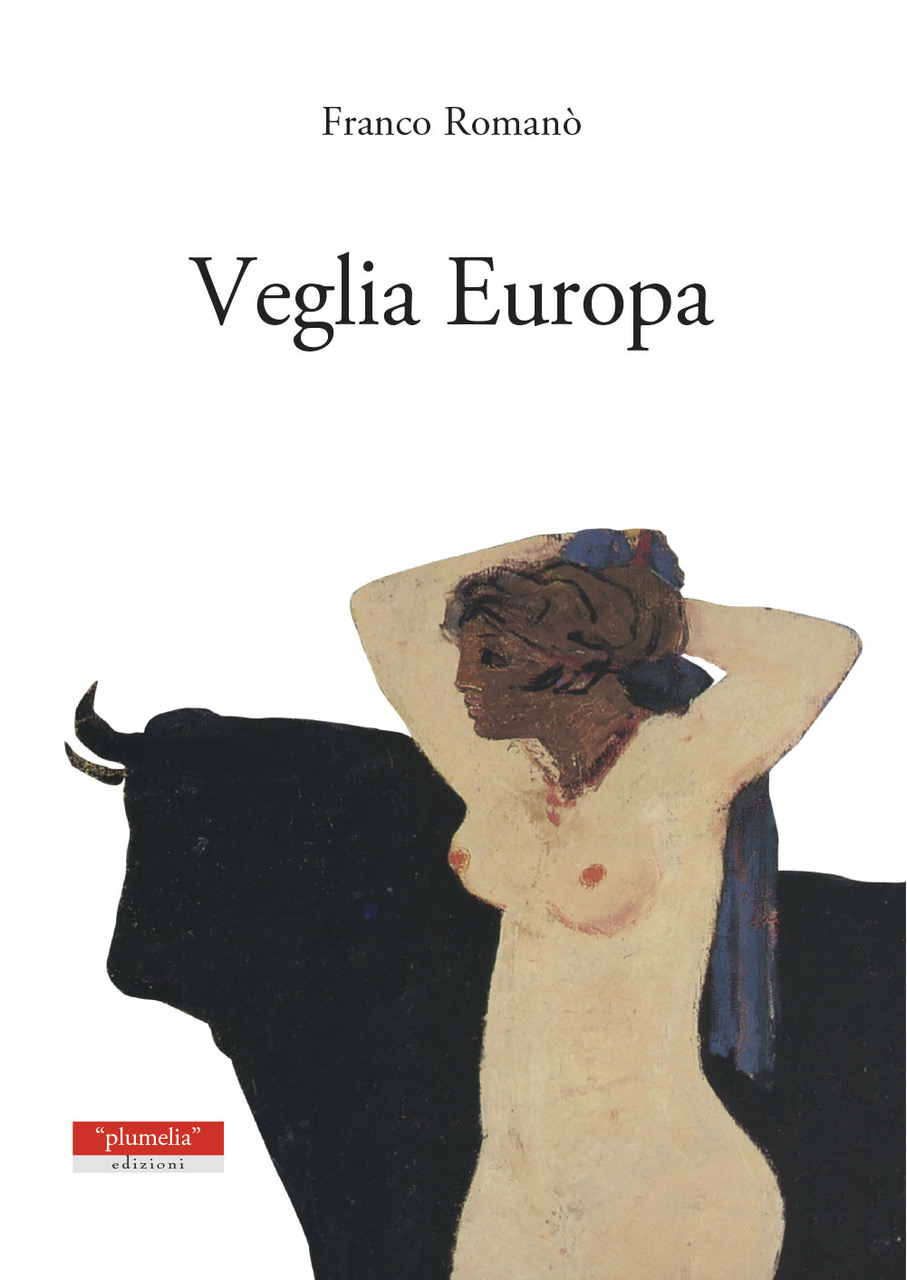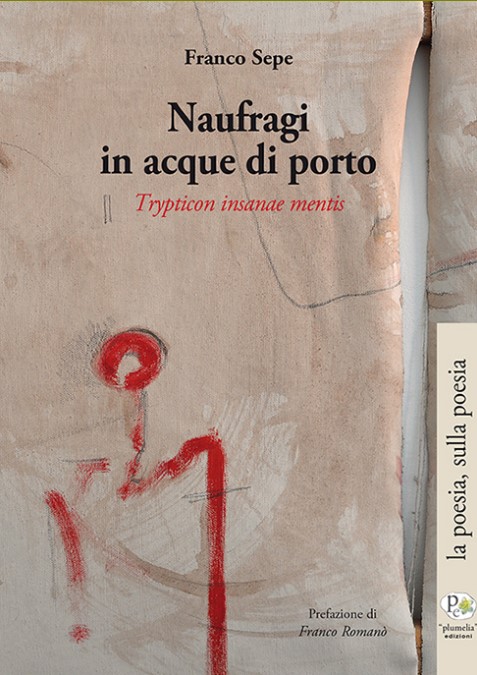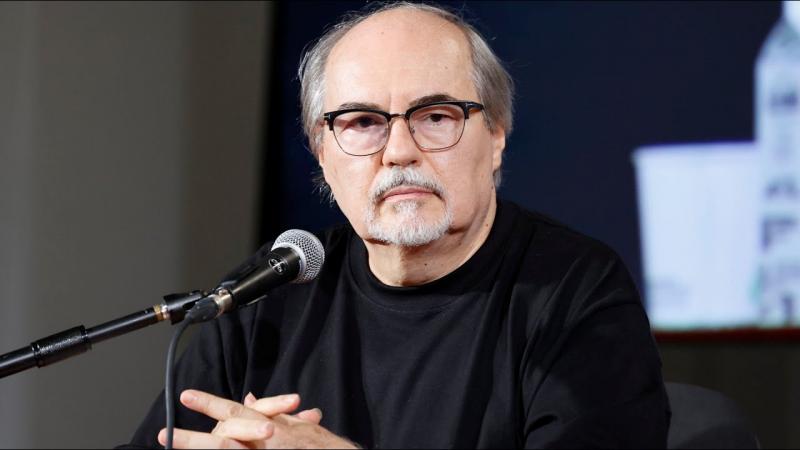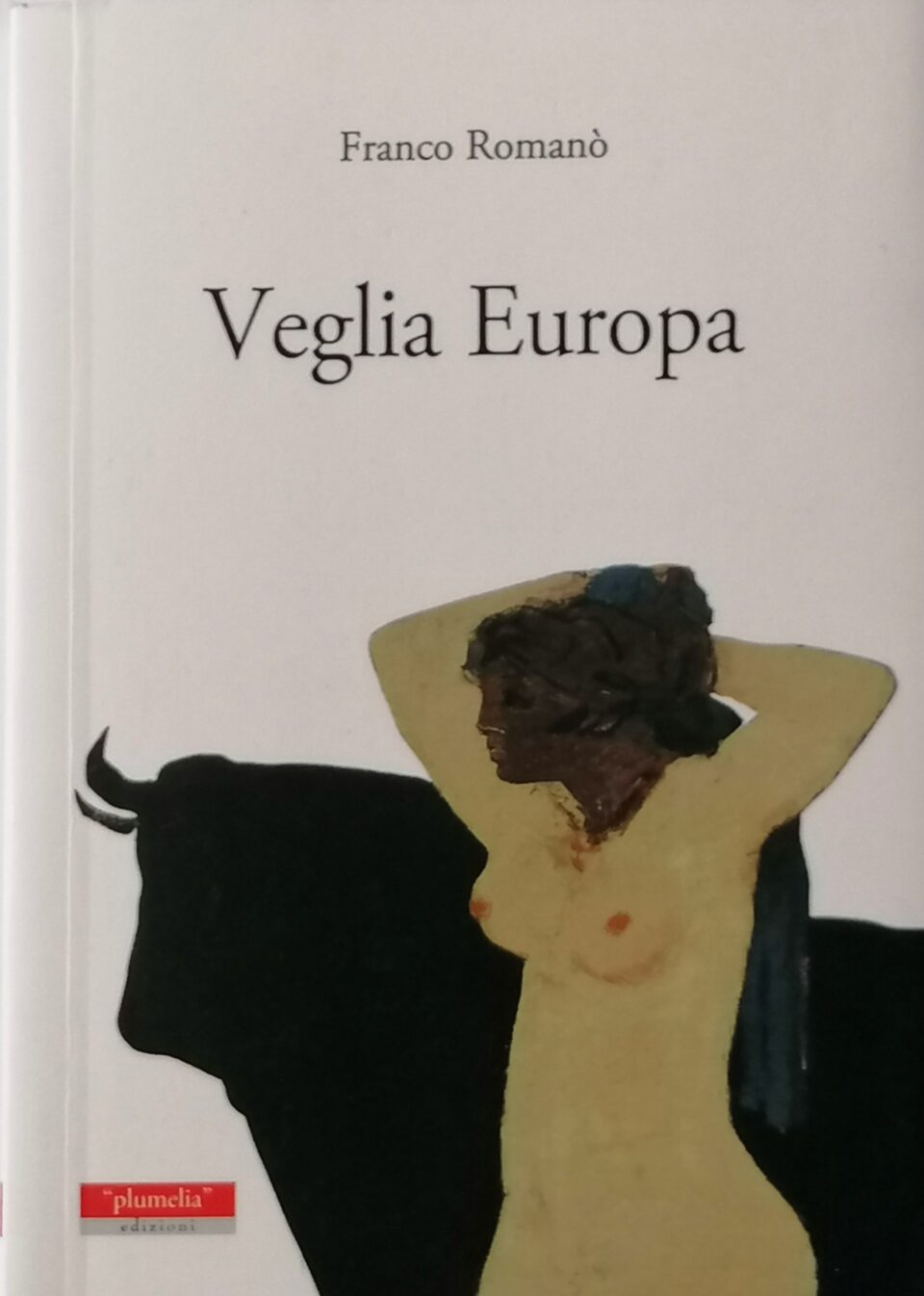ONDA SONORA, UN PROGETTO INTERMEDIALE

Premessa
Su invito della curatrice Elisa Longo ho partecipato a una puntata di Vocale, andata in onda su Fango Radio il primo aprile scorso e ora disponibile in podcast: un’esperienza per me nuova, assai intrigante che mi ha spinto a una riflessione che vuole essere però anche un dialogo. Ho proposto allora alla curatrice un’intervista che viene pubblicata qui di seguito insieme a tutti riferimenti riguardanti anche tutte le puntate precedenti di Onda sonora di Vocale e il progetto trasmesso da Fango Radio.
Franco Romanò: Parto dalla mia esperienza di ascoltatore che ha cercato di dimenticare la sua partecipazione in quanto autore: ho ascoltato tutto due volte, seguendo le istruzioni che lei aveva dato e cioè di ascoltare in cuffia. Il tempo è passato rapidamente e giunto alla fine a me era arrivato l’effetto di flusso, peraltro evocato anche nell’espressione onda sonora: probabilmente per cogliere anche le sfumature due ascolti non bastano, oppure è una questione di abitudine e di certo andrò ad ascoltare anche le puntate precedenti. Questa è la mia prima riflessione e questione che le pongo, basata unicamente sulla mia esperienza.
Elisa Longo: In primo luogo sono contenta del dialogo, per le sue riflessioni e la curiosità verso questo progetto.
Vocale rappresenta un flusso, un’onda, un viaggio attraverso il vasto campo della Poesia. Il suo fondamento si ritrova nel concetto di stream of consciousness introdotto da Joyce. Quando mi immergo nella lettura e nell’ascolto della poesia, la mia mente si popola di pensieri, suggestioni, e altro ancora, che talvolta sembrano estranei alla stessa poesia. Ho l’abitudine di registrare le poesie che mi colpiscono di più e di riascoltarle durante le mie attività quotidiane. Mentre le ascolto, si mescolano suoni, melodie, parole e dialoghi provenienti dal mondo circostante. Questo fenomeno a volte può risultare fastidioso, ma altre volte arricchisce l’esperienza d’ascolto, spingendomi a essere più attenta. La presenza di scenari reali in cui la poesia si inserisce mi fa percepire la poesia stessa come parte integrante della vita quotidiana. Vocale riporta la poesia alla sua dimensione vitale, integrandola nel flusso della vita di tutti i giorni.
Quante volte ci capita di essere interrotti durante la lettura da suoni estranei, come un messaggio o una canzone? Vocale si muove a destrutturare lo spazio tradizionalmente adibito alla poesia, che sia una pagina, un contesto o un ambiente. La poesia è concepita come un’entità permeabile e penetrante, che convive con l’ambiente circostante senza perdere la sua integrità.
A volte, è necessario fare più di un ascolto per cogliere appieno l’essenza di un’opera. In certi momenti, possiamo guardare qualcosa distrattamente, trascurando alcuni dettagli, ma se ripercorriamo l’esperienza con attenzione, ci accorgiamo che sono proprio quei dettagli a determinare l’intero quadro. Vocale è pensato sia per coloro che desiderano godere della poesia e dei suoni con un semplice ascolto e farsi travolgere dall’onda, sia per coloro che vogliono prendersi il tempo di rallentare, ripercorrere e approfondire. È per questo che ogni episodio del podcast è accompagnato da una tracklist completa degli autori, delle autrici, dei brani e delle suggestioni utilizzate. Io nutro sempre la speranza che ci sia un desiderio di approfondimento, e lo suggerisco senza imporlo.
FR: Vengo ora a un secondo aspetto più teorico: l’esperienza di Vocale è da un lato una evoluzione della poesia sonora, dall’altro però l’uso di diversi mezzi ne fa qualcosa di completamente diverso. Nelle performance che ricordo e mi riferisco in particolare a Milanopoesia, il festival organizzato da Gianni Sassi del 1983 nel ’91, c’era pur sempre un autore che andava su un palco anche se poi ci sono documentazioni video di quelle serate. Ecco, qual è stato lo spunto iniziale che ha dato vita a questo progetto e che relazione c’è – se c’è – con la poesia sonora?
EL: Per me, il processo di decontestualizzazione artistica è di fondamentale importanza. Agire in un ambiente predisposto all’ascolto o che suscita emozioni, è un territorio ben noto e relativamente semplice. Ciò che mi interessa veramente è esplorare la potenza e la resistenza della parola quando viene messa in contatto con ambienti insoliti, anche quelli che contrastano con il suo significato. Ricordo chiaramente un’esperienza in cui ho trovato un vecchio furgone russo in mezzo al nulla, in un prato in alta montagna, o quando ho visto un gregge di pecore attraversare una superstrada. In entrambi i casi, gli elementi principali mi erano noti, ma il contesto a loro estraneo rendeva l’esperienza molto più intensa. Il ricordo di quei momenti mi porta ancora a interrogarmi su come quei soggetti siano arrivati lì e sulle potenzialità del circostante, non come luogo accessorio, ma come luogo del re incontro con ciò che si è appreso, al quale si attribuisce un pensiero marmoreo e statico: una risignificazione dell’oggetto stesso e della parola che ne viene associata. Se penso a un gregge di pecore, in automatico il mio cervello associa a questa immagine un contesto appreso – un campo, un prato – a questo concetto e a questo ambiente a noi noto associamo una serie di vocaboli, emozioni, odori, sensazioni. Se invece le dico: “pensi a un gregge che attraversa una superstrada”, immediatamente a questa suggestione aggiunge una serie di emozioni, sensazioni e odori diversi, ma mette anche in gioco tutta un’area semantica di parole che nell’immagine usuale del gregge non avremmo mai pensato. Mi interessa lo scarto che si crea tra le prime parole, quelle note, e le nuove che il cervello associa all’oggetto stesso in un contesto inusuale. Trovo affascinante il ragionamento deduttivo e il contrasto. Penso che tutto quello che posso fare in questo momento, come amante e autrice di Poesia, sia cercare di portare energia e stimoli, di creare delle suggestioni per altri, che come me, lavorano in modo creativo. Quello che la Poesia rincorre è il linguaggio. A me interessa stimolare la mente di chi ascolta, fare in modo che si creino nuovi scenari e con essi nuove pensieri che risignifichino la parola stessa, non erudire.
La tradizione della Poesia sonora è senza dubbio fondamentale, ma in Vocale tutto viene ampliato, spostato e liberato dai confini. La poesia sonora si fonde con gli esperimenti dei rumoristi e si mescola a suoni diversi, alla musica e alle voci dei poeti, sia con scritture più tradizionali che sperimentali. L’obiettivo è rendere la poesia viva e dinamica in un ambiente non preconfezionato, ma piuttosto in un terreno di scambio, anche se spesso è un terreno denso di rumori e scarti che tentano di sconvolgere il significato della parola. Mi interessa particolarmente osservare e studiare quali parti del linguaggio riescono a sopravvivere a questa miscela o a questa lotta. Questo è ciò che mi appassiona e ciò su cui desidero concentrarmi con Vocale.
FR: Nella presentazione del progetto lei cita Jankins, Baruchello, Cage e Kandinskij. Sono nomi noti e importanti per diverse ragioni, ma la combinazione mi riporta una seconda volta al termine multimediale, ma anche intermediale. Vorrei che su questo punto dicesse qualcosa di più, anche perché mi sembra un aspetto centrale del progetto.
EL: Mi sforzo di sfruttare ogni elemento della realtà e tutti quegli strumenti, sia mediatici che non, che ci vengono messi a disposizione. In Vocale trovano spazio le voci dei lettori di Google, le frasi emesse dai distributori automatici e dalle casse automatiche, così come i suoni delle fontane, delle campane e dei sistemi in disuso come le audiocassette. Inoltre, ci sono riferimenti all’arte contemporanea, al cinema. Tutto ciò fa parte della nostra cultura. Nessuna forma d’arte può sopravvivere da sola. La poesia si inserisce nell’intero panorama culturale, senza confini, le voci dei poeti e delle poete dialogano tra loro e con il circostante.
Inoltre, Vocale opera anche con la dimensione dello spazio-tempo, riportando in auge conoscenze e interrogativi ancora attuali, già esplorati dai grandi maestri della poesia del passato. Mi impegno a recuperare tali domande attraverso l’utilizzo di filmati d’epoca e a reinserirle nel contesto contemporaneo, riattualizzandole. Nell’era attuale, la durata di vita di un libro è sempre più breve, e mi appassiona coinvolgere autori con opere meno recenti affinché leggano estratti dei loro scritti, così da riportare in circolo quel linguaggio e quei concetti.
Spesso, quando si pensa a una lettura poetica o a un programma radiofonico dedicato alla poesia, si crea un ambiente sterile, con una sorta di separazione silenziosa tra le parole, chi le ascolta e l’ambiente circostante. Tuttavia, le parole del poeta traggono origine da suggestioni spesso estranee al silenzio.
FR: Quello che lei dice mi fa venire in mente due nomi e un episodio legato a uno dei due: Benjamin e Brecht. Il primo perché i suoi saggi sul rapporto fra parola, arte in generale e le trasformazioni tecniche avvenute dall’avvento della fotografia e del cinema in poi, sono una pietra miliare della critica novecentesca. Il secondo perché alla domanda se avesse bisogno del silenzio per scrivere, lui rispose – cito a memoria ma il concetto è quello – che preferiva le finestre aperte e il rumore dei clacson.
EL: I suoni ci rimettono al mondo. Lo dico in ognuno dei sensi che possono essere attribuiti a questa mia frase e in questo sono in totale accordo con ciò che diceva Brecht. I suoni che arrivano da una finestra aperta ci possono risvegliare da un torpore, ci ricordano che esiste altro oltre noi, tengono il nostro ego a bada, ci aiutano a posizionarci nel lavoro artistico che stiamo affrontando.
Posso cercare il silenzio durante la scrittura, ma non mi separo, poiché in ogni cosa esiste un dialogo costante. Vocale incarna la molteplicità di voci, suggestioni e riferimenti che prendono vita nella mente di chi scrive, ma è anche la stessa molteplicità che si anima nella mente di chi ascolta.
Ciò che Walter Benjamin vedeva nel suo saggio del 1936, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica era: la cultura di massa da una parte e l’avanguardia artistica dall’altra, che secondo Benjamin, sono accomunate dalla perdita dell’aura. L’aura per Benjamin era il concetto di sacro che l’arte aveva custodito nei secoli precedenti e che era stata distrutta dalla rapida riproducibilità tecnica che portò alla cultura di massa da una parte, ma anche dalla dissacrazione dell’arte usata in modo provocatorio dalle avanguardie.
L’arte perdeva la sua aura, la sua sacralità e con questa il concetto di autentico e Benjamin vedeva questa spoliazione come funzionale al progredire dell’arte, della sua trasmissione, riproduzione e accessibilità.
Il problema dell’accessibilità, nei nostri giorni pone di nuovo alla ribalta il tema dell’autentico, sia per l’arte massificata, nell’accezione dell’attribuzione di opera di genio ( si veda il caso degli NFT in arte), sia per le aree dell’arte che si occupano di ricerca, nell’accezione di forma.
Vocale usa audio “sporchi”, non perfetti. In questo modo l’opera, seppur riproducibile si autentica sfuggendo alla massificazione, in un’epoca dove la riproducibilità di massa è perfezione (del suono, dell’immagine, etc). Per questo in Vocale tengo gli errori di registrazione, ci sono vasi che si rompono in diretta perché sono caduti mentre registravo, papere, errori di pronuncia. Tutto viene lasciato come marchio di produzione creativa umana fallace.
L’intermedialità mi aiuta invece a livello formale sfidando ciò che definisco la struttura del pensiero borghese, costruito e orientato secondo il binomio bene-male. Vocale adotta una struttura che definirei schizofrenica: un pensiero che non segue le logiche del bene o del male, ma quelle della sopravvivenza. Tale non-struttura mi consente di creare scenari atipici che favoriscono la formazione del pensiero e lo stimolano, inoltre pone il progetto in un continuum che sfugge alla sua definizione.
FR: Nel rivolgervi a poeti a artisti come vi siete orientati? Avete trovare solo consenso oppure anche scetticismo?
EL: Ho selezionato le voci dei poeti e delle poete che avrei voluto ascoltare di nuovo, come facevo con la mia vecchia cassettina da adolescente. Scelgo autori che ammiro, altri che desidero esplorare, alcuni che mi incuriosiscono per un lavoro particolare, mentre altri li scelgo per vedere come il loro testo reagisce a un ambiente diverso.
Devo dire che la stragrande maggioranza degli autori e delle autrici contattati ha risposto con entusiasmo. Alcuni lo prendono come un semplice reading, ma sono pochi; altri provengono da esperienze sonore e sono abituati a questa forma di espressione, mentre altri si cimentano per la prima volta e si divertono. Mi impegno per offrire ai miei ascoltatori il meglio degli autori e delle autrici a cui riesco a accedere, e a volte può essere difficile mantenere un alto livello. Il concetto che è difficile da spiegare ai poeti è quello del pensiero unico che viene decontestualizzato, spezzato, ma integrato.
FR: Fango Radio è stato il veicolo di Vocale, ma è anche un emittente; oppure è nata solo per il progetto? E perché la scelta di questo nome?
EL: A questa domanda le riporto la risposta del collettivo fondatore di Fango Radio. “FANGO è un nome scelto di pancia. FANGO RADIO è una piattaforma di sperimentazione, una porta aperta alle belle elucubrazioni. FANGO RADIO scava nei suoni. Trasmette dal lunedì al venerdì: qualche volta succede qualche trasmissione speciale il sabato o la domenica. Per ascoltarci puoi usare il nostro player o collegarti direttamente a questo link.
Siamo su Facebook
https://www.facebook.com/fangoradio
Su Instagram
https://www.instagram.com/fangoradio
Abbiamo qualche mercanzia su Bandcamp
https://fangoradioeditions.bandcamp.com/
FANGO RADIO compie 5 anni quest’anno e ha ancora tanto da imparare:
https://www.fangoradio.com/events/344
https://www.facebook.com/events/7535527493159200
FR: Il venti aprile si terrà una vostra performance pubblica a Busto Arsizio al circolo Gagarin: ce la vuole presentare?
EL: Vocale è stato invitato come ospite all’Aperitivo Letterario per festeggiare il quinto anniversario di Fango Radio e ha preparato uno spettacolo unico dal titolo “Non è un reading”.
Si tratta di una performance che unisce poeti, poete e sound artist che leggeranno le proprie opere accompagnate dall’energia di suoni e musica preparati in perfetto stile Vocale. Durante lo spettacolo, non ci si siederà semplicemente ad ascoltare, ma ci si lascerà trasportare dall’intensità delle parole degli autori e delle autrici che saliranno sul palco.
Il vero risultato della performance verrà catturato dalla radio, che oltre alle voci dei performer, registrerà anche i suoni e le voci del pubblico presente.
Alla guida di questa prestigiosa banda ci sarò io, Elisa Longo, accompagnata da Giorgia La Placa, Ilaria Boffa, Laura Recanati, Emanuele Bottazzi Grifoni, Silvia Atzori, Benedetta Manzi e con le interferenze sonore di Mariagiorgia Ulbar, Michelangelo Coviello e Danilo Paris.
L’evento si terrà sabato 20 aprile dalle 19:00 alle 20:00 sul palco Vocale live – Non è un reading presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA), nell’ambito della celebrazione Fango Radio 5Years, dove artisti sonori internazionali, musicisti e poeti si esibiranno fino a tarda notte. Potrete anche ascoltarci in streaming su Fango Radio.
La ringrazio per questo straordinario scambio e invito tutti a seguirci sulla pagina Instagram di Vocale, che trovate con il nome Vocale.poesia. Per chi volesse riascoltare le puntate, potrà farlo visitando il seguente indirizzo: https://www.fangoradio.com/shows/301