
La trama e i personaggi
La trama de Il tempo dei morti di Alessandro Carrera, appena uscito per Moretti&Vitali, è costituita da una vicenda famigliare che ricorda anche l’ambientazione di Piccola città di Wilder, come viene detto nella prefazione di Franco Nasi, che si riferisce a una nota dell’autore, contenuta nell’intervista finale. Quanto ai personaggi – Il Padre, la Madre, il Figlio, Il Bambino Morto, l’Angelo, il Droghiere, il Coro dei morti, il Padre ragazzo – essi sembrano richiamarsi lontanamente alla trinità cristiana, circondata da altre figure più o meno canoniche a essa collegate; tuttavia, alcune vistose anomalie rendono tale riferimento subito precario. Prima fra tutte la presenza del Droghiere, forse il personaggio più importante, insieme al Coro, indicato peraltro con un parola ormai desueta, nel senso che lo smercio tipico di quella attività è stato assorbito da mercati più ampi: il Droghiere ci riporta indietro nel tempo. Che mondo è dunque quello che viene rappresentato? Se stiamo alle indicazioni di scena iniziali vi sono pochi dubbi: tutta la vicenda è ambientata in un cimitero. La poesia, a cominciare da quella che abbiamo imparato a scuola, è piena di discese nell’Ade, di morti che parlano, di viaggi iniziatici, di miti: sono personaggi di autori memorabili che ognuno ricorda. Anche il cinema, l’arte più moderna, ha frequentato il mondo di là, in vari modi: da La voce della luna di Fellini al Nosferatu di Herzog; infine il teatro. L’episodio biografico cui Carrera si riferisce e cioè proprio una rappresentazione teatrale cui assistette suo padre nell’immediato dopoguerra, è un segnale importante. Lasciate stare i nostri morti fu urlato dal pubblico che vi assisteva: i lutti ancora recenti avevano alimentato quel grido, ma la memoria di quell’episodio ha lavorato a lungo nella mente e nel cuore dell’autore se dopo decenni, quei morti tornano a parlare. Non ci dicono nulla sull’aldilà: siamo in piena modernità, questi morti hanno lo sguardo sempre puntato sul mondo che li ha ospitati da vivi, guardano all’al di qua e in questo ricordano anche i defunti dell’Antologia di Spoon river, ma solo come eco, perché in quei testi prevale una forza sintetica che spinge quei morti a esprimersi in un linguaggio definitivo, senza appello. Ne Il tempo dei morti, invece, è la tensione dialettica fra frammenti illuminanti e flusso a dominare. Tale tensione si stempera in un finale addirittura allegro, persino scherzoso e riconciliato, dal colore improvvisamente solare, a differenza della colorazione cupa che accompagna il testo fino a quel momento. Carrera qualche indizio sulle ragioni del percorso lo dà nell’introduzione e nell’intervista finale quando afferma che quest’opera, che lo ha accompagnato per molti anni, è stata:
una lotta con un fantasma, che nel testo è rappresentato dal Bambino morto … (Pag. 81).
A questa affermazione segue una rapida descrizione del contesto famigliare che provo a riassumere, con una precisazione e cioè che la ricostruzione della trama è qualcosa che il lettore può compiere a cose fatte, ma che non riguarda il tempo del testo – il tempo dei morti – che non può essere lineare come lo è invece qualsiasi ricostruzione ex post.
Nelle prime sette scene, concluse dal Coro dei Morti, si presentano le otto voci e il loro conflitto. Nella seconda metà del dramma (scene 8-14) il conflitto prende corpo. Il Figlio deve scendere nel Regno dei Padri per comprendere che cosa è accaduto tra il Padre morto e il Bambino morto, affrontando la paura della Madre. Il Figlio comprende ciò che è accaduto al Padre e allo zio (il Bambino morto), ma solo in sogno. Il Coro dei Morti esprime una certa ostilità verso l’Angelo, facendogli capire che la sua immortalità ai morti non interessa; quello che loro vogliono è vivere nel ricordo dei vivi. Il Droghiere sorveglia fino all’ultimo che le cose vadano a buon fine: il riscatto del Padre e del Bambino avviene, ma all’insaputa della Madre e del Figlio che, in quanto ancora vivi, non vi possono assistere. La comparsa del Padre Ragazzo, che ritrova il Bambino morto in un luogo e in un tempo in cui non c’è nulla di vicino o di lontano, conclude l’opera.
La dialettica fra squarci illuminanti e flusso porta il lettore dentro un vortice, di cui però alcuni indizi e segnali permettono di delineare dei confini sia spaziali sia storici. Qualche altro segnale lo lascia Carrera. Il suo accenno biografico alla fuga – l’espressione è soltanto mia ma mi sembra calzante – da Milano verso gli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80, anni assai decisivi sia per la grande storia, sia per quelle personali, offrono una cornice temporale sufficientemente riconoscibile a questa narrazione in versi. Nel primo racconto del Padre morto e poi in quello del Droghiere, la collocazione storica, emerge con sufficiente chiarezza, pur nel mezzo di riflessioni che seguono una loro logica interna ai personaggi, da monologo interiore. Siamo fra Milano e Lodi, cioè fra la grande e la piccola città di provincia: ci sono il teatro Carcano e la Scala, l’Eni di Enrico Mattei e i crucci di chi deve ricostruirsi una vita alla fine del conflitto. Il Droghiere tornerà a parlare intorno agli stessi temi.
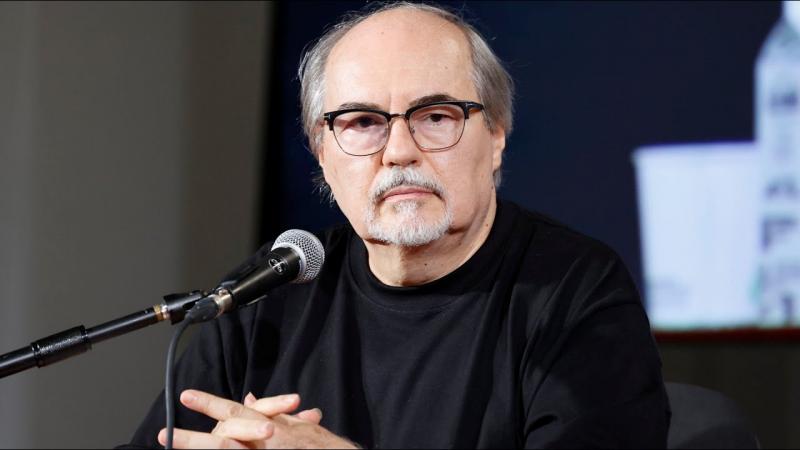
Il Droghiere
Anche a successive riletture continua ad apparirmi come il personaggio più importante, insieme al Coro. Nel suo primo intervento rimprovera il Padre, lo esorta a dimenticare il discorso che intende fare e che sarebbe poi l’orazione funebre dell’amico in occasione del suo funerale. Capiamo subito che la relazione fra il Droghiere e il Padre morto è stata una grande amicizia:
Metti via che non serve. I discorsi
Già stancano i vivi, ma qui non ci sono
Che morti, stanchissimi e morti. Non so
chi ha voluto che fosse così, alle
Pagine del libro che lo spiega non
C’è volta che ci arrivo …
Il tono ironico dei primi versi si rovescia nella seconda parte: la domanda implicita rimane sospesa e l’accenno alle pagine di un libro che dovrebbe poter spiegare ogni cosa si apre a significati molto estesi. Nella seconda parte del suo discorso torna l’ironia e il tono s’abbassa considerevolmente:
… Gli esami, lo sai, non li davo.
Non per colpa di donne
o di treni, ma a lezione facevo tardi
Anch’io, e perdevo l’inizio; di tutto,
di come son fatte le cose, di quando
comincia la donna nell’uomo, la radice
quadrata di Dio. Tu sei ancora troppo
vivo, hai le guance bagnate di sonno
e di sogni, non ti basti come noi
ti vorremmo, ti tieni così stretto
a chi sei stato, mi sembri l’internato
di Mauthasusen che a casa da sei
settimane ancora serrava la gavetta
fra le mani vuote …
Il Droghiere rifiuta il discorso/narrazione della storia fatto dal Padre Morto, ma non propone un punto di vista più elevato: neppure lui ha una risposta definitiva, le sue debolezze sono umane come quelle di tutti gli altri, non è la trasfigurazione di una capacità superiore di vedere le cose. Insieme al Padre rappresenta una coppia di amici che hanno vissuto gli stessi anni e le stesse inquietudini: sullo sfondo il difficile secondo dopoguerra. Il Droghiere, in definitiva, sembra essere poco più di un fratello maggiore. Sono vite bloccate, diversamente prigioniere di un destino ormai postumo – sia esso del tutto personale o meno – che può essere ricostruito solo per frammenti, i quali tuttavia non dialogano fra di loro se non raramente e il motivo sarà proprio l’Angelo a dirlo, come vedremo. Quest’ultimo, più che caduto, scende per scelta nel mondo. Se è un Angelo ribelle, la sua è una ribellione tenue, assomiglia di più a una diserzione: un poco ricorda l’angelo di Un cielo sopra Berlino, ma quello che dice nella prima sestina, è una sentenza che assume la funzione di chiave – intendo il termine nel suo senso musicale – della sua presenza nell’opera:
Prima sestina dell’angelo:
Mi sono ribellato, perché esser felici è intollerabile.
Ho scosso il capo alla salvezza, sotto stelle senza pena,
e sono sceso. Ti annuncio il dolore, l’unica novella
che non mi fa arrossire. Forse non abbraccio il tuo potere,
tanto è più grande del mio, che invece di riavvolgere
il tappeto manifesto lo consola di una nuova tramatura.
e sono sceso. Ti annuncio il dolore l’unica novella, è questa la sola novella che non fa arrossire chi la pronuncia. Lo spostamento rispetto alla buona novella cristiana è decisivo. Successivamente, le parole dell’Angelo, quando si rivolge alla Madre, esprimono a mio giudizio uno dei temi più importanti dell’opera:
L’Angelo
Un oblio insondabile e perfetto
Trascorre da una schiatta all’altra
Con la stessa ardente cura
Con cui gli uomini si traggono il sapere.
Pienezza dei padri è soltanto l’infanzia dei figli,
saggezza intrasmissibile dei vecchi
È che i giovani, lungo la memoria,
diventeranno più e più immemori …
L’oblio, l’impossibilità di una trasmissione fra le generazioni, ma anche fra i membri di una famiglia, la perdita di memoria. l’Angelo lo ribadisce e dunque dalle sue parole emerge quel tanto di consapevolezza in più che tuttavia non può essere condiviso. Siamo così lontani da quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni? La perdita di memoria storica, oppure la sua reiterazione inutile perché banalmente ritualizzata, non sono forse una delle caratteristiche salienti del nostro tempo? Quanto alla memoria personale, sappiamo quanto sia labile e sottoposta alle rimozioni: come sia facile scambiare date e situazioni. In fondo, anche per i vivi, il tempo lineare è una difficile conquista. Solo il lettore, a questo punto, può decidere di assemblare i frammenti diversi di queste consapevolezze. In questo senso, il testo di Carrera chiede la sua cooperazione ma non la sua complicità perché i silenzi, i vuoti, persino le amnesie – nonostante il flusso – o non permettono una sintesi, oppure ne permettono molte; o a ciascuno la propria.
I dialoghi fra la Madre e il Figlio sono stati per me la parte più difficile da decifrare. Non mancano anche nei loro interventi frammenti illuminanti, ma sembrano correre su due binari paralleli: la discesa alle Madri è particolarmente difficile e lo è forse di più per un uomo, se ha nicchiato pure Goethe come afferma Carrera nell’intervista. La ragione per cui il Figlio è nato e insieme non nato, anzi disnato, è la presenza del Bambino Morto, il fratello del Padre, morto da bambino in circostanze cupe e che porta lo stesso nome del Figlio. Tuttavia, si comprende che del Regno dei Padri la Madre non sa e non vuole sapere nulla e teme che il Figlio non faccia più ritorno, mentre lui deve staccare da sé il fantasma del Bambino morto per poter dire di essere nato. Anche il Figlio e il Ragazzo morto sembrano condannati a un linguaggio ancora più magmatico perché la loro esistenza, più ancora di quella degli altri, è senza interlocutori. È questa la ragione per cui i versi con cui si esprimono sono così franti rispetto alla solennità di altri? Probabilmente sì, ma talvolta ho avuto la tentazione di leggerli senza la cesura del verso decisa da Carrera. Nel primo intervento del Figlio pare di sentire tutto l’affanno del dire, anche se nel finale s’intravede una possibile luce:
Pure un indizio
Di memoria
Ancora mi raggiunge,
mi questiona.
Anche nelle prime battute della Madre s’avverte il medesimo affanno, è un parlare a se stessa più che al figlio, c’è una distanza palpabile che rende la comunicazione quasi impossibile. In un passaggio la Madre ricorda Maria, quando implora il Figlio di non interrogarla e prosegue così:
… comprendimi in silenzio,
io ti ho concepito nel silenzio,
tu destino, tu contemplazione,
come io fui contemplata e soppesata.
Il silenzio, in questo caso, sembra essere quello di chi nel progetto generale non ha avuto voce, perché è stata contemplata e soppesata da altri, cioè il mondo dei padri. Nelle parole della madre, infatti, la storia non compare mai e una volta sola sembra affacciarsi nelle parole del Figlio quando afferma:
Ragazzi come io non sarò mai,
seduti sui muretti
spruzzati con la canna,
intenti farsi grandi
sognarsi come padri, più furbi e fortunati,
fumano fuori dalla fabbrica
abbassando scappamenti.
Per una conclusione
Classificare un libro come Il tempo dei morti non è facile e forse solo dopo esserci tornato più volte si potrà dire qualcosa al proposito. Il mio percorso, peraltro, è stato testuale e probabilmente parziale, ma nel concluderlo è aumentata in me la convinzione che un testo del genere, può trovare nel teatro il suo felice punto di caduta. Se il Droghiere è il personaggio chiave della prima parte del testo, il Coro dei morti ha svolto un ruolo determinante nel giungere a tale conclusione perché non si tratta solo di un omaggio alla radice greca della nostra cultura, come avevo pensato a una prima lettura. Prima di tutto la sua collocazione centrale nel testo: è la settima sezione su quattordici e segna il passaggio da un prima a un dopo. La metrica è solenne, oscilla fra il blank verse della poesia inglese e l’endecasillabo, ma la particolare disposizione del testo conferisce al medesimo una sonorità molto forte, a volte aspra, che invoglia anche il lettore solitario a una recitazione a voce alta. La particolare compattezza del testo, si rovescia però nel suo opposto perché, facendoli parlare a turno e affidando a ciascuno una quartina diversa, il coro si disgrega in una molteplicità di voci che parlano individualmente, rompendo così la tradizione che affida al Coro una verità sovra determinata. Nel loro parlare insieme e disgiunti chiedono ancora una volta al lettore o allo spettatore di cooperare. Le sintesi non possono che essere tante e diverse, prestandosi anche a messe in scena per nulla tradizionali, dove la musica e persino la danza moderna possono svolgere un ruolo decisivo insieme a una parola che propone, nel corso dell’intera opera, un’alternanza di stili – da quello più alto, al basso colloquiale, al medio – che si prestano a loro volta a una polifonia di soluzioni.
