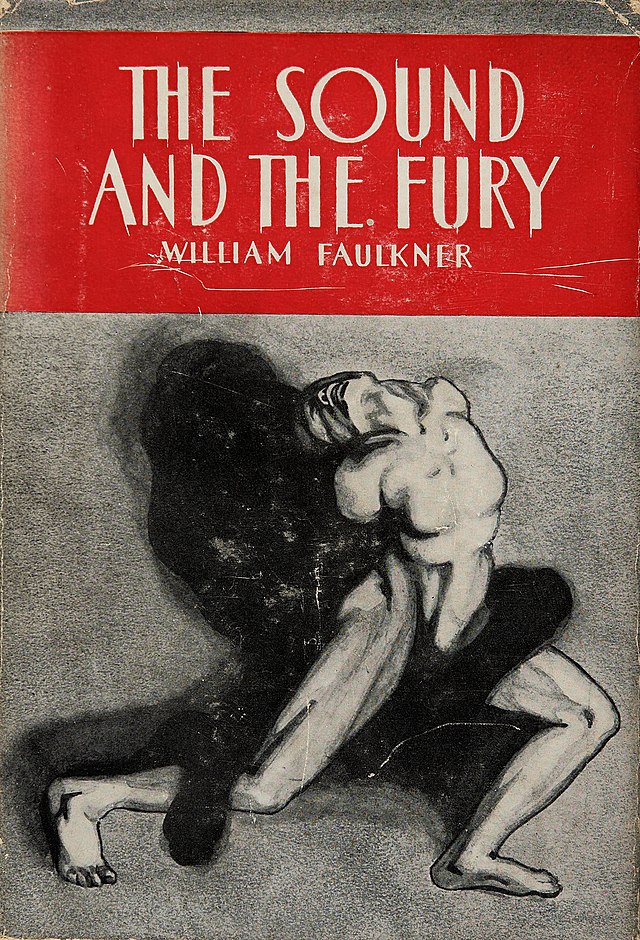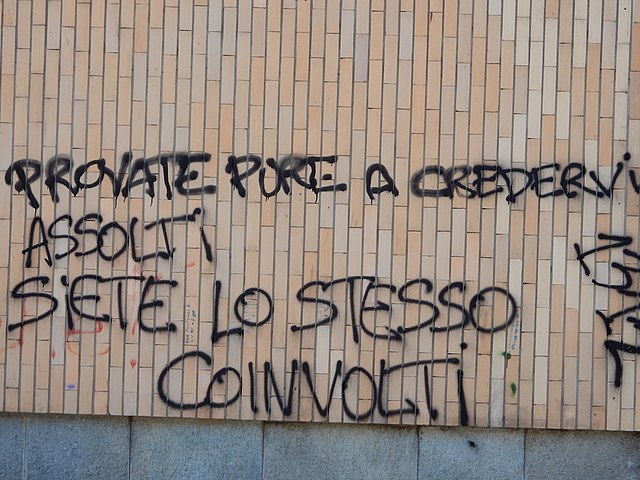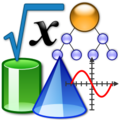PROMETEO FRA MITO E STORIA

Nel suo contesto mitologico Prometeo è una narrazione molto arcaica, appena successiva a quelle sulle origini del mondo. Figlio del Titano Giapeto e dell’Oceanina Climene, è facile notare come i genitori siano due forze della natura incontrollabili. Egli stesso viene rappresentato come un Titano, ma il personaggio appare ben più complesso perché il suo nome significa – nonostante che ciò sia probabilmente dovuto alla cattiva interpretazione di un termine, come sostiene Graves –1 colui che pensa prima di agire. Questo denota progettualità, un’attitudine che non appare consona a un Titano e che, falsa o meno che sia la sua origine, si manifesta però ampiamente nei suoi comportamenti. Tuttavia, come spesso accade con i miti, essi si ricordano solo per alcuni particolari che hanno colpito l’immaginazione, ma che rischiano anche di ridurre la portata dei personaggi e delle narrazioni. Prometeo, nella vulgata che tutti conoscono, è colui che ha rubato il fuoco agli dei per darlo agli uomini e per questo fu punito da Zeus. La storia è meno lineare, proprio a cominciare dalla sua relazione con Zeus; per questa ragione, in nota, riporto la narrazione intera del mito stesso con l’indicazione di tutte le fonti consultate al proposito.2 Prometeo è un rivoluzionario e questo spiega l’attrazione di Marx per il personaggio, ma anche tale definizione gli va stretta; oppure, dipende dall’estensione da attribuire al termine rivoluzionario. Egli sa tenere testa al potere supremo di Zeus, cerca pure di rovesciarlo, ma sa accettare anche il compromesso. Prometeo, specialmente in alcuni momenti, è la politica al livello massimo della sua nobiltà, ma il suo scontro con Zeus si conclude con un sostanziale pareggio: egli viene liberato, ma la vicenda non si conclude con il rovesciamento rivoluzionario delle gerarchie olimpiche e questo lascia a noi umani il compito di scegliere fra opzioni diverse rispetto alla questione del potere, che è un’altra delle problematiche che il mito solleva. Prometeo, dunque, non è solo la tecnologia, anche se questa è stata la valenza dominante e il modo in cui è stato recepito nella modernità; con il rischio però di considerarla tendenzialmente buona in sé o almeno neutra e neutrale. Rimane però il fatto che rubare il fuoco per darlo agli umani è prima di tutto un atto politico d’insubordinazione.
Ecco come Marx si occupa di lui nella sua tesi di laurea:
La confessione di Prometeo: (“francamente, io odio tutti gli dèi”) è la sua propria confessione, la sentenza sua propria contro tutte le divinità celesti e terrestri che non riconoscono come suprema divinità l’autocoscienza umana. Nessuno può starle a fianco. Alle tristi lepri marzoline, che gioiscono della apparentemente peggiorata condizione civile della filosofia, essa replica quanto Prometeo replica al servo degli dei Ermete:(“io, t’assicuro, non cambierei la mia misera sorte con la tua servitù. Molto meglio lo star qui ligio a questa rupe io stimo, che fedele messaggero esser di Giove”)3
Il modo in cui ne scrive parla da solo: Marx, coglie la determinazione rivoluzionaria di Prometeo, ignora il furto del fuoco e valorizza la sprezzatura nei confronti della divinità suprema e il valore civile della filosofia, che è prerogativa degli umani. Questo aspetto del mito verrà reiterato nei momenti in cui Prometeo si prenderà gioco di Zeus. Marx sembra dunque accogliere il mito, in primo luogo, per rivendicare la libertà dal vincolo religioso. La narrazione del mito, tuttavia, dice anche altro. Prometeo non riesce a rovesciare il potere supremo di Zeus, ma tutto quello che ha voluto fare per il genere umano è stato compiuto e i doni sono il fuoco, l’architettura e la lavorazione dei metalli e dunque non solo la tecnologia ma anche le scienze e in uno spettro molto ampio: l’architettura confina con l’arte. Tuttavia, a Marx sembra sfuggire la parte finale del mito e cioè l’assunzione di Prometeo fra gli immortali, atto che crea una connessione del tutto imprevedibile ma assai vistosa fra divinità e tecnologia: una conseguenza assai densa di futuro infausto per noi. Il riferimento a Prometeo manterrà nello sviluppo dell’opera marxiana, una forte dose di ambivalenza. La convinzione che lo sviluppo delle forze produttive avrebbe portato di per sé alla rottura dei rapporti di produzione si pone in termini deterministi e prometeici, mentre nel discorso sul general intellect, se lo s’intende dal punto di vista politico e cioè come telos rivolto all’autogestione da parte dei produttori e della società nel suo insieme (l’idea di una umanità socializzata evocata nella decima tesi su Feuerbach), il determinismo scompare, oppure è fortemente limitato e l’esaltazione della potenza lascia spazio invece alla cooperazione. Lasciamo a Marx le sue oscillazioni e domandiamoci: possiamo avere noi il medesimo atteggiamento di fronte ai disastri naturali e sociali causati dal sistema capitalistico, che vediamo ogni giorno? Non possiamo più e questo implica la rinuncia a qualsiasi forme di prometeismo intesa come lo è stata in passato, anche nell’esperienza storica del socialismo reale.
In che modo però Prometeo come mito e personaggio è stato accolto dalla cultura occidentale? In nota riassumo rapidamente i diversi modi in cui la sua azione è stata considerata, mentre prenderò in considerazione per esteso soltanto il Prometeo di Goethe, con una precisazione: la sola traduzione in italiano che io abbia trovato è quella di Baioni del 1967. 4 Sarebbe auspicabile che qualcun altro lo faccia. Il testo cui faccio riferimento è dunque quello facilmente reperibile anche in rete, spesso con l’originale in tedesco.
Copri il tuo cielo, Giove,
col vapor delle nubi!
E la tua forza esercita,
come il fanciullo che svetta i cardi,
sulle querce e sui monti!
Ché nulla puoi tu
contro la mia terra, contro questa capanna,
che non costruisti,
contro il mio focolare,
per la cui fiamma tu
mi porti invidia.
Io non conosco al mondo
nulla di più meschino di voi, o dèi.
Miseramente nutrite
d’oboli e preci
la vostra maestà
ed a stento vivreste,
se bimbi e mendichi
non fossero pieni
di stolta speranza.
Quando ero fanciullo
e mi sentivo perduto,
volgevo al sole gli occhi smarriti,
quasi vi fosse lassù
un orecchio che udisse il mio pianto,
un cuore come il mio
che avesse pietà dell’oppresso
Chi mi aiutò
contro la tracotanza dei Titani?
Chi mi salvò da morte,
da schiavitù?
Non hai tutto compiuto tu,
sacro ardente cuore?
E giovane e buono, ingannato,
il tuo fervore di gratitudine
rivolgevi a colui che dormiva lassù?
Io renderti onore? E perché?
Hai mai lenito i dolori di me ch’ero afflitto?
Hai mai calmato le lacrime di me ch’ero in angoscia?
Non mi fecero uomo
il tempo onnipotente
e l’eterno destino,
i miei e i tuoi padroni?
Credevi tu forse
che avrei odiato la vita,
che sarei fuggito nei deserti
perché non tutti i sogni
fiorirono della mia infanzia?
Io sto qui e creo uomini
a mia immagine e somiglianza,
una stirpe simile a me,
fatta per soffrire e per piangere,
per godere e gioire
e non curarsi di te,
come me.4
Il testo di Goethe è a mio avviso equamente distante da tutte le interpretazioni più canoniche del mito, citate nella nota precedente. Non so dire se i suoi versi in tedesco siano della stessa efficacia e bellezza di altre sue liriche e forse l’inesistenza di traduzioni recenti potrebbe far pensare che non si tratti dell’opera poetica più riuscita di Goethe; tuttavia, in questa mia riflessione vi è una oggettiva prevalenza del significato simbolico da attribuire alla sua figura mitologica e il testo di Goethe mi sembra a questo proposito sorprendente e anomalo. La prima scelta sorprendente è di far parlare Prometeo, perché in fondo ciò che colpisce nelle altre rappresentazioni è proprio il suo silenzio. Anche nei ritratti in cui è rappresentato dolorosamente angariato dall’aquila, Prometeo sembra quasi assente. Eroe o demone, oppure angelo ribelle a seconda delle interpretazioni, nonostante sia sempre presente in scena, tutto quello che possiamo dedurre del suo pensiero, lo si evince dai gesti e dai comportamenti: anche quando usa la parola – i suoi avvertimenti a Epimeteo per esempio – questa viene riportata da altri. Il tono della voce, nel testo di Goethe, oscilla fra indignazione e dolenza, dolore e invettiva. Il Prometeo di Goethe rifiuterebbe di essere accolto fra gli dei e infatti non vi è alcun cenno a questo nel testo. Vero uomo ma non vero dio, il Prometeo goethiano si distanzia dal tema eroico senza per questo diventare un antesignano degli anti eroi di cui sarà piena la letteratura novecentesca. Rimane un’ultima considerazione e cioè se l’invettiva che Goethe gli fa pronunciare sia nei confronti degli dei olimpici ma risparmi il dio cristiano. Il richiamo all’indifferenza rispetto alle sofferenze umane mi sembra del tutto riferibile anche a quest’ultimo. Goethe però non anticipa la morte di dio nietzschiana, mi sembra piuttosto che tutto il testo sia la dolente constatazione che lo spazio di dio è ormai uno spazio vuoto, che l’umanità se vuole salvarsi devo farlo da se stessa, senza bestemmiare la vita. Mi sembrano decisivi a questo proposito i versi finali che riporto di nuovo qui di seguito:
Credevi tu forse
che avrei odiato la vita,
che sarei fuggito nei deserti
perché non tutti i sogni
fiorirono della mia infanzia?
Io sto qui e creo uomini
a mia immagine e somiglianza,
una stirpe simile a me,
fatta per soffrire e per piangere,
per godere e gioire
e non curarsi di te,
come me.

1 Robert Graves, Miti greci, alla voce Prometeo e Atlante: disponibile anche in rete in formato pdf.
2 Mi sono prioritariamente rifatto all’autorevolezza di Robert Graves, ma anche ad altre fonti, riportate nella Treccani, oppure da Graves medesimo nelle sue note. Come tutte le scelte è discutibile, la motivazione che mi spinge a ritenere la ricerca di Graves fondamentale, è il suo rigore da mitografo nel riportare tutte le versioni conosciute di un mito, con pochi ed essenziali commenti, che lasciano a chi legge le interpretazioni possibili e le ulteriori riflessioni. Le altre fonti principali, peraltro sempre citate anche da Graves, sono indicate di volta in volta. I miei commenti e note redazionali sono in tondo.
Da un’unione tra il Mare e i suoi Fiumi nacquero le Nereidi. Non esistevano però uomini mortali; finché Prometeo, figlio di Giapeto, con il consenso della dea Atena, non li formò a immagine e somiglianza degli dei impastando la creta con l’acqua del Panopeo, fiume della Focide; Atena soffiò in essi la vita. Prometeo, il creatore del genere umano, che taluni includono nel numero dei Titani, era figlio della Ninfa Climene e del Titano Eurimedonte, oppure di Climene e Giapeto; suoi fratelli erano Epimeteo, Atlante e Menezio. II Gigante Atlante, il maggiore dei fratelli conosceva tutto quanto si cela negli abissi del mare; il suo regno si estendeva lungo una zona costiera scoscesa, più vasta che l’Asia e l’Africa messe assieme. La terra di Atlante giace al di là delle Colonne di Eracle e una catena di isole feraci la separa da un continente più lontano, che non è unito ai nostri …
Prometeo non agisce senza il consenso Atena anche se l’idea di creare il genere umano è sua, secondo questa versione; il particolare è assai interessante, come vedremo meglio nel prosieguo. Il racconto che segue, cioè la leggenda di Atlante, peraltro ben nota perché riferita anche da Erodoto, riguarda marginalmente i temi qui trattati, se non per un particolare che viene evidenziato alla fine, cioè quando si compie la sconfitta dei Titani ribelli. Così prosegue Graves:
Prometeo, che era più saggio di Atlante, previde come sarebbe finita la rivolta dei Titani e preferì dunque schierarsi dalla parte di Zeus, inducendo Epimeteo a imitare il suo esempio. Prometeo era, in verità, il più intelligente della sua razza; aveva assistito alla nascita di Atena dalla testa di Zeus e la dea stessa gli insegnò l’architettura, l’astronomia, la matematica, la medicina, l’arte di lavorare i metalli, l’arte della navigazione e altre utilissime, che egli poi a sua volta insegnò ai mortali.
Da questo passaggio si può capire come la capacità politica sia in Prometeo particolarmente acuta, in ogni momento della sua vicenda e sufficiente per dire che il pensare prima di agire sia effettivamente una costante del suo carattere, anche nei momenti in cui sembrerà il contrario. Non è un rivoluzionario astratto, sa destreggiarsi e anche creare il necessario consenso intorno a sé, riconosce l’importanza dei rapporti di forza, ma questo non gli impedisce di giocare le sue carte, a volte anche con ironia, come quando inganna Zeus, usando un trucco persino banale. Da questo momento in poi la narrazione diviene però meno lineare a causa delle interpolazioni che Graves spiegherà più avanti.
Ma Zeus, che aveva deciso di distruggere l’intero genere umano ed era stato distolto da tale proposito soltanto dall’intervento di Prometeo, s’irritò nel vedere gli uomini divenire sempre più esperti e potenti.
Anche in questo caso, egli esercita l’arte della mediazione piuttosto che quella del rovesciamento rivoluzionario.
Un giorno, nella piazza di Sicione, si accese una discussione a proposito delle parti di un toro sacrificato che si dovevano offrire agli dei, e delle parti che gli uomini potevano riservare per sé. Prometeo fu invitato a fare da arbitro. Egli allora scucì e smembrò il toro e ricucì la sua pelle in modo da formarne due grandi sacche, che riempì con le varie parti dell’animale. Una sacca conteneva tutta la carne, ma ben nascosta sotto lo stomaco, che è il boccone meno appetitoso, e l’altra conteneva le ossa, nascoste sotto un bello strato di grasso. Quando le presentò a Zeus perché scegliesse l’una o l’altra. Zeus si lasciò trarre in inganno e scelse la sacca con il grasso e le ossa (che da quel giorno rimasero la porzione degli dei) ma punì Prometeo, che rideva di soppiatto, privando gli uomini del fuoco. «Che mangino la loro carne cruda!» gridò. Prometeo si recò subito da Atena e ottenne che essa lo facesse entrare di nascosto nell’Olimpo. Appena giunto, accese una torcia al divampante carro del Sole e ne staccò una brace ardente, che pose poi entro il cavo di un gigantesco gambo di finocchio. Spenta la torcia, sgattaiolò via senza che alcuno lo vedesse e ridonò il fuoco al genere umano .
Questo passaggio è molto importante e la burla va sottratta alla sua apparente banalità, anche perché altre versioni presentano qualche contraddizione rispetto a questa e sembra che ci sia in questa ricostruzione la sovrapposizione di vicende diverse, come Graves peraltro avverte. L’intento di Prometeo è di dimostrare che gli dei, a cominciare da Zeus, sono in realtà le paure degli esseri umani e questo è l’aspetto di Prometeo che suscitava l’entusiasmo di Marx. Tuttavia, un altro particolare importanza è l’alleanza di fatto che nei momenti più decisivi, Prometeo trova in Atena. Principio femminile che si contrappone a Zeus? Per niente poiché Atena è nata dalla testa del padre e se mai rappresenta l’ambivalenza del maschile di cui Prometo è abile a servirsi ogni volta che lo deve fare. A questo punto, però, la storia s’ingarbuglia ancora di più:
Zeus giurò di vendicarsi. Ordinò a Efesto di fabbricare una donna di creta, ai quattro venti di soffiare in essa la vita, e a tutte le dee dell’Olimpo di adornarla. Codesta donna, Pandora, fu la più bella del mondo e Zeus la mandò in dono a Epimeteo, scortata da Ermes. Ma Epimeteo, che era stato ammonito da suo fratello di non accettare doni da Zeus, cortesemente rifiutò. Sempre più infuriato. Zeus fece incatenare Prometeo, nudo, a una vetta del Caucaso, dove un avido avvoltoio gli divorava il fegato tutto il giorno, un anno dopo l’altro; e il suo tormento non aveva fine, poiché ogni notte (mentre soffriva crudelmente per i morsi del freddo) il fegato gli ricresceva.
Zeus non affronta Prometeo direttamente e questo significa che lo teme. Il tentativo di sconfiggerlo tramite Epimeteo, però fallisce e questo particolare è più importante di quella parte della narrazione che riguarda Pandora, anche perché la connessione fra i due miti appare forzata e lo vedremo meglio subito dopo. Non è per nulla evidente perché proprio Pandora avrebbe dovuto ingannare i due fratelli. Il mito di quest’ultima andrà preso in considerazione in sé per quello che significa da un punto di vista della codificazione patriarcale, ma rispetto al nostro argomento sia l’atteggiamento prudente di Zeus, sia l’ammonizione di Prometeo a Epimeteo, sono ben più decisive. Così prosegue Graves:
Zeus, non volendo ammettere di aver dato sfogo al suo desiderio di vendetta, cercò di giustificare la propria crudeltà facendo circolare una falsa voce: e cioè che Atena aveva invitato Prometeo sull’Olimpo per un segreto convegno amoroso. Epimeteo, angosciato per la sorte di suo fratello, si affrettò a sposare Pandora, che per volontà di Zeus era stupida, malvagia e pigra quanto bella. Subito essa aprì il vaso che Prometeo aveva affidato a Epimeteo raccomandandogli di tenerlo chiuso, e nel quale si trovavano tutte le Pene che possono affliggere l’umanità: la Vecchiaia, la Fatica, la Malattia, la Pazzia, il Vizio e la Passione. Subito esse volarono via a stormo e attaccarono i mortali.
Ancor più di prima la connessione fra i due miti non appare affatto necessaria: che nesso c’è fra la punizione inflitta a Prometeo e la decisione di Epimeteo di sposare Pandora? D’accordo, Epimeteo è un avventato e infatti il suo nome significa colui che pensa dopo avere agito, ma ci sono troppe contraddizioni e persino sull’apertura del vaso esistono due versioni. In una è proprio lui – Epimeteo – ad aprirlo e non Pandora. Insomma, un guazzabuglio, rispetto al quale tuttavia, ancora una volta Prometeo ne esce bene: è lui ad avvisare il fratello di custodire il vaso senza aprirlo. Le incongruenze nascondono sempre qualcosa di grosso che c’è eccome ed è proprio Graves ad affermarlo nella sua nota numero 8. La leggenda Prometeo, Epimeteo e Pandora, narrata da Esiodo, non è il mito originale ma una favola antifemminista inventata da Esiodo stesso, benché si ispiri alla leggenda di Demofoonte e Fillide. Il vaso di Pandora, in origine, conteneva anime alate. La rivolta dei giganti, di cui il mito di Prometeo è la parte successiva, è narrata essenzialmente da Apollodoro, Pausania e Diodoro Siculo. Euripide scrisse una tragedia dal titolo i Ciclopi. Altre fonti si ritrovano nell’Odissea, Eschilo scrisse una tragedia sul tema ma è andata perduta.
Fra le fonti autentiche citate Esiodo non c’è proprio e, in effetti, egli è poi il primo di una lunga tradizione misogina. Probabilmente il mito di Pandora andrà visto nella sua autonomia rispetto a quello di Prometeo, cercando se mai successivamente intrecci possibili. Il finale di questa parte della narrazione, tuttavia, merita attenzione perché in realtà i finali sono due e la differenza non è da poco. Vediamoli entrambi di seguito.
Ma la fallace Speranza, che Prometeo aveva pure chiuso nel vaso, li ingannò con le sue bugie ed evitò così che tutti commettessero suicidio. (tutti si riferisce al genere umano ndr.)
Solo la speranza, rimasta nel vaso tardivamente rinchiuso, da quel giorno sostenne gli uomini anche nei momenti di maggior scoraggiamento.
La prima delle due versioni attribuisce a una scelta di Prometeo l’avere inserito anche la speranza nel vaso, ma subito dopo ecco la diffamazione nei suoi confronti: seppure in modo obliquo. La speranza sarebbe solo un inganno per il genere umano, ma è lui Prometeo ad averla messa nel vaso e quindi ad averli ingannati. Ora che sappiamo che tutta la vicenda di Pandora va rivista in altro modo e contesto, rimane il tentativo di usarla nel finale per minimizzare l’opera di Prometeo. La seconda versione più neutra, rivaluta la speranza assegnandole un valore positivo. Con la chiusura di questa parte assai accidentata, torniamo alla narrazione principale. Avevamo lasciato Prometeo nel momento in cui, grazie alla complicità di Atena, ridona il fuoco all’umanità e sempre grazie a lei aveva acquisito anche altre abilità, dall’architettura alla lavorazione dei metalli, che aveva di nuovo donate agli umani. Così prosegue la narrazione principale:
Alla fine, non vi erano più qualità da assegnare al genere umano, ma Prometeo rimediò subito rubando ad Atena uno scrigno in cui erano riposte l’intelligenza e la memoria che donò agli umani. Zeus in quel momento aveva deciso di distruggerli e non approvava la gentilezza di Prometeo per le sue creature; inoltre considerava i doni del titano troppo pericolosi perché gli uomini in questo modo sarebbero diventati sempre più potenti e capaci.
Questo finale appare più realistico nell’indicare le ragioni per cui Zeus decide di punire Prometeo: gli umani sono diventati troppo potenti, grazie a lui, mentre l’ordine degli dei o del solo Zeus era diverso, lasciare gli umani in una sorta di perenne minorità. La parte finale del mito, Graves la lascia ad altri autori, prima di tutto a Eschilo che racconta nel Prometeo liberato che fu Eracle a trafiggere con una freccia l’aquila che tormentava Prometeo e lo liberò spezzando le catene. Secondo il racconto contenuto nella Biblioteca dello Pseudo Apollodoro, durante un incontro tra Chirone ed Eracle, alcuni centauri attaccarono l’eroe che per difendersi usò frecce avvelenate da cui non si poteva guarire. Chirone venne inavvertitamente graffiato da una delle frecce. Non potendo morire perché immortale, cominciò per lui una sofferenza atroce. Zeus quindi accettò la vita di Chirone che poté finalmente morire in cambio dell’immortalità di Prometeo.
3 La tesi di laurea di Marx è facilmente reperibile in rete, la citazione in oggetto è riportata su diversi siti.
4 La tesi di laurea di Marx è del ’41 e si inserisce in un contesto in cui il dibattito su Prometeo è assai intenso. Tendenzialmente i romantici lo avevano rifiutato, tranne Shelley, la cui interpretazione è vicina a quella di Marx. Leopardi lo considera uno sconfitto, dal momento che si era fidato di una imperfezione: l’uomo stesso. Tuttavia è con la generazione successiva ai romantici che Prometeo comincia ad essere apprezzato come costruttore di civiltà, cui si oppone invece la reazione religiosa che lo vede come Satana, l’Angelo ribelle. Prevale sempre di più la prima ipotesi, anche perché il positivismo ne fa facilmente un proprio eroe. Il ‘900 non apporterà grandi modifiche a questa declinazione del mito se non nel caso della scrittore svizzero Carl Splitter che accentua i caratteri roussoviani del mito, rappresentando Prometeo come il ribelle che risponde soltanto alla propria coscienza e si batte contro le ipocrisie della morale comune. Infine Gide che lo attualizza e lo vede tormentato dalla propria coscienza piuttosto che dall’aquila che gli rode il fegato.
4 Johann Wolfgang Goethe – Prometeo (poema: Prometheus) (trad. it. di Giuliano Baioni, in Goethe, Inni, Einaudi, 1967)