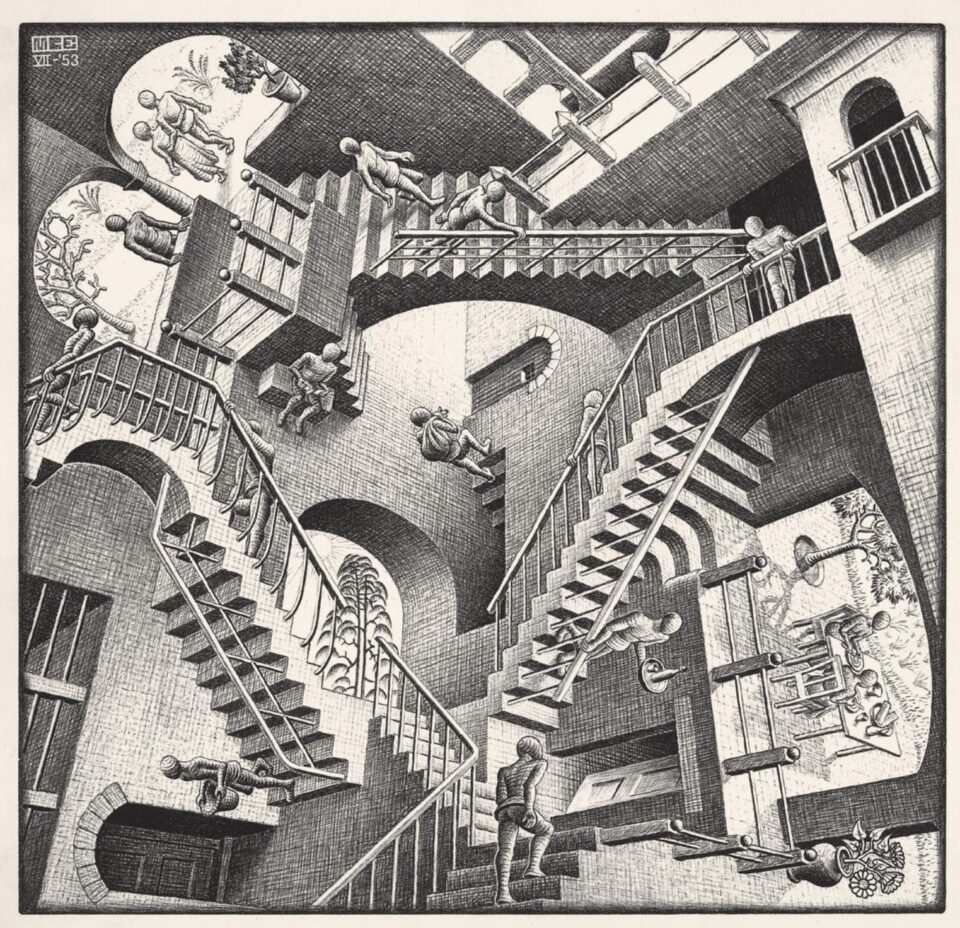MEMORIA E RICORDO

Nel pieno dei processi staliniani degli anni ’30, delle repressioni e internamenti nei Gulag che ne seguirono, alla poetessa Anna Achmatova accadde un giorno di trovarsi in mezzo a una fila di persone che attendevano il proprio turno davanti a una stazione di polizia, dove si erano recate per chiedere notizie dei congiunti e amici arrestati. La fila triste, i volti bassi dei presenti, l’angoscia che regnava su tutto e tutti trasformava il silenzio in qualcosa d’intollerabile, ma al tempo stesso impediva la parola, azzerava qualsiasi discorso. Poi, alzando lo sguardo da terra, una donna anziana la riconobbe e, in un lampo di speranza e sollievo, si rivolse alla poeta dicendole: “Lei può raccontare tutto questo.”
Sappiamo dell’accaduto dalla testimonianza della Achmatova stessa, dunque, superficialmente, si potrebbe dire che la poetessa ha ottemperato a ciò che l’anonima donna le chiedeva; solo superficialmente, però, poiché credo che questo piccolo e tragico episodio, introduca molto bene la differenza che vi è fra ricordo e memoria. Se scomponiamo la scena nelle sue sequenze, prese isolatamente, vediamo una triste fila di persone, sconosciute le une alle altre, forse in parte sospettose le une delle altre e che dunque non si confidano i loro guai. Anna Achmatova è una di loro, è anche lei anonima, ha le stesse apprensioni degli altri, attende silenziosamente il suo turno. Se connettiamo lo spazio scenico con il tempo possiamo collocare sull’asse delle ascisse la fila anonima delle persone che si succedono nello spazio, mentre possiamo porre sull’asse delle ordinate le scansioni del tempo d’attesa, un tempo anch’esso anonimo che fa solo da sfondo neutro alla tragedia che si sta svolgendo e la cui unità di misura sono gli istanti rappresentati dalle persone che entrano una dopo l’altra dentro la stazione di polizia. Nella seconda sequenza, in primissimo piano, abbiamo due sguardi che s’incrociano per caso: idealmente, lo possiamo rappresentare come il punto in cui le due linee degli assi cartesiani s’incrociano. Uno sguardo s’illumina. L’istante rompe la cattiva continuità temporale, istituendo uno spazio differente; dentro questo perimetro spazio temporale la comunicazione diventa possibile.
Nella terza scena, ancora breve, un altro istante rispetto al monotono scorrere del tempo, la donna non ha riconosciuto un’amica di cui si fida e neppure una persona qualsiasi, bensì la poeta Anna Achmatova. La barriera di diffidenza cade di colpo, la richiesta della donna del popolo è perentoria, ma di quale richiesta si tratta esattamente? Cosa viene chiesto alla poeta: di ricordare forse? No, la richiesta è più complessa e per avvicinarsi al senso che essa racchiude bisogna usare un altro verbo da quello comune, perché ricordare suona troppo generico. Anche l’anonima donna poteva ricordare e c’è da credere che lo abbia fatto, che il segno di quella tragica attesa non l’abbia abbandonata per tutta la vita. Evidentemente, però, la popolana, in modo più o meno cosciente, stava chiedendo altro e per questo si rivolgeva alla Achmatova, non in quanto persona anonima che attendeva come lei e come tutti, in preda al suo personale strazio, bensì alla scrittrice, alla poeta.
Il ricordo può essere privato, ma per diventare universale ha bisogno di una forma; la memoria collettiva non è una testimonianza qualunque da aula di tribunale e probabilmente neppure una serie quantitativamente importante di testimonianze singole, anche se la tendenza contemporanea di costruire una storia memoriale grazie alla ricostruzione personale di eventi storici, da parte di persone non direttamente coinvolte in posizioni di responsabilità diretta, sia un fattore importante di cui tenere conto.
Naturalmente da questo episodio si possono trarre molte altre considerazioni: prima fra tutte che nell’Unione Sovietica staliniana degli anni ’30 gli scrittori godevano di uno statuto di credibilità che oggi si può riscontrare soltanto nei paesi Latino Americani, in India, nei paesi Islamici, e in Estremo Oriente; ma non in Europa o negli Stati Uniti. Forse in Russia.
Torniamo alla Achmatova e alla donna che si rivolse a lei. Non sono in grado di dire in che modo la poeta abbia metabolizzato in senso artistico questo episodio e altri simili: non ne conosco così profondamente l’opera tanto da poterlo dire; sono certo, tuttavia, che, se lei lo ha raccontato, il problema se lo è posto e ha tentato pure di risolverlo, forse senza riuscirci, se ha sentito così fortemente il bisogno di restituirlo a noi in una forma che non è quella che si chiede a un racconto che abbia lo statuto riconoscibile di un’opera artistica, ma quello di una semplice testimonianza.
Alexander Solgenitsin, invece, la tragedia dei Gulag staliniani ha cercato di raccontarla e i suoi romanzi, discutibili anch’essi, talvolta, nella loro resa estetica, sono importanti e appartengono a pieno titolo alla grande letteratura; tanto che la parola Gulag è diventata un simbolo e un’icona del campo di concentramento, affiancando nell´immaginario collettivo il termine precedente, Lager, che godeva, fino agli anni ‘80 del secolo scorso, una predominanza pressoché totale.
Gli scrittori veri inventano sempre parole nuove, che diventano successivamente di tutti. Fu così anche con Primo Levi, la cui testimonianza sui campi di sterminio nazisti è tuttora insuperata, anche perché letterariamente risolta. I suoi romanzi, quale per esempio, Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati, oppure Arcipelago Gulag, Un giornata di Invan Denissovic, del romanziere russo, hanno contribuito a creare una memoria collettiva che è diventata nell’Europa del secondo dopoguerra, senso comune largamente condiviso. Mancano all’appello gli Stati Uniti.
La memoria dei vincitori
Non esiste una narrativa statunitense che abbia elaborato le tragedie della Seconda Guerra Mondiale e ciò che più l’ha caratterizzata: il lager come immagine sintetica dell’accaduto. Ci sono testimonianze cinematografiche (molte di pregio), che insistono sulla ragione dei vincitori, sulla superiorità delle democrazie occidentali, oppure che indulgono nel culto dell’eroismo e fanno del conflitto bellico lo scenario ideale per film di grande impatto spettacolare: valga per tutti l’esempio de Il giorno più lungo. Oppure propagandano l’immagine dell’americano liberatore. I grandi film sulla Shoah, però, sono tutti europei fino a tempi molto recenti: l’unico statunitense, addirittura hollywoodiano, è Shindler’s list di Spielberg. Se si vuole ricordare un grande romanzo di guerra statunitense bisogna tornare a Addio alle armi di Hemingway e, per il cinema, arrivare fino alla guerra del Vietnam. Tutta l’epopea del West e le allegorie di Cormac McCarthy affrontano il tema bellico e quello della violenza congenita della società americana, ma lo fanno con modalità che prescindono da questo o dall’altro evento storico; infine Scorsese, in Gangs of New York ha affrontato in modo hollywoodiano (sebbene il film sia stato girato a Cinecittà), il nucleo psicologico e sociale dell’imperialismo americano e cioè la necessità del nemico esterno per impedire la dissoluzione della società americana dall’interno.
Le ragioni che possono spiegare questo atteggiamento sostanzialmente reticente, sono tante: quella apparentemente più semplice è che gli Usa, mai invasi prima dell´11 settembre, da un evento bellico che pioveva davvero sulle loro teste, hanno una percezione molto rarefatta dello sconvolgimento che una guerra provoca nella società civile. Un’altra, fallace, sta nel pensare che il lager fu un problema eminentemente europeo, dimenticando che due milioni di nippo statunitensi furono internati in campi di concentramento negli Usa dopo l’attacco alla base di Pearl Harbour e che, alla fine del conflitto, di centinaia di migliaia di loro non si ebbe più notizia. Una terza potrebbe indicare un riflesso di altro genere, una disattenzione dovuta al fatto che, in fondo, la tragedia della persecuzione ebraica è una storia tutta europea. Penso, tuttavia, che ci sia una ragione preponderante, addirittura enorme e che, se mai, utilizza tutte le altre ragioni al fine di perpetuare nel tempo una gigantesca rimozione: il lancio dell’atomica su Hiroshima e Nakasaki e il trattamento differenziato che la cultura occidentale tutta (anche europea dunque) assegna alle due città giapponesi rispetto ad Auschwitz, luogo qui inteso in senso riassuntivo e simbolico dell’intera tragedia della Shoah. [1]
Gli Usa e la Shoah
Se dalla narrativa si passa alla storiografia, la rimozione è altrettanto pesante. Per comprenderlo occorre fare un passo indietro. L’attenzione statunitense nei confronti della Shoah è recente e direttamente proporzionale alla difesa dello stato di Israele, mentre è stata del tutto ignorata nei decenni successivi la Seconda Guerra Mondiale. Durante il maccartismo, per esempio, ogni accenno alla persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, era visto con sospetto negli Usa, in quanto l’intelligentia ebraica aveva forti simpatie comuniste e socialiste e nella mentalità paranoica di quegli anni bastava essere semplicemente critici dell’American way of life per essere perseguitati: la vicenda surreale di Chaplin e quella ben più tragica dei coniugi Rosenberg lo sta a testimoniare. Quando fu pubblicato il libro di Annah Arendt, oggi tanto esaltato, e cioè La banalità del male (siamo a metà degli anni ’60, dopo il processo al criminale nazista Eichman), la diffidenza era così forte che ne fu sconsigliata la pubblicazione negli Usa. Tutto questo, nel silenzio totale da parte della comunità ebraica di quel paese e non solo.
Se poi si passa al bombardamento atomico delle città giapponesi nonché alla criminale rappresaglia seguita alla battaglia di Okinawa, che portò al bombardamento di Tokio durante il quale i morti furono persino superiori per numero a quelli immediatamente colpiti dalle bombe nucleari, la rimozione è totale.
Quanto ai campi di internamento statunitensi, il primo film degno di nota sulla tragedia dei nippo statunitensi è della metà degli anni ’60, uno più recente con Richard Geere, affronta di nuovo il tema in modo assai edulcorato, ma non esiste nulla di paragonabile rispetto all’attenzione dedicata ad altri eventi. La storiografia ufficiale giustifica l’atomica, non vi è traccia di revisionismo o almeno di resipiscenza critica per un atto che, sotto ogni aspetto, si configura come un crimine contro l’umanità, neppure giustificato da esigenze belliche, dal momento che il Giappone era allo stremo e non poteva minimamente minacciare le potenze alleate. La logica politica che guidò quella decisione scellerata, lo sanno tutti anche non si può dire, fu quella della vendetta e della rappresaglia da un lato (una sorta di attualizzazione del detto romano guai ai vinti) e costituiva un avvertimento all’Unione Sovietica dall’altro. Finché non ci sarà anche solo simbolicamente, una Norimberga per Hiroshima e Nakasaki, la memoria dell’occidente sarà basata solo su un peloso senso di colpa nei confronti della Shoah e nella rimozione di un altro crimine spaventoso.

L’uso politico della memoria storica appare qui talmente vistoso da risultare grottesco. Se la condanna dei Rosenberg fosse accaduta oggi si può dare per certo che essa sarebbe stata rubricata come una vicenda di antisemitismo, tanto frequente e abusata tale accusa nei conforti di tutti coloro che semplicemente criticano la politica di discriminazione razziale e apartheid da parte dello stato di Israele. D’altro canto, tale atteggiamento corrisponde a una filosofia della storia che si è fatta strada nel corso del ‘900 e che è diventato una sorta di paradigma dopo la tragedia della seconda Guerra Mondiale e cioè la considerazione che lo sconfitto, il vinto, sia per definizione anche un reprobo, concetto che appare all’orizzonte solo nel secolo scorso: dall’avversario al nemico, al Male. Tutto ciò con effetti grotteschi: non appena appare qualcuno all’orizzonte che disturba la politica americana esso diviene immediatamente il nuovo Hitler!
Che rapporto ha, invece, l’Europa con la storia e la memoria della Seconda Guerra Mondiale? Apparentemente la risposta è molto semplice: sono talmente numerose le celebrazioni, le manifestazioni, le reiterate iniziative istituzionali con cui viene ossessivamente ricordata la Shoah, da sembrare, la mia, una domanda inutile. Non lo credo affatto, invece, perché anche nel continente europeo, se si gratta sotto l’apparenza, si scoprono molte crepe in quella che sembra l’icona ben costruita. Prima di tutto va ricordato che anche in Europa, per ragioni diverse rispetto agli Stati Uniti, la memoria collettiva della Shoah è più recente di quanto non si creda. Subito dopo il conflitto gli stessi internati nei campi di concentramento non parlavano volentieri della loro esperienza e lo si può comprendere; ci vuole del tempo per metabolizzare una simile tragedia. Le stesse opere letterarie citate in precedenza non nascono nell’immediatezza, ma successivamente. Lo stesso si può dire per la Germania, dove il processo di elaborazione del passato è stato fatto in una forma che è sconosciuta in altri paesi (per esempio in Italia) che portano le stesse responsabilità politiche, almeno per quanto riguarda i crimini di guerra in altri paesi: mi riferisco all’uso dei gas nelle guerre coloniali del fascismo e alle efferatezze compiute dall’esercito italiano durante l’occupazione della Croazia e del Montenegro.
La memoria come costruzione
La memoria può essere soltanto costruzione e ricostruzione insieme. Tale processo può essere compiuto sia dagli storici, sia, almeno in teoria, dagli scrittori.
Nel Giulio Cesare di Shakespeare c’e’ un passaggio che ha fatto saltare il buon Freud sulla sedia e forse fu uno dei dati che lo spinse a scrivere (secondo me con un ottimismo eccessivo, se guardiamo a quanto avvenuto successivamente), che gli scrittori e i poeti avevano inventato la psicanalisi prima di lui.
Nella tragedia del grande bardo si accenna al fatto che Cesare, uscendo di casa il mattino del fatidico 15 marzo, inciampi nella soglia. Naturalmente sul piano del dato storico, tutto questo non esiste: nessuna testimonianza, da Sallustio a Tacito ad altri storici romani ci autorizzano a pensare a qualcosa del genere. Sappiamo che secondo la cultura pagana del tempo Cesare aveva avuto le sue premonizioni; sappiamo pure che alcune di esse erano molte precise nel delineare la congiura, ma che abbia inciampato nel gradino uscendo di casa è una pura invenzione, ma la circostanza è talmente vera sul piano psicologico che si può finire per crederla vera anche sul piano storico.
La memoria può essere solo una costruzione che si avvale di apporti diversi e appartenenti a campi diversi che spaziano dall’arte all’antropologia ed è dal loro intreccio che si può arrivare a una affresco degno di nota, mentre una dossologia di eventi che, per il solo fatto di essere posti in una scansione lineare di tempo che procede dal più piccolo al più grande pretendono perciò stesso di essere significativi, finiscono per avere poco senso, come non ne aveva la fila di persone dalla testa bassa in attesa di entrare nella stazione di polizia, con cui questa riflessione è iniziata. Ciò che distingue quella fila da una qualsiasi coda in attesa di entrare in un ufficio postale, oppure di salire su un autobus, è l’istante in cui lo sguardo della popolana rompe la cattiva sequenza spazio-temporale e successivamente, ciò che da quello sguardo e da quella rottura poteva nascerne. La testimonianza di Achmatova, non ci ridà il senso compiuto, neppure il suo ricordo diviene memoria, ma la sua testimonianza illumina la differenze che noi possiamo leggere in altri: oltre ai ricordati già Levi e Solgenitsin, anche altri che ciascuno può inserire in un elenco personale di scrittori che conosce.
[1] L’espressione trattamento differenziato non è mia. La prendo in prestito dal filosofo Costanzo Preve che l’ha usata nel suo libro dedicato alla guerra della Nato alla Serbia .