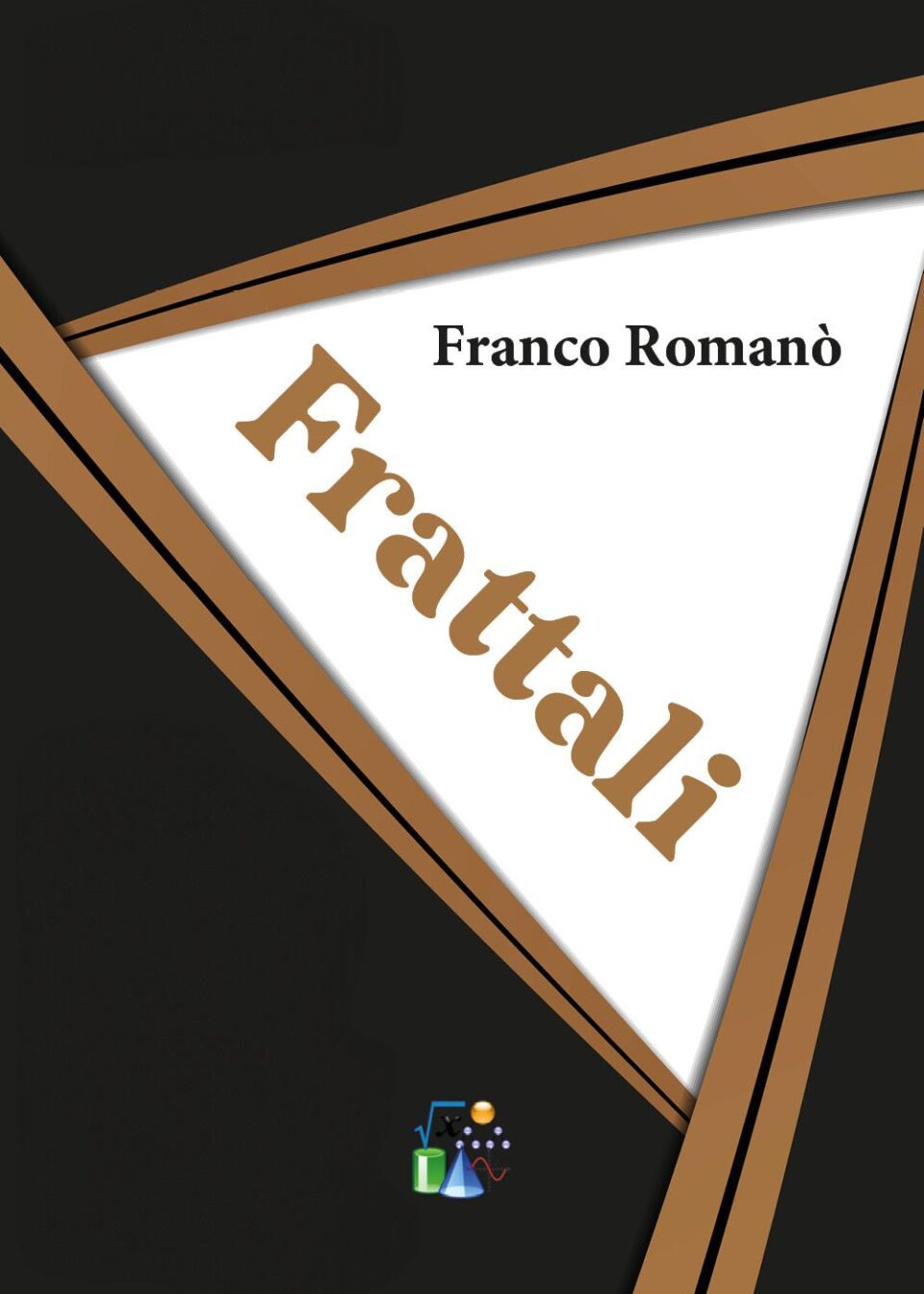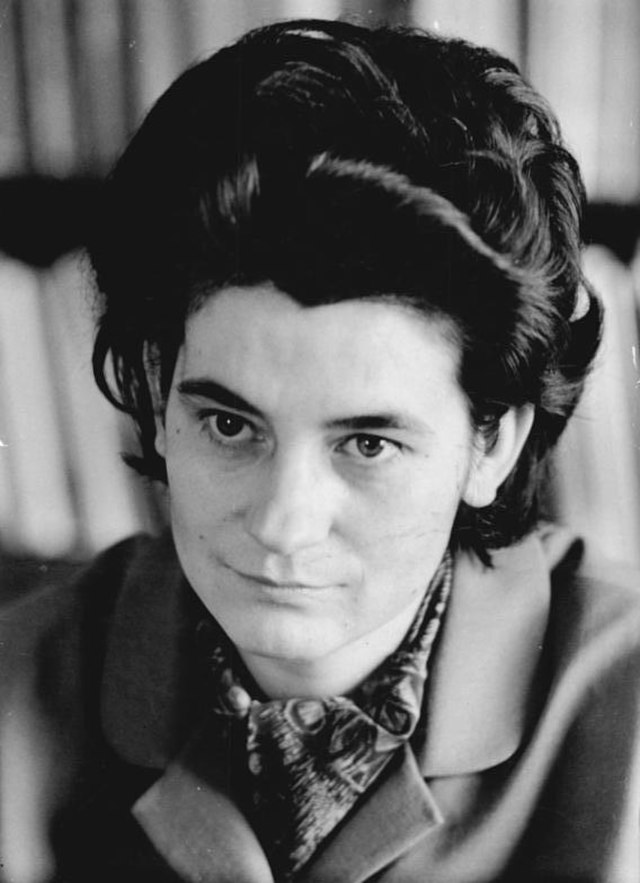NARRAZIONI FRA MEMORIA E STORIA

Premessa
Il secondo libro di questo ciclo dedicato alle scritture narrative che si collocano fra memoria collettiva e storia, porta a una vicenda tipicamente italiana, l’emigrazione in cerca di lavoro: un problema storico che data dall’Unità d’Italia e che in forme diverse si ripropone a ogni generazione. La novità è che si tratta di un’emigrazione in Francia, precisamente in Lorena, una regione di confine cui sono legati molti ricordi – spesso tristi – che hanno segnato la storia europea: la miniera e il carbone sono sempre i protagonisti, ma l’emigrazione in Francia è meno nota di altre, meno legata a eventi funesti come la tragedia di Marcinelle in Belgio. Tuttavia, un accordo simile a quello con il governo belga era stato stipulato anche con il governo francese. Infine, l’emigrazione in Francia del secondo dopoguerra vive anche nelle bellissime canzoni di Gianmario Testa, il più francese dei cantautori italiani.
Un viaggio nella memoria
Quelle brevi stagioni, è il titolo del libro di Tonino Pecchia, pubblicato per 26 lettere edizioni nel 2021. Il sottotitolo recita così: Carnet di viaggio tra il “popolo delle gallerie.” Anche questa narrazione, come quella di Paola Martini è autobiografica e tutto inizia da un antefatto casuale: Tonino, il protagonista e narratore, legge casualmente nel 2017 un articolo del 2003 pubblicato su un giornale francese, da un giornalista che diventerà poi il prefatore del libro: Pierre-Christian Guiollard. L’articolo celebrava la chiusura della miniera di Merlebach e di colpo Tonino si ritrova proiettato a ritroso negli anni, a se stesso adolescente quando in un anno niente affatto banale – il 1968 – riceve in regalo il biglietto del treno per recarsi in vacanza dallo zio, che in quella miniera lavorava. La lettura dell’articolo diventa una specie di shock che lo spinge a ritornare sugli stessi luoghi di quelle brevi stagioni da lui trascorse in Lorena decenni prima. Le riflessioni sul presente e i richiami della memoria danno vita un intreccio narrativo fatto di rispecchiamenti e sovrapposizioni. La sensazione prima che ne ho ricavato come lettore è che l’emigrazione in Francia, pur nella durezza di qualsiasi migrazione, aveva dei tratti meno precari e cupi di altre. Il gusto dello stare insieme, il ballo in piazza, il gioco delle bocce, il cibo e il vino, tutta una serie di ritualità che Tonino ricorda puntualmente, dipingono un clima che nella mia memoria è diverso sia dai racconti che sentivo fare dai miei parenti emigrati in Svizzera, sia rispetto a una certa cupezza belga, che si ritrova puntualmente nella canzoni di Brel.
Il viaggio in treno
Il viaggio dell’adolescente Tonino comincia in un modo un po’ traumatico, ma il protagonista lo ricorda con sobrietà e leggerezza. La durezza dell’emigrazione compare subito, i litigi per un posto sul treno, un coltello minaccioso che compare e che subito dopo la minaccia – per fortuna domata – serve ad aprire una valigia da cui escono gli aromi rilasciati da cibi famigliari. L’Europa è quella del dopoguerra, ma non siamo già più nei momenti più aspri, se lo zio ha potuto invitarlo. Quel treno poi – l’Europa Express – fu veicolo per tante cose e tante esperienze diverse. Da studente universitario lo prendevo sempre pure io ogni estate per andare in Inghilterra a studiare e su quel treno si facevano incontri. Accadde anche a Tonino di trovare una ragazza su quel veicolo un po’ magico, che attraversava mezza Europa e arrivava a Calais. L’atmosfera di quel viaggio è ricostruita con leggerezza e ironia dal protagonista, che forse avrebbe preferito continuare su quel convoglio piuttosto che essere atteso dall’automobile dello zio alla stazione di Metz.
Da quel momento però si entra nel cuore della Lorena profonda, con le sue miniere, i suoi paesi – Merlebach, uno dei tanti – con le case basse dei minatori, che a me hanno ricordato molto anche quelle di Niccioleta e Follonica in Toscana. Le terre minerarie hanno tratti comuni. Lo zio però coinvolge il nipote anche nella discesa alla miniera:
… La nostra discesa alla miniera avvenne in un periodo in cui si effettuava soprattutto manutenzione … La miniera … è un labirinto di strette gallerie, non è opera del lento lavorio naturale, qui è l’uomo che scava e avanza, strappando il minerale alla terra, puntella le gallerie, continua a scavare e avanza sempre più in basso. Si scende tra i 500 e i 1250 metri, la discesa è buia, appena rischiarata dalle lampade sui caschi di protezione … il calore è spesso soffocante può superare i 40 gradi e persino i 60 pp. 150-1.
La durezza dell’esperienza è però supportata dall’esistenza delle cooperative solidali dei minatori, da un tessuto sociale che cresce intorno alla miniera e produce cultura, musica persino festival letterari.
La fine del ciclo minerario
Quando Tonino ritorna in quei luoghi molti anni dopo, tutto è cambiato. Il suo ritorno non è solo in Lorena ma anche a Parigi e la prima immagine che registra è il passaggio di una piccola processione religiosa sui Campi Elisi (pag. 136.). La memoria corre indietro nel tempo a quel 1968 che aveva potuto comunque osservare da vicino. Ritrovarsi con una processione nel luogo che fu teatro di scontri memorabili suscita in Tonino una sensazione di straniamento. L’Europa è cambiata profondamente, è caduto il Muro di Berlino e in questi ultimi anni, poi, è successo di tutto. Quanto alla miniera, i distretti minerari di un tempo si sono trasformati in musei di archeologia industriale. Tutto questo spinge l’autore a una riflessione di sintesi su entrambe le esperienze, quella giovanile e quella del ritorno. Il capitolo 29 intitolato Partire o restare Il problema del ritorno inizia proprio questa riflessione conclusiva che si colloca a metà strada fra narrazione e riflessione saggistica. Tre sono i casi presi in considerazione, corredati da una serie di testimonianze:
L’emigrante che sposa un’autoctona e resta in Francia.
L’emigrante sposato con una connazionale che per vari motivi ritorna definitivamente al paese d’origine.
L’emigrante che arriva in Francia e sposa una connazionale vi resta.
Lo zio di Tonino appartiene alla prima categoria e la sua come le altre testimonianze raccolte sono assai importanti ma ci presentano un quadro che probabilmente è assai diverso per chi emigra oggi. Nella nostra contemporaneità sono i giovani e le giovani laureate ad allontanarsi dal Bel Paese perché in esso trovano stipendi da precari a vita e poca mobilità sociale, mentre nelle testimonianze raccolte nel libro la sensazione prevalente è quella di una storia di avanzamento sociale, di difficile integrazione ma pur sempre integrazione. Certamente non è così per i migranti che provengono in Europa e in Italia dal sud del mondo.
L’appendice finale dedicata ai flussi migratori fra Francia e Italia, la ricca documentazione delle fonti consultate e la galleria di fotografie in bianco e nero costituiscono altrettanti contributi preziosi. La sorpresa finale è però un’altra. Tonino non smetterà di viaggiare, continuerà a ritornare in quei luoghi, la storia non è finita e le ultime osservazioni intorno ai problemi che i distretti minerari si lasciano a spalle, primo fra tutti l’inquinamento, sono un’esortazione a non lasciarsi catturare solo dalla memoria e dalla nostalgia, ma guardare al futuro. Ci aspettiamo dunque un seguito.