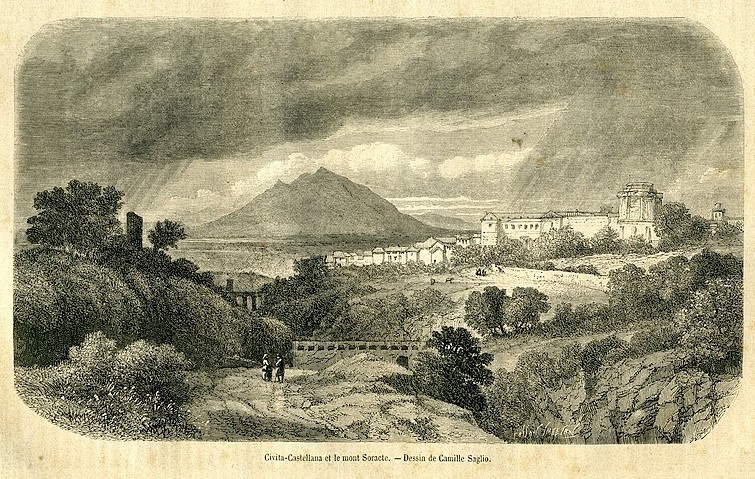DIARIO BERLINESE: PRIMA PARTE

Introduzione
Berlino è stata per alcuni anni una città che ho abitato e non semplicemente visitato: precisamente dal 2007 al 2019. La pandemia Covid 19 ha chiuso una fase della vita, ponendo fine fra l’altro anche alla frequentazione abituale della città. Ci ritornerò? Non lo so, la questione è assai complessa. I luoghi, con l’età che avanza, tendono a diventare definitivi nel ricordo e si ha quasi paura di turbarli di nuovo con la nostra presenza: poi però ci sono le relazioni e a Berlino ne ho stabilite poche ma di grande valore e intensità e con alcuni è difficile vedersi altrove. In attesa di trovare una soluzione al dilemma ho riletto il diario che ho tenuto in quegli anni e ho deciso di pubblicarlo qui a puntate.
29 Ottobre 2007.
Abitare una città e non visitarla da turista diventa percepibile quando alcuni luoghi che pure si sono frequentati volentieri durante i primi momenti, escono quasi dalla vita quotidiana, sostituiti da altri più legati al quartiere in cui si vive, al supermercato dove si va sempre perché solo lì si trova il vino che ci piace, oppure l’internet point e il bar dove capita di scambiare qualche parola con i gestori turchi del medesimo. Questa sensazione si è consolidata proprio in questi giorni.
30 Ottobre.
I luoghi influiscono sul modo di scrivere. È banale dirlo, ma quello che è difficile è mettere a fuoco il perché. Mi capita spesso di pensarlo qui a Berlino. Forse perché il mio tedesco è ancora misero e claudicante, scrivere a Berlino significa chiudersi dentro la propria lingua, attorniato da suoni che soltanto raramente diventano senso. A volte sono semplici parole, la cui frequente ripetizione suggerisce di colpo il significato e allora si forma come un atollo di significati che mi strappa alla lingua mia e mi riporta all’altra: da questa sorta di connubio dialettico sembra nascere qualcosa. Per il resto Berlino è una città che permette di rifarsi una verginità della vista, bombardati come siamo da immagini triviali; in questo anche Roma offre altrettanta e differente ricchezza. Perciò mi piace sempre di più scrivere in queste due città: forse vi è davvero un rapporto inverso fra comunicazione e scrittura. Mi ricordo anche di una recente intervista a uno scrittore ceco – Topol – il quale dice di venire a Berlino a scrivere proprio perché non sa il tedesco e può allora chiudersi in un silenzio che non è quello dell’assenza di parole, ma proprio la possibilità di essere immerso in una realtà potendo conservare la propria distanza. Berlino è avvolgente nel silenzio e questo accende altre parole… E poi la luce del nord, il suo estremismo che ha il proprio contraltare nel buio invernale altrettanto estremo.
6 gennaio 2008.
Forse la caratteristica saliente delle città tedesche è la presenza ancora oggi di un robusto apparato industriale all’interno del perimetro urbano; caso unico in Europa. Andando verso Amburgo con il bus lo si coglie bene. A parte le strutture del porto, tutta l’estrema periferia ovest della città è piena di ciminiere in azione, fabbriche, capannoni. Anche in zone più vicine al centro la presenza di industrie, in qualche caso dismesse, è altrettanto vistosa, tanto che in alcuni punti la città sembra un museo di archeologia industriale a cielo aperto. Alcune aree vengono destinate ad altri usi, ma lasciate nella loro integrità architettonica. A Milano tutto questo non esiste più da 50 anni ormai: l’ultima rovina industriale che ricordo è la stazione fatiscente della Bovisa, prima della bonifica. Nella parte est di Berlino la presenza industriale è ancora più evidente, a volte è difficile capire subito se una fabbrica sia ancora in funzione oppure sia una rovina. Poi si arriva ad Amburgo, un caso a parte: la ricostruzione del porto è qualcosa di spettacolare, uno degli esempi di architettura contemporanea più funzionali e belli da vedere, un mix di rispetto per la storia e di ardite soluzioni.
20 gennaio.
La visita al Museo ebraico di Berlino era in programma da tempo, ma non mi decidevo ad andarci, anche perché va detto che nella capitale tedesca i monumenti, i musei, le iniziative estemporanee che ricordano la Shoah sono tante; tuttavia quando si dice Museo ebraico si pensa a questo di Linden strasse, perché è di tutti il più completo e originale, anche come concezione architettonica. Esso è costruito intorno a quattro linee di forza che s’incrociano: la storia degli Ebrei in Germania da Costantino in poi, la storia delle persecuzioni, e delle conseguenti emigrazioni, la Shoah e infine il ritorno degli Ebrei nella Germania liberata e ancor più dopo la fine dell’Unione Sovietica. Progetto ambizioso, non sempre facile da seguire ma tuttavia esauriente. Le diverse linee che s’incrociano finiscono in tre casi in altrettanti vicoli ciechi. Il senso di essere immersi in un passato che non passa è assai forte, nonostante lo sforzo di avviare un discorso che sia anche di riconciliazione; ancora una volta mi ritrovo a pensare che l’orrore non sia rappresentabile e che solo i Greci si sono avvicinati a poterlo fare con una delle funzioni della tragedia: la catarsi, il rivivere insieme e collettivamente il dramma che permette di compatire, cioè patire insieme.
16 Febbraio.
Il paradosso berlinese quanto è destinato a durare? Difficile dirlo, ma l’insofferenza degli altri tedeschi cresce. A Berlino si vive troppo bene con poco e non è soltanto il frutto di una certa attitudine spartana, ma anche dei cospicui finanziamenti pubblici, riversati sulla città da tutta Europa. Berlino doveva essere risarcita in qualche modo dal fatto di essere stata la città di frontiera per eccellenza, di avere sopportato il peso della guerra fredda come nessun’altra città europea ha dovuto sopportare. Sono passati più di vent’anni, però, la memoria è corta. E poi a est rimpiangono addirittura il muro talvolta, sono molti a parlare di annessione, non di riunificazione e questo genera sentimenti ambivalenti: per l’uomo medio tedesco poco interessato alla politica, i berlinesi dell’est sono ingrati se rimpiangono il passato, mentre il cittadino dell’est, anche quello che aveva seguito le manifestazioni che portarono alla caduta della DDR, oggi, si rende conto di essere stato trattato come un tedesco di serie B.
20 Febbraio.
Della detenzione dei gerarchi nazisti nel carcere interno alla cittadella di Spandau, non rimane quasi nulla. I tedeschi ricordano in molti modi la terribile avventura nazista, lo fanno con scrupolo e metodo e lo fanno da tempo, dal 1968 in poi, con grande determinazione. Però, hanno voluto ridare all’affascinante complesso di palazzi e cortili della Cittadella di Spandau, il volto di un centro culturale, dove avvengono mostre concerti e altro: hanno fatto bene. Spandau è una cittadina deliziosa, come Potsdam peraltro, circondata dalle acque come sempre, ed è difficile capire se si tratta di uno dei tanti rami e canali della Spree o di che altro, bisognerà restarci un bel po’ in questa città per orientarsi davvero nel suo labirinto di acque e di boschi!
10 Marzo.
A cena con amici italiani che vivono qui a Berlino da tempo.
“Pare siano 800.000 gli invisibili in città mi dice Stefano e Corinne conferma.
“Forse sono un po’ tanti” ribatto io, “e mi è pure difficile pensare che siano proprio invisibili, forse sono tollerati, lo sanno ma finché non diventa un problema, non intervengono …”
Difficile dirlo, ma il problema rimane, il flusso migratorio di giovani verso Berlino è continuo e rilevante e ne conveniamo tutti. Potrà continuare? Si finisce sempre con questa domanda e la risposta è la recita di un mantra cui siamo tutti abituati: se l’Europa va in pezzi la Germania sarà l’ultima ad andarci e Berlino è l’ultimo posto a cadere. Rassicurati come sempre dopo ogni replica del copione, ci dedichiamo più volentieri al minestrone alla milanese che ho preparato cui segue un agnello sardo con patate e a cui seguirà il panettone – sì proprio lui – acquistato al Mittemeer e cioè alla catena di supermercati che vendono prodotti di pregio dei paesi del Mediterraneo: hanno confuso la Pasqua con il Natale ma la cosa ci mette ancora più allegria. I vini sono del Salento e di Spagna, abbiamo avuto le stesse idee in proposito, ma bevendo l’iberico mi rendo conto che anche loro hanno imparato a fare i rossi.
16 Marzo.
Capitato quasi per sbaglio alla Ostbanhof, cerco di capire cosa ci si possa fare. Ci sono le file di autobus in attesa di partire per i quartieri ancora più esterni di questa città che non finisce mai. Ripercorro allora la galleria da cui si sale ai binari dei treni ed esco dall’altra parte. A distanza vedo delle insegne di negozi. Esco, alla fine della breve scalinata che porta in strada staziona un gruppo di punk con accanto i cani di ordinanza e le bottiglie di birra nel mezzo del cerchio. Mi era già capitato di soffermarmi sulla differenza fra punk milanesi e berlinesi e questo gruppo me le richiama alla mente. Non parlo della foggia degli abiti, largamente comune e neppure del colore dei capelli o delle creste, di ordinanza come i cani, ma dell’atteggiamento. Il punk milanese maschio o femmina che sia è tendenzialmente aggressivo, la sua diversità è esibita: vuole essere notato, salvo poi mandarti al diavolo se gli fai qualche osservazione o anche semplicemente cerchi di parlarci. Spesso l’abito casual nasconde il griffato trash e alternativo, costoso, tanto da far pensare che dietro molti di loro ci siano famiglie non proprio indigenti. Sempre in movimento e petulanti nel chiedere, i punk milanesi, specialmente in certe zone della città, sembrano caricare all’eccesso il piacere di violare le regole; ma poiché nessuna comunità può vivere del tutto senza di esse, ecco che è sul cane che si riversa tale necessità. Mediamente meglio tenuti e puliti dell’animale umano cui si accompagnano, gli esemplari canini del punk milanese ostentano un portamento severo insieme a un distacco aristocratico: si muovono poco, osservano il mondo con l’occhio che oscilla fra un atteggiamento di indifferenza oppure uno sguardo del tipo “ma guarda cosa mi è capitato”; ma è solo un attimo, poi ritornano alla loro riservatezza fin troppo umana. Si spostano poco e solo se strettamente necessario e mai per attirare l´attenzione: sono loro alla fine che s’impongono nella coppia simbiotica, come portatori di una superiore dignità e allora può essere che anche il passante meno predisposto si lasci scivolare una moneta dalle mani, pensando al loro destino.
Il punk berlinese è del tutto diverso: più vicino al cliché nostrano del barbone di città il suo sguardo è rassegnato ma lui o lei sono educatissimi del comportamento. Il punk berlinese chiede con l’aria di chi sa già che non riceverà nulla, specialmente se si trova in metropolitana, ma non manca mai di ringraziare e augurare buona giornata all’interlocutore. Sa già che la sua diversità ha travalicato i confini di una città peraltro accogliente, ma che non tollera chi si è posto troppo oltre le regole e non guarda in faccia nessuno: tutti i punk che ho incontrato sono tedeschi, non ne ho visti di stranieri. E il cane? Pulcioso e sporco come i nostri vecchi cani da pagliaio si ingegna al posto del padrone per procurarsi il cibo, del resto la sua attitudine raminga non gli deve dispiacere del tutto: nella coppia simbiotica è lui a trarre il maggior beneficio da un ritorno al suo stato almeno in parte selvatico, mai del tutto cancellato nella specie cane da appartamento che subisce tutte le nostre nevrosi e malattie. Appena mi vede infatti, è lui a corrermi appresso (sono pur sempre uno che ha invaso il suo territorio), mentre il gruppo dei punk non mi degna di uno sguardo, sia pure per chiedermi qualcosa: una volta che ha messo a fuoco il mio intento del tutto pacifico, mi lascia al mio destino ma mi tiene d’occhio e infatti, non appena ho finito di guardarmi la posta in un internet point, ecco che riappare subito, si avvicina, scodinzola allegramente e mi guarda. È a lui in definitiva che do la moneta, come accade anche a Milano per ragioni opposte. Dal gruppo umano neppure uno sguardo: tutti con gli occhi rivolti a terra, oppure a chi sta loro di fronte in quel momento, seduti in cerchio come una vecchia tribù indiana, indifferenti a tutto e a tutti.
30 Marzo.
Mi sono spinto per l’ennesima volta nell’estrema periferia di Berlino: un vero e proprio viaggio perché il tram ci mette più di mezzora per raggiungere il capolinea di Wittenberg a partire da Alexander Platz! Dopo i grandi viali a ridosso del centro si arriva in una specie di terra di nessuno: campi sterrati, edifici fatiscenti, dove di certo non è difficile nascondersi. Pochi in quest´area gli spazi abitati. Per l’ennesima volta Berlino mi si rivela non solo immensa ma anche molto vuota. Ci sono voragini di spazio nella sua area urbana, e del resto 5 milioni di abitanti in un territorio come questo sono davvero pochi: se fosse una metropoli asiatica o latino americana ci abiterebbero almeno 20 milioni di persone.
2 Aprile.
Sì le cose stanno già cambiando anche qui eccome! La notizia mi arriva proprio oggi. L’amministrazione ha sospeso le erogazioni dei sussidi ai provenienti dai paesi del sud dell’Europa. Ci saranno ricorsi e molti vinceranno anche perché la norma pare retroattiva, ma il segnale è chiaro e molto forte: l’accoglienza indiscriminata che Berlino ha riservato a tutti e anche fornendo percorsi di integrazione guidati e sussidi economici, è finita. Durava dalla caduta del muro e si farà presto a dimenticare gli anni della generosità, ora che per l’ennesima volta i tedeschi danno la misura della loro capacità di decidere in fretta: in una notte hanno cambiato tutte le regole, cosa per noi difficilmente digeribile viste la propensione a non decidere o a decidere male e poi a fare peggio nel momento di applicare le decisioni.
3 Aprile.
Il segnale di cambiamento è forte, ma cosa sta davvero a significare al di là delle conseguenze che avrà verso coloro che qui avevano già iniziato un percorso di inserimento? La risposta più ovvia sta nel dire che anche la Germania non poteva continuare a reggere un livello di investimento pubblico e quindi di spesa così elevato, come è avvenuto per vent’anni. Del resto i tagli alla spesa sono cominciati anche qui e ci sono state grandi manifestazioni e scioperi quando è stato investito il settore universitario. Eppure la Germania sembra ancora lontana dal subire una contrazione del livello di vita medio (le secche di povertà e precarietà esistono eccome anche qui ma sono ben mascherate proprio dagli ammortizzatori sociali ancora efficienti). I provvedimenti si prestano dunque a diverse spiegazioni e risposte. Programmazione lungimirante della crisi? Oppure vicolo cieco nel quali tutti i popoli e gli stati europei si sono cacciati e verso il quale vanno in ordine sparso a sbattere uno per uno in tempi diversi? Oppure altro ancora? Difficile dirlo, ma una sensazione mi accompagna in modo martellante: gli storici ricorderanno questi mesi o poco più come un tempo di tregua prima di una grande tempesta.