WALLACE STEVENS: LE LEZIONI DI POETICA
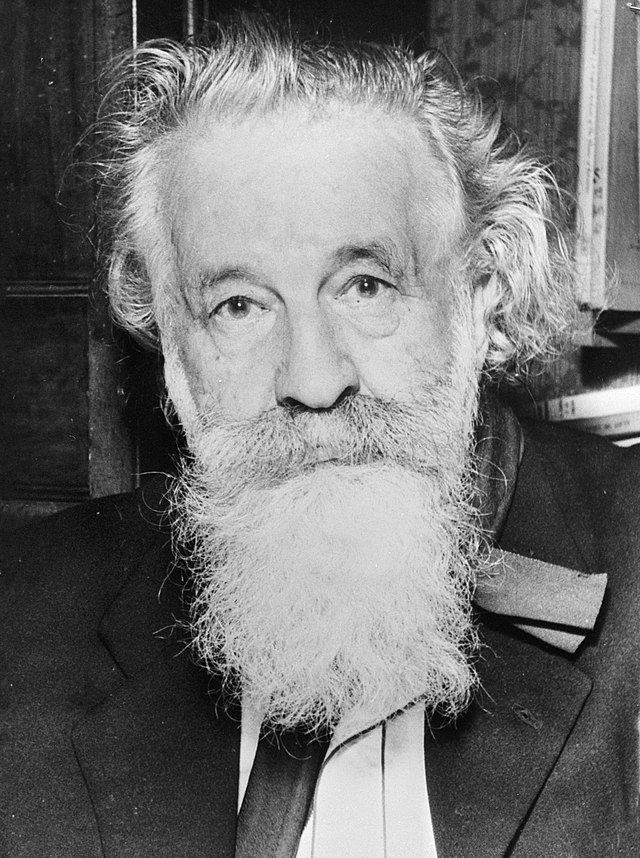
Introduzione
Con questa parte, la settima, si conclude il saggio sull’opera di Wallace Stevens. Il prossimo autore di cui mi occuperò in questa rubrica sarà T. S. Eliot e con lui terminerà il percorso di anglistica e americanistica che comprende anche Marianne Moore e William Blake. Su quest’ultimo non aggiungerò nulla mentre sugli altri tre e su alcuni convitati di pietra pubblicherò un saggio conclusivo sui modi di attingere alle diverse tradizioni letterarie.
——
Esiste una tematica centrale negli scritti di poetica di Stevens, che funga da attrattore? Ce ne sono a mio avviso quattro di cui una però preminente: il rapporto fra realtà e immaginazione, il vero rovello della poetica stevensiana. La seconda è il rapporto fra poesia e pittura; la terza, che si avvicina alla speculazione filosofica, è l’idea del mondo come meditazione. L’ultima emerge con chiarezza da uno solo di questi saggi dal titolo Effetti dell’analogia ed è l’importanza che il poeta assegna alla similitudine come figura retorica.
Lo stile di questi saggi è ellittico, la divagazione vi regna sovrana, ma alla fine, quando con le sue sintesi egli stringe le fila del discorso, ecco che si ritorna all’uno o all’altro degli attrattori.
In quanto lettore, Stevens era una spugna, ma anche svagato. Quando sembra che le sue letture siano approfondite per l’acutezza di certi giudizi, si scopre poi che tutto questo è assai vivo nel testo poetico, ma se si va oltre non si trova nulla o poco; oppure che il poeta è riuscito a dissimulare molto bene.
Vi sono a mio giudizio due filosofi e pensatori europei contemporanei a lui che Stevens aveva ben presenti: Henry Bergson e Gaston Bachelard. Al primo dedica anche una citazione in uno dei saggi de L’angelo necessario,83 il secondo è più sotto traccia ma altrettanto importante.
Per entrambi i filosofi e per Stevens, la realtà fisica è la base imprescindibile di ogni forma di conoscenza e quando Bergson afferma che la percezione non aggiunge nulla all’immagine percepita, riscontriamo un’assonanza con l’affermazione di Stevens che l’immaginazione non aggiunge nulla all’oggetto, ma lo intensifica. In Bachelard, addirittura, è la realtà fisica a suggerire le metafore più ardite e illuminanti, a questo proposito, sono le pagine che egli dedica alla scoperta del fuoco.84
Un’altra assonanza con Bergson possiamo riscontrarla nel modo di trattare la memoria da parte di entrambi e nel concetto di flusso che in parte si sovrappone a quello di durata. Abbiamo visto come in Stevens il processo decreativo non sia un passaggio da ciò che è creato al nulla, ma a ciò che creato non è o non lo è ancora. Il flusso, in secondo luogo, porta all’endless poem, cioè al poema senza fine, che non significa incompiuto e neppure senza una conclusione, ma che allude alla tendenziale inarrestabilità del flusso. Vale forse la pena di notare come la parola morte compaia pochissimo nei testi di Stevens; anzi, ricordo una sola forte presenza nella sezione finale di Peter Quince at the clavier, oppure indirettamente in Omone rosso che legge e in alcuni testi dedicati al soldati defunti in guerra. Sia Bergson, sia Bachelard, sia Stevens, sono diffidenti quando non ostili nei confronti dell’invenzione e della fantasia, mentre considerano la scoperta e l’immaginazione veramente importanti. Nel caso dei due filosofi farò riferimento solo ai testi e a un saggio pubblicato sul Wallace Stevens Journal e che ritengo esaustivo (specialmente per quanto riguarda i rapporti con Bergson).85 Quanto a Stevens, per capire cosa lui intende nel contesto della poesia e della critica letteraria, mi servirò di due citazioni in momenti e situazioni diverse, accostandole. La prima è tratta da una conferenza compresa nella raccolta L’Angelo necessario e suona in questo modo:
… Una delle caratteristiche dell’arte moderna è la sua intransigenza. In questo, essa assomiglia alla politica moderna … Un’altra caratteristica dell’arte moderna è che essa è plausibile. Ha una spiegazione per ogni cosa. Anche l’assenza di spiegazioni diventa una spiegazione. Picasso rimane sorpreso quando gli chiedono cosa significhi un quadro e dice che i quadri non sono concepiti per avere un senso. Questo spiega tutto. Un’altra caratteristica dell’arte moderna è il suo settarismo … Anche nella poesia moderna abbiamo la stessa incapacità di scendere a compromessi … Per illustrare questo punto dividerò la poesia moderna in due categorie: la prima categoria è moderna per ciò che dice, la seconda lo è per la sua forma. La forma non interessa particolarmente i poeti del primo gruppo. … Oggi si vede moltissima poesia, grazie forse a Un coup de dès di Mallarmé, in cui l’interesse per la forma si risolve solo nell’uso di lettere minuscole al posto delle maiuscole, su originali chiusure di verso, di troppa o troppo poca punteggiatura … Per la prima categoria che si concede una forma ordinaria, è persino dannoso suggerire che i suoi poeti sono meno artificiali di quelli della seconda … Ognuna delle due categorie, mostra una totale intransigenza nei confronti dell’altra.86
La seconda citazione è una sentenza, pubblicata per la prima volta insieme ad altre e ad alcuni aforismi, sulla rivista View nel 1940, cui ne seguirono altri nel ’42:
L’errore fondamentale del surrealismo è che inventa e non scopre. Un mollusco che suona la fisarmonica è un’invenzione non una scoperta. L’osservazione dell’inconscio, per quanto sia possibile osservarlo, dovrebbe svelare cose di cui prima eravamo inconsapevoli, non le cose famigliari di cui siamo ben consapevoli, più la fantasia. 87
Ancora una volta Bergson può soccorrerci. Anche per lui la metafisica intuizionale è fondamentale nella scoperta scientifica, ma niente è più nefasto alla scienza dell’invenzione. La scienza non inventa, scopre: sebbene nel formulare una teoria o un’ipotesi possa partire da una metafora o da un’intuizione matematica, essa deve poi trovare una concretizzazione nella realtà fisica, altrimenti rimane una congettura priva di sostanza.
Cosa rimprovera Stevens, allora, alle avanguardie europee? In primo luogo gli eccessi e la mancanza di misura; in secondo luogo, nella sentenza di cui sopra, che la mancanza di misura impedisce di distinguere fra invenzione e scoperta, perché l’invenzione, in sostanza, non tiene conto della realtà fisica dell’oggetto e lo manipola. Su quanto afferma sull’inconscio si dovrebbe rimanere più a lungo, ma mi sembrano queste le distinzioni prima di tutto decisive. L’immaginazione ha una funzione di scoperta, mentre la fantasia è arbitraria, sebbene possa essere un punto di partenza. Da quanto detto sopra si può capire meglio la distanza che separa Stevens dal postmodernismo, che in fondo non è altro che un’accentuazione di tutti gli aspetti deteriori delle avanguardie storiche, senza conservare quelli virtuosi. Si può comprendere forse meglio, allora, la predilezione di Stevens per la similitudine e l’analogia, ma anche lo stile paratattico del suo linguaggio. L’accostamento, che porta all’analogia e alla similitudine piuttosto che alla metafora, lascia i diversi elementi accostati in uno stato di fluidità maggiore, di oscillazione del senso, ma anche di maggiore libertà di ciascun elemento di ritornare a essere quello che è al di fuori della connessione e dell’accostamento. Il procedimento paratattico di Stevens va allora messo in relazione con il suo concetto di decreazione che è appunto un passaggio da ciò che è creato all’increato o al non ancora creato. Lo abbiamo visto sempre in alcuni snodi della sua poesia: nell’ottava sezione di Sunday Morning, ma anche nel passaggio dalle figure dei due leoni poi al canonico Aspirina per approdare all’Angelo necessario: l’accostamento paratattico può essere sciolto per creare di nuovo le condizioni di una successiva ricreazione, alla quale però nuovi apporti non cancellano del tutto gli apporti precedenti. Accostamento paratattico, analogia e decreazione sono gli elementi combinati di un processo metamorfico continuo. L’analogia, peraltro, ci riporta anche a Bachelard che ne fa largo uso. Non per caso, dunque, uno dei saggio più importanti di Stevens s’intitola proprio Effetti dell’analogia.88
Conclusioni in divenire
Per Stevens, lo abbiamo visto, le tradizioni cui attingere sono molte, anche se alcune sono prevalenti; esse non sono un peso, né una fonte ingenua di scoperta, ma un oggetto di riflessione e di meditazione. Il procedimento decreativo, la metamorfosi, la rinuncia alle antinomie – per dirla con le sue parole non o, o (aut aut) ma e, e, la scelta del sì che ripete più volte dando a questa espressione il valore di un’adesione senza tentennamenti alla nuda vita, sono le architravi della sua poetica e da questo scaturisce il suo rifiuto a vivere la storia del ‘900 come un cultore dell’abisso. Allora vale forse la pena di domandarsi non quanto della tradizione occidentale Stevens conservi, ma dove si affaccia alla fine la sua ricerca. Da parte della critica che si è occupata di lui affiora qui e là la parola zen, seppure per ridimensionarne la portata. Guido Carboni nella sua ricognizione sui possibili referenti della poesia stevensiana, si esprime così:
Quando Stevens inizia la sua meditazione pensare il paradosso doveva essere ancor più difficile perché non c’erano molti strumenti a disposizione. Non c’erano le speculazioni di Bateson sul rapporto mente e natura, non le riflessioni sul metodo di Cartesio … né quella di Maturana sull’autopoiesi … C’era naturalmente lo zen, cui molti scrittori contemporanei o appena più giovani di Stevens si andavano avvicinando, ma non se ne trova traccia diretta in lui, il suo orientalismo è un fatto degli inizi della sua carriera poetica e appare come assolutamente estetico.92
Non concordo con l’ultima parte perché la grande poesia ha sempre un valore conoscitivo e non la si può ridurre a un valore puramente estetico. Se Carboni, dopo avere evocato lo zen, pare metterci una pietra sopra, il dubbio sembra venire anche a Massimo Bacigalupo che nell’introduzione all’Opus Posthumus, a proposito della poesia dal titolo The course of the particular, di cui ci siamo occupati afferma:
L’eroe di Stevens è la mente umana alla ricerca di un modus vivendi anche minimo, e questo non può darsi se non attraverso il superamento dell’inimicizia fra mente e materia … ma non si tratta di riesumare l’organicismo deistico dei romantici … bensì di preparare l’uomo alla sua cancellazione escludendo rigorosamente ogni protezione antropomorfica … cancellazione che si compie … e si fonda sulla convinzione che solo attraverso la disperazione, un azzeramento quasi zen del significato, passi la vita di ciò che è sufficiente.93
Questa affermazione mi sembra assai interessante e a mio modesto parere bisogna imboccare con maggiore coraggio questa strada, senza fare per questo del poeta un antesignano delle mode degli anni ‘60 o di quelle attuali. Il secondo spunto viene dal titolo stesso di una delle sue opere finali: Il mondo come meditazione. Le parole che un poeta sceglie non sono casuali e la parola meditazione ha un peso e una consistenza particolari. La sua poesia è stata spesso definita una poesia di ossimori. Questa costatazione, quasi ovvia, va tuttavia precisata meglio perché se prendiamo questi versi:
… Fra origine e ritorno//C’è un’assenza in realtà/ Le cose come sono. O così pare/,94
ci rendiamo subito conto di essere in presenza non di una semplice figura retorica. Quello di Stevens è un vero e proprio ossimoro concettuale, cioè un paradosso, e proprio il ricorso ai paradossi, poco comune nella poesia occidentale, si presta a un accostamento a certi modi orientali di manifestare il pensiero: i koan giapponesi ne sono l’esempio più illustre. Stevens era un profondo conoscitore del teatro e della cultura giapponesi e lo è rimasto per tutta la vita. Infine, in certi passaggi da un verso all’altro vi sono allusioni al concetto di vuoto come lo intende il buddismo e cioè in modo assai diverso da quello che la parola potrebbe evocare per noi occidentali. Il vuoto, anche nella concezione del Tao, per esempio, non è il nulla ma uno spazio libero dove si forma qualcosa: pensato in questi termini è un concetto assai prossimo a quello di decreazione in Stevens, cioè il passaggio dal creato all’increato ma anche al non ancora creato. Lo si potrebbe descrivere anche come il silenzio che circonda la parola poetica prima del suo sorgere e dopo.
Infine in rapporto alle cose, il suo mondo irreligioso non è ostile al mistero, ma non porta sulle tracce del divino, almeno nel senso che questa espressione ha assunto, dopo Heidegger. Come va intesa allora questa sua non ostilità al mistero e forse anche sacro? Nel senso che tutto ciò che abita il mondo è per Stevens animato, possiede una sua propria musica, persino la roccia, metafora di una durezza che resiste all’immaginazione. C’è un alone che circonda le cose ed esso può essere inteso anche come una sorta di danza dionisiaca della materia, senza che questo ricada in un credo di tipo panteistico, poiché anche per i panteisti ciò che si manifesta nella natura rimane pur sempre il dio personale, dalle sembianze alla fine antropomorfe, seppure immanenti.
Il canto della terra è per Stevens una qualità fine della materia che l’immaginazione sa cogliere perché entrambe sono parti di uno stesso cosmo non più scindibile in una neutra realtà oggettiva e nello sguardo esterno del cogito che la osserva e la manipola. Siamo dunque distanti da Cartesio, che Stevens tuttavia conosce bene, tanto da farne spesso l’oggetto di versi ironici anche se non sempre appropriati e fondati in parte sull’equivoco di considerare Cartesio come il primo degli illuministi. Cartesio, invece, dedicò l’intera sua vita alla res extensa, più che al cogito e cioè, paradossalmente, proprio a quella realtà fisica e organica dalla quale anche per Stevens non si può prescindere. Tornando allora con una breve parentesi ai suoi referenti filosofici, oltre ai nomi già citati, alcune sue descrizioni entusiastiche di fenomeni naturali ricordano da vicino proprio un filosofo e poeta dell’antichità: Lucrezio.
Ci sono due terre promesse alla fine del poema infinito di Stevens: una è quella stessa raggiunta da lui nel suo approdo a New Haven e nell’Opus Posthumus; la seconda più nebulosa, la intravvediamo arrampicandoci sulle sue spalle ed è una zona di confine. Perché è indubbio che Stevens arriva in un punto dove, parafrasando un verso delle sue Note, il pensiero non può più progredire in quanto tale. L’abbandono delle antinomie ci avvicina a un modo diverso di sentire anche se mi rendo conto che parlare contemporaneamente di zen e di un alone quasi animistico intorno alle cose significa accennare a due modalità molto differenti. Mi fermerò allora alla considerazione che l’endless poem di Wallace Stevens sembra alludere alla necessità di fuoriuscita dal pensiero occidentale, piuttosto che ritornare ai suoi miti originari, ignorando la modernità, che invece Stevens non ha mai smesso di attraversare. I grandi spiriti artistici, vedono i tempi nuovi con grande anticipo e forse la presunta difficoltà della sua poesia sta proprio in questo annuncio. Se è così il tempo lo rischiarirà.

83 Op. cit. pp. 113-4
84 Gaston Bachelard, L’intuizione dell’istante, la Psicoanalisi del fuoco, Edizioni Dedalo, Bari 1973.
85 Mi riferisco al numero 1 della primavera del 2002 che contiene un saggio di Temenuga Trifonova dal titolo The poetry of matter: Stevens and Bergson: pp-41-69.
86 I rapporti fra la poesia e la pittura . Tutte le citazione sono tratte dal capitoletto intitolato Terzo, pp.239-42.
87 Materia poetica, in Aurore d’autunno, a cura e traduzione di Nadia Fusini, Adelphi Milano 2014, pp.27. Naturalmente, questa sentenza lapidaria di Stevens, non può essere adoperata per una critica di fondo al Surrealismo, ma per certi suoi aspetti certamente sì. Del resto, se si considera un autore come Walter Benjamin – che certamente Stevens non conosce – che del Surrealismo è stato un grande estimatore tanto da scrivere sul movimento uno dei suoi saggi più importanti, alcune sue critiche molto severe rivolte a Breton hanno delle assonanze con l’affermazione di Stevens. Anche Benjamin non amava le invenzioni gratuite, specialmente quando sconfinavano nell’esoterismo. Le assonanze, in ogni caso, si fermano qui: Stevens avrebbe considerato aberrante quello che Benjamin amava di più del surrealismo e cioè il suo rapporto con le politiche rivoluzionarie.
88 Wallace Stevens L’angelo necessario, a cura di Massimo Bacigalupo, Coliseum, 1988, pp. 181-206
92 Wallace Stevens, Mattino domenicale, a cura di Renato Poggioli, Postfazione di Guido Carboni, Einaudi 1982, pag.170
93 Wallace Stevens, Harmonium, a cura di Massimo Bacigalupo, saggio introduttivo. Suggerisco la lettura dell’intera introduzione di Bacigalupo. Einaudi, collana i Millenni, Torino 1994.
94 La frase è una delle più comuni, ripetuta in varie forme sia in conferenze sia in versi come in questo caso.

