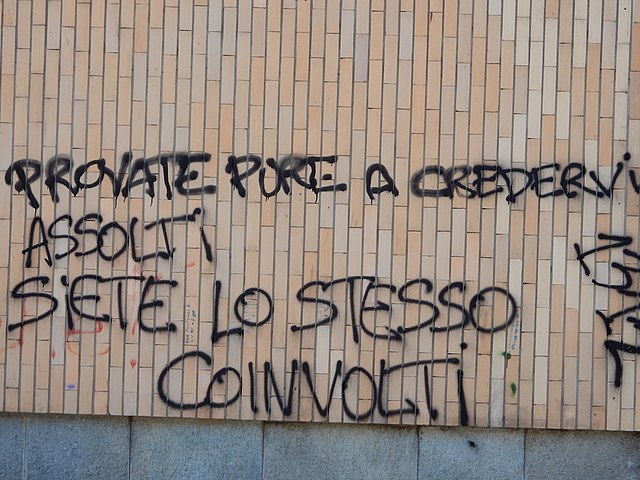NOBEL MANCATI: FABRIZIO DE ANDRÈ
Questo saggio fu pubblicato nel blog Diepicanuova – http://diepicanuova.blogspot.com, – fondato da Paolo Rabissi e da me. L’occasione, allora, fu il dibattito che nacque dopo l’attribuzione del Nobel della letteratura a Bob Dylan, dibattito che si trova e può essere letto nel sito Diepicanuova. Lo ripropongo qui in memoria di Fabrizio de Andrè, nei giorni ci ricordano la sua precoce morte.

Premessa.
L’attribuzione del Nobel a Bob Dylan è ormai metabolizzata alle nostre spalle da tempo e siamo ritornati negli alvei consueti, tutto passa in fretta. Contagiato dalla lentezza, però, ho continuato a ragionare sul senso che possa avere l’assegnare alla canzone d’autore un valore che sia anche letterario. La questione ha una sua importanza, checché ne pensino i poeti laureati, anche perché esistono culture diverse dalle nostre, seppure parenti strette (penso all’America Latina), dove hanno opinioni molto diverse in merito. Così, di riflessione in riflessione, mi sono ritrovato a domandarmi che cosa abbia Fabrizio De Andrè meno di Bob Dylan per essere considerato nel Pantheon degli esponenti maggiori del genere e perché no – visto il precedente illustre – anche meritevole di un riconoscimento letterario. Ho cominciato allora ad ascoltare di nuovo De Andrè, album dopo album, convinto come sono che le antologie (anche quelle di poesia) sono importanti per dare il senso di un periodo letterario, ma sono bugiarde quando sono la rassegna dedicata a un solo autore. Gli album sono come i libri per un autore di canzoni: entrambi sono organismi autonomi e non semplicemente una sequenza di testi e canzoni. Le antologie, invece, tendono per forza di cose a scegliere fior da fiore, ma in questo modo si perde il lavorio che sta alle spalle di un libro come di un album, ma anche a considerare minori delle canzoni o poesie che non lo sono affatto.
La prima fase
Il primo album registrato da De Andrè, nonostante alcuni 45 giri precedenti e un long playing, è Volume 1 del 1967, un titolo anodino ma anche leggibile oggi in altro modo. A un semplice ascolto dopo tanto tempo, l’impressione è grande. Durante gli anni ’60 ci sono state molteplici rotture culturali e politiche. Nel campo della canzone ebbero di certo la loro importanza Modugno e i cantautori genovesi; inoltre, c’era stata la polemica di Calvino, Pasolini e Fortini contro il Festival di Sanremo, che aveva portato fra l’altro al rilancio della canzone popolare e operaia con Cantacronache e poi il Nuovo Canzoniere di Michele Straniero. Si trattò di operazioni meritevoli, ma con lo sguardo rivolto a un passato che andava di certo conservato, ma che non poteva avere alcun impatto sulla cultura di massa che si stava formando: lo avrebbe avuto dopo il ’68 per ragioni politiche. Il festival di Sanremo non andava aggredito per contrapposizione e Pasolini fu il primo ad accorgersene quando ammise (cito a memoria) che niente altro poteva rappresentare l’estate del 1964 meglio di Sapore di sale di Gino Paoli. Occorreva un’operazione diversa e cioè portare la canzone popolare e di massa a un livello più elevato anche dal punto di vista dei testi, togliendo così centralità al Festival. Ascoltando il primo album di De Andrè, si coglie il senso di una frattura profonda con quanto si cantava in precedenza; a cominciare da Preghiera di gennaio, la canzone d’apertura che egli scrisse dopo il funerale di Luigi Tenco. Versi in difesa dei suicidi come:
Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero […] perché non c’è l’Inferno nel mondo del buon Dio […] l’Inferno esiste solo per chi ne ha paura
aprono un orizzonte nuovo e se pensiamo proprio al confronto con Tenco medesimo e aldilà della loro amicizia, la separazione dal gruppo genovese è netta. Iniziò allora una stagione veramente importante, anche grazie all’intuizione di Amilcare Rambaldi, che seppe metabolizzare la morte di Tenco fondando il club omonimo che divenne il polo intorno al quale cominciò a coagularsi il meglio della musica italiana d’autore. L’operazione ebbe anche un successo commerciale, visto che si vendeva e si ascoltava di più quello che non andava a Sanremo piuttosto che quello che ci andava.
L’album contiene alcuni dei suoi brani memorabili come Bocca di Rosa e la Ballata di Re Carlo, tuttavia è sulla sua prima parte che vorrei soffermarmi, perché in essa è presente la visione di un cristianesimo anti istituzionale che ricorda l’analoga operazione compiuta da Dario Fo più o meno negli stessi anni: distaccare la figura di Gesù da ogni orpello chiesastico. Mi riferisco a brani come la già citata Preghiera di gennaio, Spiritual e Si chiamava Gesù. Questo tema di un cristianesimo vagamente anarchico e antistituzionale, fondato anche sui Vangeli Apocrifi, che tanto entusiasmava un uomo e un sacerdote come Don Andrea Gallo, verrà ripreso da De Andrè anche in alcuni degli album successivi e prima di tutto in La buona novella.
Nella seconda parte di Volume 1, con Via del Campo, entrano in gioco i temi che saranno – in ogni album – i suoi più forti: gli emarginati, gli anarchici, i ribelli, le puttane e i loro clienti, la critica dell’ipocrisia e del perbenismo borghesi, il rifiuto di ogni potere e della sua giustizia (“non ci sono poteri buoni”).
Dall’esistenzialismo alla ribellione
Il contesto sociale che fa da sfondo alla poetica di De Andrè durante il corso degli anni ’60 è la Genova città di porto più che terzo polo industriale del triangolo: con le sue taverne più che non le sue industrie, la famosa via Prè che corre in parallelo alle grandi strade, che si apre ad altri vicoli e ai suoi umori e personaggi. Questa realtà però si tinge di colori espressionisti e visionari, sia risalendo a fonti letterarie come Villon e Angiolieri, sia andando indietro nel tempo, riscoprendo sonorità a ritmi che si richiamano a un medioevo genericamente inteso o comunque rivolti a un passato che a Genova è stato peraltro assai fiorente. Nella Genova contemporanea, come altrove, prevalevano – negli artisti più inquieti – gli umori esistenzialisti, i riferimenti erano Parigi, Prevert, Sarte ma, specialmente per il gruppo genovese, Juliette Greco, Brel e Brassens. Nel tempo, però, tali umori diventarono una gabbia per la maggioranza di loro, dalla quale non usciranno mai. Per tutti l’estenuato Tenco, il cui tragico destino non può far dimenticare, a decenni di distanza, la sua troppo esibita malinconia esistenziale, condita da quantità industriali di narcisismo. In Italia stavano cambiando molte cose e il solo a uscire dalla gabbia fu proprio De Andrè, perché già in origine la sua poetica si nutriva di riferimenti che spaziavano in molteplici direzioni, fra cui la poesia. De Andrè non fu vicino al ’68 perché troppo lontano da ogni tentazione militante, tanto da essere ritenuto addirittura una spia dalle componenti più settarie e idiote delle nascenti forze partitiche extra parlamentari; il paradosso sta nel fatto che anni più tardi fu proprio lui a diventare oggetto delle attenzioni dei servizi segreti! Egli seppe però cogliere il cambiamento, scegliendo anche nei suoi riferimenti d’oltralpe, chi anche in quel contesto sapeva interpretare meglio lo spirito dei tempi: Vian piuttosto che l’eterno adolescente Prevert.

Gli album successivi al primo riflettono questi mutamenti, sia per la concentrazione in pochi anni, sia per i toni espressivi interni a ciascuno di essi, tanto da segnare il passaggio dagli esordi a una prima fase di maturità: Tutti morimmo a stento (1968), Volume III, sempre del ’68; poi Nuvole barocche (1969), che comprende anche tutte le canzoni precedenti l’anno d’esordio. Questo ciclo si conclude nel 1973 con Vita di un impiegato, ma a metà di esso e cioè nel 1971, si colloca Non al denaro, non l’album minore di questo periodo, nonostante La canzone dell’amore perduto peraltro presente anche in altri long playing. Volume III contiene alcuni dei suoi capolavori fra cui un’impareggiabile versione de Il Gorilla di Brassens, La guerra di Piero, Amore che viene amore che va.
Tuttavia, è sull’ultimo album di questo periodo, Storia di un impiegato, che mi sembra utile soffermarsi, perché si distanzia dai precedenti proprio perché affronta criticamente e anni dopo, il movimento del ’68 e tutto quanto se sortì. La critica di sinistra lo accolse male ma anche al di fuori di quell’ambito, fu considerato un flop. De André stesso in un’intervista, ne parlò in questo modo:
La “Storia di un impiegato” l’abbiamo scritta, io, Bentivoglio, Piovani, in un anno e mezzo tormentatissimo e quando è uscita volevo bruciare il disco. Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente e so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile, so di non essere riuscito a spiegarmi.
Nella dichiarazione di cui sopra c’è quasi tutto, nel senso che emerge da essa la difficoltà di De Andrè nel rapportarsi ai movimenti di quegli anni, ad affrontare direttamente una tematica politica ma anche l’onestà intellettuale di avere cercato di farlo. La scelta stessa di scrivere la storia di un impiegato rivela prima di tutto la sua difficoltà a rapportarsi con la classe operaia; a differenza di Jannacci a Milano, per esempio. Anche nelle canzoni di quest’ultimo non mancano barboni, prostitute e clienti, solo che tali figure assumono maggiormente aspetti caricaturali e comici, mentre i veri personaggi drammatici delle canzoni più alte di Jannacci sono le vincenzine, cioè le operaie, le commesse, le lavoratrici che diventano metafora della fatica proletaria. Nonostante vivesse nella città dei portuali che nel 1960 erano stati protagonisti di una memorabile stagione di lotta che apriva il decennio che avrebbe portato al ’68, De Andrè non li vede, forse non è in grado di vederli perché il suo occhio vede altro. Tuttavia, era proprio così sbagliata l’idea di mettere un impiegato al centro della scena? Uno degli aspetti nuovi delle lotte di quegli anni non era forse costituito proprio dalla presenza di un forte movimento studentesco e di una saldatura fra operai, impiegati e tecnici dentro le fabbriche? A Milano, in anni precedenti, gli impiegati, le commesse, i goliardi delle serali, non erano forse stati i protagonisti del poemetto La ragazza Carla di Elio Pagliarani e de La capitale del Nord di Giancarlo Majorino? Non sarà proprio un perito tecnico impiegato alla Sit Siemens a diventare il leader delle Brigate Rosse? Allora, al netto di certe prese di posizione troppo emotivamente datate, si può affermare ad anni di distanza che si tratta di un album minore rispetto a quelli citati in precedenza, ma che in esso è presente un testo come Il bombarolo, che, proprio nella sua ambivalenza, indica una possibile parabola che accompagnò il decennio ‘70 come una nuvola scura. La radicalizzazione un po’ astratta e troppo recente da parte di ceti in ombra fino a un decennio prima, poteva portare anche a derive di varia natura. Parlo di ambivalenza perché Il bombarolo incarna una figura estrema e opaca al tempo stesso, che poteva prestarsi o essere usato sia a sinistra sia a destra. Se vi è una eco, nella canzone, delle tendenze anarchiche De Andrè, il personaggio appare segnato da un’ambiguità che lo corrode dall’interno.
Chi va dicendo in giro/che odio il mio lavoro/non sa con quanto amore/mi dedico al tritolo,/è quasi indipendente/ancora poche ore/poi gli darò la voce/il detonatore.//Il mio Pinocchio fragile/parente artigianale/di ordigni costruiti/su scala industriale/di me non farà mai/un cavaliere del lavoro,/io sono d’un’altra razza,/son bombarolo.//Nello scendere le scale/ci metto più attenzione,/sarebbe imperdonabile/giustiziarmi sul portone/proprio nel giorno in cui/la decisione è mia/sulla condanna a morte o l’amnistia.//Per strada tante facce/non hanno un bel colore,/qui chi non terrorizza/si ammala di terrore,/c’è chi aspetta la pioggia/per non piangere da solo,/io sono d’un altro avviso,/son bombarolo.//Intellettuali d’oggi/idioti di domani/ridatemi il cervello/che basta alle mie mani,/profeti molto acrobati/della rivoluzione/oggi farò da me/senza lezione.//Vi scoverò i nemici/per voi così distanti/e dopo averli uccisi/sarò fra i latitanti/ma finché li cerco io/i latitanti sono loro,/ho scelto un’altra scuola,/son bombarolo.//Potere troppe volte/delegato ad altre mani,/ sganciato e restituitoci/dai tuoi aeroplani,/io vengo a restituirti/un po’ del tuo terrore/del tuo disordine/del tuo rumore.//Così pensava forte/un trentenne disperato/se non del tutto giusto/quasi niente sbagliato,/cercando il luogo idoneo/adatto al suo tritolo,/insomma il posto degno/d’un bombarolo./C’è chi lo vide ridere/davanti al Parlamento/aspettando l’esplosione/che provasse il suo talento,/c’è chi lo vide piangere/un torrente di vocali/vedendo esplodere/un chiosco di giornali. //Ma ciò che lo ferì/profondamente nell’orgoglio/fu l’immagine di lei/che si sporgeva da ogni foglio /lontana dal ridicolo/in cui lo lasciò solo,/ma in prima pagina/col bombarolo.
Forse, concludendo questa parte si può dire che non era nelle sue corde affrontare di petto una tematica politica e che i conti con il ’68 li aveva già fatti, a modo suo, altrove, nella riscrittura dell’Antologia di Spoon River.
L’album chiuse un periodo dalla sua produzione, cui seguì una lunga crisi creativa, che tuttavia vide anche l’inizio di nuove collaborazioni proficue (con De Gregori e più tardi con Bubola), traduzioni di canzoni di Cohen, Dylan e altri e una serie di pubbliche esibizioni. Non intendo in questa riflessione seguire un percorso storicistico e dunque salto direttamente all’ultimo De Andrè, quello di Crêuza de mä (1984) e di Anime salve (1996), sebbene nel mezzo un album come Rimini (1978), sia tutt’altro che disprezzabile.
I grandi album
Il vertice dell’opera di De Andrè si trova a mio avviso nei due ultimi album e in quello già citato del 1971: Non al denaro, non all’amore né al cielo.
Crêuza de mä è un’opera del tutto nuova rispetto alle precedenti, che apriva una strada interrotta purtroppo dalla precoce morte: l’attenzione verso la musica etnica, le sonorità mediterranee e le lingue minori. La scelta di scrivere i testi in genovese lo testimonia. Non sono in grado, mi mancano le competenze per farlo, di valutare quale apporto linguistico esso dia alla koinè ligure e genovese che, ancora negli anni ’60, esprimeva autori che andavano ben oltre la commedia dialettale nel teatro (Govi) e che avrebbe espresso poeti come Roberto Giannoni e Paolo Bertolani. Da semplice ascoltatore c’è un dato sorprendente che mi ha colpito subito: il mare, in fondo poco presente nella produzione precedente di De Andrè, diventa il primo protagonista di questo album, un mare che si avverte prima di tutto nelle cadenze ritmiche della partitura musicale. Il merito, in questo caso, non è soltanto suo ma anche di Mauro Pagani.
Anime salve è una lunga meditazione sulla vita e sulla morte, dove precipitano in un’opera compatta e rigorosa tutti i temi della sua poetica, ma anche i diversi stili e timbri musicali, in questo aiutato dalla collaborazione con Ivano Fossati. Viene ribadita anche l’attenzione verso le sonorità mediterranee e le lingue minori (Â cúmba è scritta in genovese). Prinçesa, il brano d’apertura, ci dice fra l’altro quanto tempo sia passato dalle taverne di via Prè, dagli emarginati dei vicoli genovesi, dal porto ormai in parziale disarmo. Lo scenario è diventato globale e De Andrè lo coglie nella storia di un bambino brasiliano che si sente donna e si sottopone a tutta la trafila di dolore e umiliazioni possibili fino ad approdare fra le braccia di un avvocato milanese: l’alternarsi della lingua italiana con quella brasiliana riprende nel testo l’attenzione vero gli altri idiomi di cui si è detto.
Il sodalizio fra Fabrizio De Andrè e Fernanda Pivano nacque intorno all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e portò all’album che a mio avviso è il suo più grande: Non al denaro, né all’amore né al cielo (1971). Pivano in alcune interviste disse che De Andrè, in alcuni casi, aveva fatto anche meglio del poeta statunitense. La critica milanese amava di certo le iperboli, ma in questo caso mi sento di condividere quello che afferma. De Andrè non traduce i testi ma li riscrive, rispettando solo il pilastro fondamentale su cui si regge l’opera di Masters: la riproposizione in chiave moderna della dantesca legge del contrappasso, fondata sulla similitudine piuttosto che sulla metafora. Per il resto compie un’operazione del tutto diversa e in una direzione opposta. Masters scrisse una commedia umana in versi, fondata sull’equilibrio fra il microcosmo (la piccola comunità di un paese) e il macrocosmo che consiste nella dilatazione delle vicende, delle tipologie umane fino ad abbracciare per intero quella comunità, ma anche alludere a un’infinità di situazioni diverse: il piccolo paese diventa così un’allegoria dell’umanità intera. Perciò l’Antologia è una narrazione epico-lirica, a tratti sapienziale, che ritorna sulle stesse situazioni e tipologie di personaggi più volte. De André, dopo l’omaggio a tutti i defunti della comunità nel brano di apertura (La collina), distilla al massimo, riducendo la sua opera a un solo testo emblematico per ogni tipologia e situazione: una scelta metonimica, che mantiene, anzi esalta, la similitudine e la legge del contrappasso. De Andrè riesce a tenere in tutto l’album un livello altissimo di tensione. Non vi sono brani minori in questo album, governato da una rigorosa unità di stile e di scelte. Per darne un esempio, dunque seguirò semplicemente il mio gusto, scegliendo un testo soltanto, che riprende uno dei temi più cari di De Andrè fin dal primo album: la diffidenza verso ogni forma di potere giudiziario:
Un Giudice
Cosa vuol dire avere/un metro e mezzo di statura,/ve lo rivelan gli occhi/e le battute della gente,/o la curiosità/d’una ragazza irriverente/che vi avvicina solo/per un suo dubbio impertinente://vuole scoprir se è vero/quanto si dice intorno ai nani,/che siano i più forniti/della virtù meno apparente,/fra tutte le virtù /la più indecente.//Passano gli anni, i mesi,/e se li conti anche i minuti,/è triste trovarsi adulti/senza essere cresciuti;/la maldicenza insiste,/batte la lingua sul tamburo/fino a dire che un nano/è una carogna di sicuro/perché ha il cuore troppo/troppo vicino al buco del culo.//Fu nelle notti insonni/vegliate al lume del rancore/che preparai gli esami/diventai procuratore/per imboccar la strada/che dalle panche d’una cattedrale/porta alla sacrestia/quindi alla cattedra d’un tribunale/giudice finalmente,/arbitro in terra del bene e del male.//E allora la mia statura/non dispensò più buonumore/a chi alla sbarra in piedi/mi diceva “Vostro Onore”,/e di affidarli al boia/fu un piacere del tutto mio,/prima di genuflettermi/nell’ora dell’addio/non conoscendo affatto/la statura di Dio.
La lingua fra poesia e musica
Uno dei leit motiv che la critica letteraria e anche i poeti rivolgono a chi pensa si possa dare un valore letterario ai testi delle canzoni dei maggiori autori, è che mentre la poesia avrebbe la musicalità incorporata nel testo, la canzone deve ricorrere a un artificio: la musica si pone come esterna e spesso prevarica il testo, piegandolo alle proprie esigenze ritmiche e sonore. Questo discorso è vero solo in parte o lo era quasi totalmente per il melodramma, quasi senza eccezioni. La canzone d’autore è nata e si è evoluta su altri presupposti. Gli autori più importanti padroneggiano entrambi i linguaggi, non ricorrono a parolieri, spesso sono autori anche di versi e raccolte poetiche (Dylan, Vincius de Moraes) e il problema è l’equilibrio che riescono a ottenere fra i due linguaggi: nel caso di De Andrè tale equilibrio è sempre presente nella sua produzione anche se non sempre gli esiti sono dello stesso livello. La scelta della Ballata come genere che può essere sia musicale sia poetico, lo favorisce in questo, almeno nei suoi album maggiori. Tuttavia egli stesso, parlando della propria musica, tenne sempre un profilo piuttosto basso, affermando per esempio che suo figlio Cristiano possiede una cultura musicale migliore della sua. Diamo per scontato un eccesso di affetto paterno in questa dichiarazione, ma è pur vero che De Andrè ricorse sempre a collaborazioni eccellenti. Vi è in ogni caso molta più coerenza, non solo tematica ma di stile, nei suoi testi che non nella partitura musicale assai eclettica, tanto da pensare che nel suo caso è proprio la musica a piegarsi alle esigenze del testo; vale allora la pena di guardarlo più da vicino.
Pur ricorrendo quasi sempre alla Ballata, De Andrè non sceglie l’ottonario (il verso per eccellenza della ballata come testo poetico), ma più spesso il settenario o l’alternanza fra settenari e novenari, tranne quando la scelta dell’ottonario è imprescindibile per ragioni di ritmo. In qualche caso il doppio settenario si alterna a novenari; raramente ricorre l’endecasillabo, ma piuttosto al verso di dieci sillabe della poesia inglese, aggiungendovi spesso un piede. Tutto questo non è casuale: la coerenza è alta e se in qualche caso, come ne Un giudice riportato più sopra, vi è qualche scostamento rispetto a tale norma in altri casi il rispetto è rigoroso. L’attenzione alla metrica da parte di De Andrè può essere colta anche nella rara presenza di endecasillabi, il verso d’eccellenza della poesia italiana ma che, spesso ridondante in sé anche sulla carta, lo sarebbe ancora di più se associato alla musica. Per chi pensa ancora anche la metrica sia casuale, suggerisco di scegliere uno o due testi fra i migliori di Mogol-Battisti e confrontarli con quelli di De Andrè. La casualità delle scelte nel primo caso è evidente, se ci sono righe che potrebbero far pensare a versi, ciò avviene per caso e perché il linguaggio è almeno in parte sempre ritmico e scandito, persino nei momenti più comunicativi: vado a fare la spesa è un settenario. In De Andrè c’è sempre la ricerca di una regola dalla quale si può scartare a volte (il ritmo musicale ha in suoi diritti e li fa valere), ma sempre dentro un contesto di ricerca di equilibrio fra i due linguaggi.
Lo stile, la voce, la pietas
Concludo con una riflessione su due testi che permettono di tornare alla radice più profonda di tutta l’opera di De Andrè: la pietas, che diventa un elemento portante del suo stile e che fu anche la strada maestra che lo portò lontano dalle secche dell’esistenzialismo. Il primo brano è ispirato dall’Antologia: Un chimico. Il secondo è Ho visto Nina volare da Anime salve.
Un chimico.
Solo la morte m’ha portato in collina
Un corpo fra i tanti a dar fosforo all’aria
Per bivacchi di fuochi che dicono fatui
Che non lasciano cenere, non sciolgon la brina
Solo la morte m’ha portato in collina
Da chimico un giorno avevo il potere
Di sposar gli elementi e farli reagire
Ma gli uomini mai mi riuscì di capire
Perché si combinassero attraverso l’amore
Affidando ad un gioco la gioia e il dolore
Guardate il sorriso guardate il colore
Come giocan sul viso di chi cerca l’amore
Ma lo stesso sorriso lo stesso colore
Dove sono sul viso di chi ha avuto l’amore
Dove sono sul viso di chi ha avuto l’amore
È strano andarsene senza soffrire
Senza un volto di donna da dover ricordare
Ma è forse diverso il vostro morire
Voi che uscite all’amore che cedete all’aprile
Cosa c’è di diverso nel vostro morire
Primavera non bussa, lei entra sicura
Come il fumo lei penetra in ogni fessura
Ha le labbra di carne, i capelli di grano
Che paura, che voglia che ti prenda per mano
Che paura, che voglia che ti porti lontano
Ma guardate l’idrogeno tacere nel mare
Guardate l’ossigeno al suo fianco dormire
Soltanto una legge che io riesco a capire
Ha potuto sposarli senza farli scoppiare
Soltanto la legge che io riesco a capire
Fui chimico e, no, non mi volli sposare
Non sapevo con chi e chi avrei generato
Son morto in un esperimento sbagliato
Proprio come gli idioti che muoion d’amore
E qualcuno dirà che c’è un modo migliore.
In questo testo la concatenazione di similitudini e la legge del contrappasso emergono limpidamente dal testo, senza scorie. Come sulla bilancia ideale di un chimico ogni elemento viene pesato e connesso con l’altro fino a costruire una rete di rimandi interni fittissimi; ma il testo può essere letto anche come una sequenza di immagini emblematiche, fino a quella davvero sorprendente dell’idrogeno che tace e dell’ossigeno che dorme al suo fianco. Sul richiamo dantesco vale forse la pena di dire che esso è rivolto del tutto all’al di qua, come del resto avviene anche nell’Antologia di Masters, ispirata da quella Palatina. I defunti di Masters e De Andrè hanno lo sguardo che ritorna al mondo come al tempo ritrovato dei propri errori, dei propri sogni e mancanze, senza alcun giudizio. La metrica sfrangiata del testo che oscilla fra rari endecasillabi e blank verse allungato rimane in equilibrio fra solennità del tema e un incedere che lo rende più leggero, come quei fuochi fatui di cui si dice nel primo verso.
Infine: Ho visto Nina volare:
Mastica e sputa/da una parte il miele/mastica e sputa/dall’altra la cera/mastica e sputa/prima che venga neve//Luce luce lontana/più bassa delle stelle/sarà la stessa mano/che ti accende e ti spegne//Ho visto Nina volare/tra le corde dell’altalena/un giorno la prenderò/come fa il vento alla schiena//E se lo sa mio padre/dovrò cambiar paese/se mio padre lo sa/m’imbarcherò sul mare//Mastica e sputa/da una parte il miele/mastica e sputa/dall’altra la cera/mastica e sputa/prima che faccia neve//Stanotte è venuta l’ombra/l’ombra che mi fa il verso/le ho mostrato il coltello/e la mia maschera di gelso./E se lo sa mio padremi metterò in cammino/se mio padre lo sa/m’imbarcherò lontano./Mastica e sputa/da una parte la cera/mastica e sputa/dall’altra parte il miele/mastica e sputa prima che metta neve.//Ho visto Nina volare/tra le corde dell’altalena/un giorno la prenderò/come fa il vento alla schiena.//Luce luce lontana/che si accende e si spegne/quale sarà la mano/che illumina le stelle./Mastica e sputa/prima che venga neve.
Vita e morte s’intrecciano e s’incarnano in immagini di grande suggestione. Il ruminare la vita, il distillare il miele eliminando lo scarto, il tempo che ci è concesso (prima che venga neve), l’immagine di Nina, evocata anche nella copertina dell’album, ma che si eleva a misteriosa allegoria. Infine quella stessa mano che accende e spegne. Anche in questo testo ogni elemento di cui è fatto il vivere viene pesato e soppesato, senza mai dimenticare che la materia con cui è fabbricato è spuria (come non ricordare che dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior), necessita di quel continuo masticare e sputare che lo raffina finché ne è capace. Pensando a queste due ultime canzoni, un’ultima notazione la lascio alla voce di De Andrè, una voce sempre in bilico fra recitativo e canto. È proprio quest’ultima a far risuonare, anche nei testi più aspri ed espressionisti, quella nota di pietas che affonda le sue radici in un mondo mediterraneo e pagano che De Andrè riscopre, seppure traducendolo nella sensibilità di un cristianesimo tutto suo.