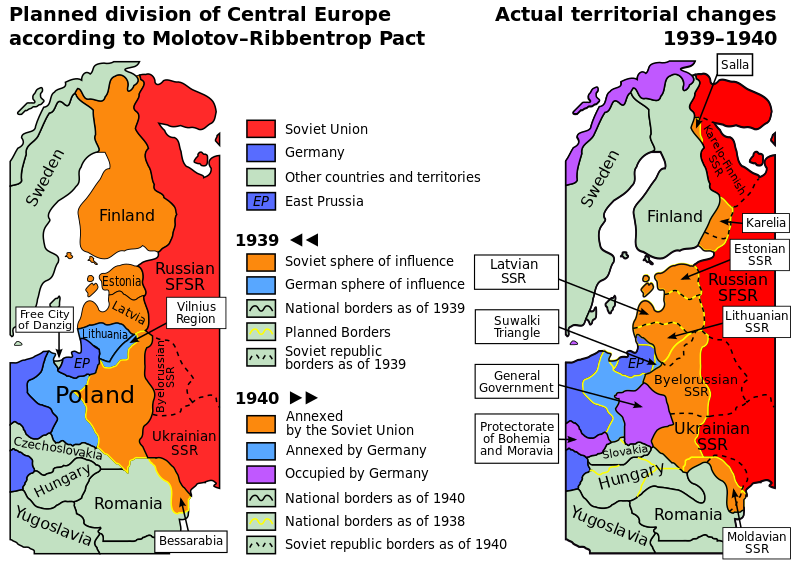INTORNO A PROMETEISMO E TRANSUMANISMO

Recentemente il termine prometeismo è tornato in auge insieme a un altro di conio più recente: Antropocene. In merito al primo termine, alcuni studiosi hanno proposto una lettura che, partendo dal mondo preistorico, individua due diverse forme di prometeismo: la prima volta alla distruzione l’altra positivamente orientata.1 Il quadro che ne esce, tuttavia, è altrettanto problematico, perché individuare due tendenze opposte (lo sdoppiamento) rischia di essere un’operazione d’inutile buon senso al punto in cui ci troviamo; così come il ripetersi a ogni occasione che la tecnologia può essere buona o cattiva e dipende da come la si usa. Rimanere dentro tale senso comune non può più aiutarci a comprendere il presente. L’emergenza climatica, il rischio di ripetersi di pandemie innescate dallo spillover, a sua volta agevolato dagli allevamenti intensivi, non permettono più di considerare il prometeismo nei suoi aspetti positivi, se non evidenziandone valenze diverse rispetto a quelle storicamente valorizzate, tutte incentrate sull’esaltazione della potenza. Ancor peggio, poi, se lo scontro fra le due tendenze viene accolto come una sorta di sfida fra due diversi titanismi. Il prometeismo è diventato un vicolo cieco, sebbene il mito da cui deriva e il personaggio Prometeo, meritino una riflessione assai più attenta a partire dall’opera di Mary Shelley a lui dedicata, Frankenstein, or the modern Prometheus. L’importanza dell’opera di Shelley sta nel mettere in scena un Prometeo che non vuole più dare agli umani gli strumenti per poter vivere meglio, ma vuole creare una seconda natura con le proprie mani. La differenza fra l’opera di Mary Shelley e le distopie proposte da altri autori, specialmente quelle che verranno scritte in pieno ‘900, è che lei è la sola a non manifestare alcun ammiccamento o collusione fascinosa con la tematica oggetto del romanzo. Il suo intento sono la denuncia e la paura, che non si ritrovano invece in molti romanzi successivi, in cui l’autore di fatto collude con la distopia che mette in scena e in alcuni casi addirittura esibisce in modo narcisistico il proprio cupio dissolvi. Pubblicata nel 1818, Shelley modificò in parte il romanzo nel 1831 quando uscì la seconda edizione: come tutte le storie gotiche ha alcune caratteristiche tipiche del genere letterario che possono fuorviare dal nucleo e dalla sua origine e cioè un incubo che lei ebbe a seguito di un gioco di società inventato da Byron e dalla sorellastra di Mary, Claire Clarmont. Il gioco consisteva nell’inventare fiabe e narrazioni di fantasmi, ma senza trascurare il fatto che fantasie scientifiche, scoperte reali e narrazioni horror – diremmo oggi – si mescolavano facilmente in molti ambienti in quegli anni. Mary Shelley, forse influenzata dalle scoperte dell’abate Galvani, sogna quello che sarà poi il tema centrale del suo romanzo: un uomo che assembla i pezzi di un altro essere fino a infondergli la vita. L’incubo la terrorizza e lei decide di scrivere proprio per liberarsene, ma la scelta di definire il professor Frankenstein come il moderno Prometeo pone il romanzo ben oltre il genere di appartenenza e per noi che siamo da tempo prigionieri di una commistione perversa fra capitalismo e Big Science, possiamo proiettare l’opera della scrittrice britannica nel futuro. La visione di una seconda natura ha in questo slancio prometeico e titanico al tempo stesso, le sue ragioni d’essere, le stesse che in parte abbiamo trovato anche nel Romanticismo e ancor più nella mitologia intorno al medesimo: gli anni sono quelli. Nel romanzo, la creatura mostruosa decide alla fine di darsi lei stessa la morte.2 Il Prometeo di Mary Shelley è la visione più potente dell’homo capitalistis e prometeico (uso l’espressione dandole anche un significato di genere) coniugato all’esaltazione delle tecnologie nella loro proiezione storica e forse non è un caso che a scriverlo sia stata proprio una donna. Si pensi al ruolo esponenziale delle protesi, alla robotica estesa fino a fare dei robot delle badanti e ora anche delle amanti come nelle più recenti declinazioni giapponesi. Si pensi alle visioni fra l’apocalittico e il fantascientifico di certi guru della Silicon Valley che vagheggiano la possibilità di superare per sempre la morte tramite l’ibernazione, le tecnologie di sostituzione degli organi, o la manipolazione del DNA, le fughe su astronavi alla ricerca di altri mondi in cui vivere.3 Il transumanismo coniugato all’onnipotenza tecnologica è l’estrema propaggine delle distopie e delle narrazioni apocalittiche attuali e non è un caso che nasca in ambienti anglo statunitensi, in una commistione perversa fra millenarismo, letture catastrofiche dell’Apocalisse di Giovanni e deliri tecnologici autodistruttivi. Sulle narrazioni tossiche contemporanee il libro Una vita liberata di Roberto Ciccarelli è quanto mai prezioso.4 In esso l’autore affronta in un capitolo specifico e qui e là nell’intero saggio, il significato attuale delle molte narrazioni catastrofico-apocalittiche che si sono susseguite, specialmente dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19. Il suo giudizio è netto: tali narrazioni tossiche confondono fine del mondo con fine di un mondo e si pongono come forme di falsa coscienza e rivoluzione passiva che trova tuttavia collusioni anche in chi critica l’ordine neoliberale. L’analisi di Ciccarelli quanto mai convincente per quanto mi riguarda, ha il merito fra l’altro di mettere in evidenza, seppure sotto traccia, come tali narrazioni nascano in un humus culturale definito, il medesimo peraltro in cui sono nate la maggiori distopie da un punto di vista letterario
Disastri veri e apocalissi fasulle
Nessun genere letterario è più anglo statunitense della distopia, ma ciò che è più interessante per il contesto oltre atlantico, è la commistione fra tecnologia, catastrofismo apocalittico, misticismo e pensiero empirista, che si riscontra anche in molti romanzi, ma che appartiene anche a una élite che fa parte di un establishment trasversale alle diverse presidenze Usa. Il grande modello o archetipo che sta alle spalle di molte narrazioni distopiche è proprio l’Apocalisse di Giovanni, sia nella versione etimologicamente corretta del termine e cioè di rivelazione e anche di missione messianica, sia in quello corrente di catastrofe. Il testo ha profondamente influenzato la cultura statunitense delle origini, sia nel senso proprio di rivelazione, sia nell’altro senso. Alcuni degli elementi fondanti di questa formazione discorsiva si trovano nell’esperienza empirica dei coloni puritani sbarcati nell’America del nord e sono riassumibili a mio avviso in alcuni punti, di cui i primi due sono i pilastri portanti e gli altri due il trascinamento sul suolo americano di formazioni discorsive nate in Europa: la predestinazione, il primato dell’individuo sulla società e la comunità, la natura come oggetto da asservire, la tecnologia e il calcolo come strumenti di tale asservimento.
La predestinazione.
Grazia e predestinazione alla salvezza sono una coppia importante e la seconda parola è una traduzione possibile dell’immagine dei Marcati e dunque dei salvi a priori che si trovano nell’Apocalisse di Giovanni. A questo si aggiunga il fatto che secondo il protestantesimo radicale di Calvino, è proprio il successo mondano uno dei segni possibili della grazia. Ora, se si pensa agli inizi dell’avventura coloniale, alle indubbie difficoltà nell’approdare in un luogo in parte sconosciuto, la capacità di resistere e di farsi largo in quel mondo (sto adottando provvisoriamente il loro punto di vista e non quello dei popoli nativi ovviamente) tutto questo poteva facilitare la convinzione di essere stati predestinati a una missione divina. L’idea più volte ripetuta in tutti i discorsi presidenziali statunitensi – più accentuata in quelli democratici – di una missione degli Usa nel mondo ha le proprie radici proprio in questa narrazione, che tuttavia ha nutrito anche un pensiero laterale democratico come quello, per esempio di Thoreau. Tale presupposto fondante, forse il più importante, non ha se non in minima parte le proprie radici in un pensiero genericamente illuminista, né deriva di per sé dalla concezione che ispirava i rivoluzionari francesi, ma costituisce già in origine una formazione discorsiva che ha obiettivi ben diversi, perché i due contesti sono diversissimi. I diritti dell’uomo e del cittadino nascono prima di tutto in contrasto con l’assolutismo, sono quindi diritti del cittadino singolo rispetto al dispotismo del sovrano e dell’aristocrazia, ma sono anche diritti del popolo e quindi della comunità, tramite il parlamento e il suffragio. Non è affatto vero che la filosofia di fondo che ispirava la prima carta costituzionale francese fosse quella di un individualismo esasperato. I suoi limiti erano di genere e di classe. Il contesto statunitense è totalmente diverso.
L’individualismo statunitense.
Quegli uomini (e il termine va preso alla lettera perché le donne erano escluse), erano già liberi, i nativi per loro erano solo selvaggi che non ponevano problemi di ordine giuridico e costituzionale e neppure morale – se non per alcuni – mentre aristocrazia e assolutismo se li erano lasciati alle spalle in Europa. L’idea di una preminenza dell’individuo sulla società e la comunità – parole che non uso per caso al posto della parola Stato – non è la traduzione americana dei diritti dell’uomo e del cittadino, ma piuttosto una formazione discorsiva nella quale confluiscono l’assolutizzazione di una concezione della salvezza che è solo individuale (tipica delle versioni più estreme del protestantesimo), un’idea d’individualità come misura di ogni cosa che ha una qualche radice nel solipsismo filosofico di Barkeley, sostenuta probabilmente anche sulla visione ingenua di un teismo che riconosceva nella vastità del territorio vergine e ricchissimo da conquistare e occupare un’immagine possibile del Paradiso Terrestre o almeno di quella prefigurazione della fine dei tempi e della tenda di dio in mezzo agli uomini di cui parla l’Apocalisse. Dicendola un po’ più alla buona: se c’è posto per tutti perché preoccuparsi della società? Che ognuno faccia di se stesso una società o la comunità che vuole, pianti la sua bandiera dove arriva, si armi fino ai denti, recinti la sua conquista per stabilire che quel territorio è di sua proprietà, al massimo estendendola alla famiglia, unica istituzione riconosciuta nel passaggio aldilà dell’Atlantico. Proprietà e famiglia – entrambe armate come sancito dalla costituzione degli Usa – sono gli ambiti sociali per eccellenza tutto il resto va soltanto limitato nei suoi poteri.
La natura da asservire.
Non è ovviamente una prerogativa statunitense ma di tutto il pensiero occidentale, almeno da un certo momento in poi; tuttavia, nel passaggio al nuovo continente essa si radicalizza e una delle ragioni sta proprio nella vastità del territorio. Poche parole sono necessarie in questo caso: la narrazione della frontiera e dell’espansione verso ovest parla da sola ed è in realtà una narrazione che nega l’esistenza della frontiera e cioè del limite. Infatti, non appena ultimata la conquista, non appena finite le guerre indiane, l’espansione a occidente si tramuterà nel giro di pochi anni in una attitudine imperiale (uso il termine in alternativa a imperialismo che significa altro) e aggressione agli stati vicini (la guerra ispanica del 1888). Per apprezzare meglio il passaggio che riconnette mistica e tecnologia, invece, mi servirò di un libro dello storico statunitense David Noble, intitolato La religione della tecnologia: divinità dell’uomo e spirito d’invenzione. Scelgo questo libro perché è una raccolta di citazioni molto importanti intorno a questa tematica, per cui il lettore non deve fare la fatica di andarsele a cercare. Non sempre le tesi conclusive e le deduzioni di Noble sono accettabili e talvolta troppo ingenue, Più sociologo che filosofo Noble tende alla fine a una visione troppo parziale, però la mole di materiali che egli ha raccolto è indubbiamente impressionante. Mi servirò del suo libro in questo senso cercando però di inserirlo in un quadro più ampio di quanto non faccia il sociologo statunitense. Noble parte da un’osservazione empirica che viene dalla lettura dei testi sacri: come la tecnologia sia stata considerata, dal Medioevo in poi, un’arma affidata dal dio cristiano ai fedeli per combattere il male. Questo vale sia per le tecnologie agricole messe a punto dai monaci benedettini, ma anche per le armi con cui combattere gli infedeli, come si evince da questa citazione tratta dal Salterio di Utrecht:
I malvagi si accontenteranno di usare un’affilatrice di vecchio stampo; i devoti invece … la prima manovella usata fuori dalla Cina e applicata alla prima mola conosciuta al mondo. Ovviamente l’artista vuole dirci che il progresso tecnologico è volere di Dio.
Non solo i padri della Chiesa come Agostino, ma anche eretici o mistici visionari quasi all’indice condividono questo pensiero: da Gioacchino da Fiore a Raimondo Lullo. Nella seconda parte del libro, intitolata Tecnologie della trascendenza, il libro di Noble affronta il nesso fra tecnologia, potere politico e millenarismo nella contemporaneità ed è qui che entra in scena Hume. Perché, fino a tutto il Medioevo, l’ipotesi di una tecnologia al servizio di dio piuttosto che dei malvagi, si ammanta solo di espressioni metaforiche e in fondo abbastanza ingenue. Quando però tale pretesa diventa calcolabile e si ammanta di oggettività tecnologica assurta a verità teologica, essa produce degli effetti che nei successori, atei o credenti che siano, porta alle aberrazioni qui di seguito. Secondo Edward Fredkin, vi sono stati tre grandi eventi di uguale importanza nella storia dell’universo. Dopo aver detto che il primo è la creazione stessa dell’universo e il secondo l’apparire della vita, eccoci al terzo:
Penso che la nostra missione sia quella di creare l’intelligenza artificiale, è il prossimo passo dell’evoluzione.
Sempre più preso dall’entusiasmo il nostro si domanda addirittura come mai dio non ci abbia pensato lui a crearla. Ma chi è Fredkin? Ovviamente uno scienziato che si occupa di intelligenza artificiale, ma anche un consigliere di diversi presidenti. Ma c’è di più. Nel capitolo viii del libro di Noble, dal titolo significativo “Armageddon, la battaglia finale: le armi atomiche”, Noble cita scienziati e politici anglo statunitensi, che sembrano parlare come mistici invasati, ma dotati appunto di un potere tecnologico immenso. Una sola citazione per tutte:
La bomba atomica è la buona novella della dannazione.
Mi sono chiesto cosa ci sia dietro questo narcisismo della distruzione che alberga nella cultura anglo-americana come in nessun’altra e che ritroviamo puntualmente anche nelle distopie. Nel caso della citazione finale forse la chiave di comprensione diventa assai semplice. Una mondità del tutto affidata al caos, alla legge del più forte e senza alcuna speranza di salvezza e redenzione, alla lunga diventa insopportabile anche per chi la persegue: il mito di Armagheddon e cioè la lotta finale e definitiva fra il bene e il male quanto prima arriva tanto meglio è: ciò giustifica ampiamente il paradosso di una buona novella della distruzione: un vero e proprio corto circuito che chiude il cerchio e che spiega anche l’eclatante deriva complottista e negazionista – prima del Covid e poi del voto – che ha avuto come protagonista addirittura un presidente eletto. Questa miscela esplosiva di razzismo, deliri tecnologici e pseudo misticismo è nel Dna dell’uomo bianco statunitense fin dalle origini. Non bisogna farsi illusioni sulle intenzioni dell’establishment nordamericano. La politica estera statunitense conosce solo due principi: Carthago delenda est e Vae victis, perché senza nemico esterno, il suo fronte interno si disgregherebbe subito, la guerra civile e le spinte secessioniste sono sempre latenti in ogni momento della sua storia. Il problema non è se potranno cambiare, ma se potranno continuare a farlo oppure no. Come per tutte le distopie, infatti, non è detto che riescano a trionfare; anzi, fanno di certo molti danni ma alla fine non trionfano.

1 Il primo studioso a proporre una definizione specifica per l’era in cui la Terra è massicciamente segnata dall’attività umana fu il geologo Antonio Stoppani nel 1873. Successivamente il geochimico russo Vernadskij definì il periodo col termine di noősphera (ossia mondo del pensiero) per sottolineare il potere crescente della mente umana nel modellare il suo futuro e l’ambiente; lo stesso termine venne usato dal paleontologo e pensatore cattolico Teilhard de Chardin. Nel 1992, Andrew Revkin ipotizzò la creazione di una nuova epoca geologica chiamata Antrocene. Il termine fu diffuso negli anni ottanta dal biologo naturalista Eugene F. Stoermer e adottato successivamente da Paul Crutzen. Successivamente Crutzen formalizzò il concetto in opere quali l’articolo Geology of mankind, apparso nel 2002 su Nature e il libro Benvenuti nell’Antropocene. Per quanto riguarda invece il termini prometeismo, mi riferisco ad alcuni saggi comparsi in Sinistra in rete. Riporto il nome degli autori di alcuni di essi: Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli con un articolo dal titolo L’assalto al cielo, Bellamy Foster – La dialettica della natura di Engels e l’antropocene; infine ancora Burgio, Leoni e Sidoli con Homo Prometeous e marxismo prometeico.
Due libri recenti, il primo scritto congiuntamente da David Graeber e da David Wengrow – L’alba di tutto – e il secondo del solo Graeber – Il debito i primo 5000 anni – sono decisivi nel proporre uno sguardo diverso dalle narrazioni correnti anche sul tema del prometeismo.
2 Figlia di Mary Wollstonecraft e di William Godwin, cresciuta in un ambiente ricco culturalmente e dove l’emancipazione femminile era considerata un valore, Mary Shelley, ha avuto un ruolo importante nella cultura di quegli anni. Il modo in cui termina il suo romanzo è governato dalla pietas, un sentimento che la distanzia ulteriormente da ogni forma di ammiccamento e titanismo, anche involontari. La scelta della creatura mostruosa di darsi lei stessa la morte sta all’opposto del nichilismo e suona come una denuncia delle pretese del suo creatore. Una eco di questa soluzione a me sembra sia stata ripresa nel primo Blade runner e precisamente nell’episodio finale della morte del replicante con il suo celeberrimo monologo. Quanto alla ricezione della sua opera presso di noi, fino al 1970 è stata principalmente conosciuta per l’apporto che ha dato alla comprensione e alla pubblicazione delle opere del marito e per il suo romanzo, che ebbe grande successo e ispirò numerosi adattamenti teatrali e cinematografici. Studi recenti hanno però permesso una più profonda conoscenza del profilo letterario di Mary Shelley; in particolare, questi studi si sono concentrati su opere meno conosciute dell’autrice, tra cui romanzi storici come Valperga, romanzi apocalittici come L’ultimo uomo. Altri suoi scritti meno conosciuti, come il libro di viaggio A zonzo per la Germania e l’Italia contribuirono a fare di Mary Shelley l’esponente di una politica radicale, ma anche in opposizione agli ideali romantici ma individualisti che ispirarono in particolare William Godwin. La sua istanza politica era molto più indirizzata nel senso della cooperazione sociale, distanziandosi così sia dal padre sia da Percy Bessie Shelley.
3 Gli articoli e le interviste a manager, esponenti a vario titoli delle più importanti major statunitensi della Silicon valley sullo sfidare la morte, sono continue. Il Sole 24 ore ha pubblicato diversi articoli al proposito, ma è sufficiente aggirarsi nella rete per trovare tutto quello che serve per informarsi. Citarne una o l’altra non ha molta importanza. Riporto soltanto l’indicazione di questo articolo dell’Huffington Post: https://www.huffingtonpost.it/2017/01/26/miliardari-silicon-valley-preparano-per-apocalisse_n_14413104.html
4 Roberto Ciccarelli, Una vita liberata Derive Approdi, Roma 2002.