OLTRE IL NULLA, VIVERE POSTUMI! CATASTROFE E DESIDERIO IN CORMAC McCARTHY. Prima parte

Premessa
IN MEMORIA DI CORMAC MCCARTHY
La sintassi cinematografica come stile
Nella Trilogia della Frontiera – Oltre il confine, Cavalli selvaggi, Città della pianura – McCarthy inizia il suo corpo a corpo con la cinematografia e lo fa rendendo feroce e prosaica l’epopea del West, attaccando dunque la rappresentazione edulcorata fornita dal cinema hollywoodiano, con una parola che descrive fino al dettaglio più crudo, come avviene in questo passaggio tratto da Meridiano di sangue:
A ciascuna di quelle piccole vittime, sette anzi otto, era stato fatto un buco nella mandibola ed erano stati appesi per la gola ai rami spezzati di un mesquite. Fissavano senza occhi il cielo nudo. Calvi e pallidi e gonfi, come larve di un essere inimmaginabile…”. 1
Vi è un personaggio chiave che riassume in sé tutti gli altri della trilogia: quello del giudice, sempre in Meridiano di sangue.
Egli è un uomo che può infarcire i suoi discorsi di citazioni letterarie, addirittura tratte dai Vangeli o dalla Bibbia e che guarda il mondo degli umani dall’alto, come un eroe tragico dell’antichità. In realtà, è un capobanda che raduna intorno a sé, sbandati di ogni genere. Ambientato nella seconda metà dell’800, nella zona di confine fra Usa e Messico, il romanzo si basa su un ampio corredo di documenti ufficiali. Le azioni compiute della banda non servono alcuna causa, sono semplicemente l’espressione di una crudeltà che non ha scopi e non ne vuole avere, se non quello del proprio potere sadico sugli altri e del bottino. La conquista della frontiera diviene qui un puro avanzare e saturare lo spazio, occupare il territorio, distruggerne ogni cultura precedente, a cominciare da quella dei nativi, fondarvi una legge che coincide e s’esaurisce soltanto nella quantità di violenza e di terrore che è in grado di sprigionare 2
Vi è un secondo modo altrettanto importante di rapportarsi al cinema: la scelta stilistica di asciugare il più possibile il linguaggio, depurandolo da ogni effetto speciale per raggiungere un registro anti eroico, ma diversamente epico. Il brano che segue è tratto dal primo dei suoi romanzi, Il buio fuori:
“Ormai intorno al carro si accalcavano diverse centinaia di persone, e tutti parlavano in un brusio crescente. Il sole era esattamente sopra di loro. Sembrava appeso lassù in un’abbagliante immobilità, come se si fosse fermato, forse sorpreso di vedere ancora sulla terra quei pupazzi di fango che ci erano stati messi tanto tempo prima. Gli uomini sulla passerella avevano cominciato a sfilare davanti alla porta, qualcuno in punta di piedi, per andare a vedere i resti nel cassone del carro.”3
In questa scena, una prima protagonista è la folla di uomini e di donne che s’avvicina a un carro, sul quale è successo qualcosa; è la situazione tipica che si crea dopo un incidente, oppure sulla scena di un delitto. Il secondo protagonista è il sole. Esso è appeso, abbagliante, immobile, sorpreso. Ognuno di questi aggettivi, anche i due più apparentemente ovvi come il secondo e il terzo, non lo sono affatto se consideriamo l’intera sequenza. L’ultimo, inoltre, accoppiato al primo, fa scattare una dilatazione di senso. Il sole può essere appeso e sorpreso soltanto se diventa metafora e questo si chiarisce meglio nel prosieguo del brano, laddove prende vita una doppia metamorfosi. La prima è quella di cui è oggetto, implicitamente, il sole stesso, la seconda riguarda le centinaia di persone. Questa doppia trasformazione, da sole a dio e da persone a pupazzi di fango, crea un corto circuito. Il sole, scrive McCarthy, era esattamente sopra di loro. Questa ulteriore descrizione chiarisce meglio perché esso è appeso. Chi può vedere in questo modo e da dove si può vedere in questo modo? L’esperienza di essere esattamente sopra gli altri, a meno di non ritenersi dio stesso, presuppone che esistano, le alte torri, i grattacieli e le macchine da presa appese al loro cavalletto. Il sole-dio, in realtà, è dunque un sole-dio-torre-macchina da presa; quest’ultima riprende dall’alto tutta la scena, come avviene in un set cinematografico. La moltitudine che s’avvicina al carro, invece, è fatta di uomini-pupazzi di fango.
L’asimmetria accentua l’ironia, implicita nel designare la specie umana con un’espressione che ci riporta al testo biblico. Se, infatti, natura (il sole) e tecnica (la macchina da presa come espressione moderna della capacità umana di costruire protesi e utensili) possono mutare e mostrarsi sempre in ogni tempo storico con eguale potenza e come sfingi indecifrabili che osservano dall’alto – al pari di dio – le vicende umane, cioè i pupazzi di fango rimangono quelli che sono ed erano. L’unica differenza percepibile fra natura e sviluppo della tecnica (dalle torri alla macchina da presa), è l’immutabilità dei processi che le riguardano, prerogativa quest’ultima che entrambe spartiscono con la divinità.
Cosa vogliono rappresentare queste poche righe così intense e dense? Un dio stanco degli esseri umani o una semplice trasposizione della finzione letteraria del narratore onnisciente ottocentesco nei nuovi abiti di una macchina da presa totalizzante? Fatto sta che questo brano così apparentemente semplice ci svela da subito (siamo all’inizio del suo percorso letterario), uno degli elementi costitutivi della cifra stilistica di Cormac McCarthy: il suo particolare rapporto con l’immagine e con il cinema.
Naturalmente ci sono altri aspetti decisivi, qui già in atto, che il romanziere riprenderà in ogni sua opera: la reciproca indifferenza fra natura e storia, dove la prima è una sfinge (il richiamo a Leopardi è d’obbligo), risplende spesso di una bellezza abbacinante e vive di una vita propria di cui anche gli esseri umani fanno parte, ma – si direbbe – non più in una posizione privilegiata.
Nello stesso romanzo, alcune pagine più avanti abbiamo una seconda modalità stilistica che si richiama al cinema:
Prenditi un sedia, la invitò una donna.
Grazie.
L’altra era presso la stufa, e attizzava il fuoco rivoltando le ceneri grigie e smorte. Non sei sposata? Chiese.
No signora.
…………..
Dov’è tuo figlio?
Come?
Ho detto dov’è tuo figlio.
Non ne ho.
Il bambino, il bambino cantilenò la vecchia.
Non c’è nessun bambino.4
Le peculiari caratteristiche di questo dialogo balzano subito all’occhio: mancano le virgolette che solitamente delimitano un dialogo dall’altro. Le parole delle due donne scorrono in contemporanea alle azioni compiute dalla terza donna che si trova nella stanza. Movimento e parola non possono essere scisse l’una dall’altra, la loro mescolanza e la contemporanea eliminazione di quasi tutti gli accorgimenti più propriamente specifici della scrittura narrativa, alludono ancora una volta al cinema e anche, nel caso specifico in modo più evidente, trattandosi di una scena che avviene in un interno, al teatro rappresentato sul palcoscenico.
Se la scrittura narrativa di McCarthy è fin dalle origini impregnata di teatralità e di suggestioni cinematografiche, corre subito l’obbligo di dire in che modo lo sia, tema assai rilevante dal momento che anche molta narrativa contemporanea, specialmente italiana, s’ispira abbondantemente alla tecnica cinematografica5.
Come abbiamo visto McCarthy inizia il suo percorso ripensando al mito della frontiera, sfidando perciò il cinema statunitense proprio sul genere western, il più hollywoodiano per definizione, ancorato inoltre a quel segmento della storia degli Usa che affonda le sue radici in un mito tipicamente moderno.
In secondo luogo McCarthy accoglie della grammatica e della sintassi del cinema tutto ciò che può rendere ancora più essenziale la scrittura, togliendole ogni orpello non necessario o di gratuito ammiccamento al lettore.
Basta questo per indicare la differenza che separa il suo modo di accostarsi al cinema rispetto alla deriva contemporanea, dove si cerca d’imitarne gli effetti speciali.6 La Trilogia trova in due altre opere un completamento e uno spostamento al tempo stesso. La prima, Sunset limited, è più o meno contemporanea a La strada (mi riferisco alla stesura non alla data di pubblicazione in Italia delle due opere). La seconda, ma in realtà precedente, è Suttrie, del 1979.

Sunset limited è un’opera teatrale che ha come protagonisti un bianco (nichilista) e un nero, che lo ha appena salvato da un tentativo di suicidio sotto il treno Tramonto limitato, traduzione letterale e quanto mai significativa del titolo inglese.
Suttrie, invece, è il nome di un uomo che, dopo avere abbandonato una vita borghese di agi e anche i suoi tormenti religiosi, decide di vivere in riva a un fiume, in una capanna abbandonata. La sua compagnia sono gli animali che abitano il corso d’acqua e i suoi dintorni; non quelli più domestici, bensì i più primitivi: insieme a loro una pletora di sbandati di ogni tipo, compreso il buffo, paradossale e strampalato Harrogate, una figura a metà strada fra animalità selvaggia e umanità, che riecheggia nel nome la parola Arrogance. Nel fiume, nei suoi detriti, in coloro che ne abitano le sponde, sembra riversarsi, come in un grande lavacro, tutta l’epopea americana. Alle origini della narrativa statunitense troviamo infatti un fiume, Il Mississipi quello su cui Hukleberry Finn compie le sue avventure e diventa adulto. Huck Finn è il romanzo di formazione per eccellenza dei coloni bianchi ed è certamente un romanzo solare e aperto, sul futuro positivo, di chi ha un mondo davanti a sé da esplorare. Da questo mondo erano naturalmente esclusi i neri e i nativi. In Suttrie sembra compiersi un destino: il fiume non è più fonte di vitalità ma piuttosto un rifugio e una discarica.
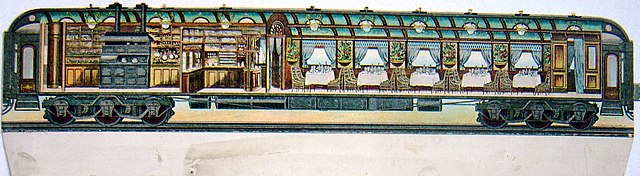
Con i romanzi Questo non è un paese per vecchi e successivamente con La strada McCarthy abbandona il West e compie un balzo temporale di duecento anni. Il primo dei due, tuttavia, non riesce a mio avviso nell’intento perché troppo didascalico: la trasposizione del paradigma della crudeltà dalla conquista dell’ovest all’America contemporanea risulta un po’ forzata, espressione di una tesi troppo precostituita, anche se plausibile da un punto di vista sociale.
1 Cormac McCarthy Meridiano di sangue, traduzione di Einaudi, Torino
2 Con il giudice, lo scrittore crea con lui un personaggio anti eroico, ma individuando una strada radicalmente diversa da quella seguita da larga parte della narrativa novecentesca europea. Quest’ultima, infatti, ha cercato fino all’estenuazione l’irrisione e la parodia: ha sì smitizzato l’eroe, ma ha finito per rinchiudersi nella dimensione di un disperato nichilismo, a volte sarcastico, più spesso semplicemente irridente.
3 Cormac McCarthy, Il buio fuori, traduzione di Raul Montanari, Einaudi, Torino 1999, pp. 73-4
4 Op. cit.pag.96.
5 Per un lungo periodo di tempo dopo la sua nascita, la settima arte ha saccheggiato la letteratura, facendo di alcuni grandi romanzi, il soggetto ideale per sceneggiature e film. Per alcuni di essi si è trattato di una vera e propria apoteosi: sono diciannove (otto delle quali in Italia), le pellicole che hanno per soggetto I miserabili di Victor Hugo, per non parlare di Guerra e pace, di Anna Karenina, dei Promessi sposi. La narrativa, maggiore o minore che fosse (pensiamo anche a I tre moschettieri, Il conte di Montecristo, La cittadella ecc. e così via), è stata un serbatoio inestinguibile. La televisione, quella italiana con la gloriosa tradizione degli sceneggiati, curati da registi di prim’ordine e attori altrettanto prestigiosi, fu in passato uno strumento d’indubbia promozione del gusto letterario, nutrendo una generazione intera e influendo anche sulla vendita dei libri. Era abbastanza normale, poi, per i registi, rivolgersi agli scrittori per le sceneggiature. Tutto questo fino alla fine degli anni ’60. Dal decennio successivo in poi si assiste a un movimento in senso contrario, che raggiunge in tempi recentissimi il suo culmine. È il romanzo a rifarsi sempre più spesso al cinema e sono sempre più rari invece i registi che collaborano con scrittori: le coppie Cerami-Benigni e Handke-Wenders sono eccezioni, quello di Cristina Comencini, scrittrice e regista, un altro caso a sé. Il primo in Italia a scrivere un romanzo con una tecnica molto vicina, forse troppo, alla sceneggiatura, fu Pasolini, con Teorema, nel 1969. Lo stesso Pasolini, con Petrolio, si accingeva ad approfondire quella strada con ben altra consapevolezza, purtroppo interrotta tragicamente dal suo assassinio. Anche il nouveau roman francese, tuttavia, in anni precedenti, si era avvicinato al cinema. L’ècole du regard si poneva, infatti, come una poetica capace d’influenzare sia la narrativa sia la tecnica filmica: Jean-Luc Godard fu al tempo stesso un convinto assertore di quella poetica, ma anche colui che la sviluppò portandola fino all’esasperazione. Anche certe descrizioni estranianti del primo Le Clézio risentono di tali influenze e lo stesso si può dire del Calvino di Palomar. La narrativa di McCarthy rientra in questo percorso di avvicinamento al cinema, senza per questo ipotizzare un’influenza diretta da parte dell’ècole du regard o altri su di lui, anche perché i segni distintivi che lo rendono diverso sono troppo forti e decisivi.
6 Non parlo dei prodotti più dozzinali e di consumo che poco hanno a che vedere con la scrittura letteraria, mi riferisco, come esempio, a un solo romanzo altrettanto recente perché fra tutti è certamente il più dignitoso e il suo autore uno scrittore fra i migliori della sua generazione: il primo capitolo di Caos calmo di Sandro Veronesi. Il crescendo che lo contraddistingue sembra essere preso di sana pianta dalla sequenza di venti minuti del primo Indiana Jones (non ha alcun’importanza che i temi siano diversi, anzi è un’aggravante.) L’effetto di tale ritmo incalzante sul lettore è quello di togliergli sì il fiato, ma arrivati alla fine, l’insieme dei fatti narrati, la concatenazione degli stessi, assomiglia troppo al cliché del film d’azione e questo toglie tragicità alla morte di Lara, con cui il capitolo si conclude. Ne abbiamo viste a iosa di queste sequenze, ciò che conta è il paradigma. In Indiana Jones, dopo una serie di fughe, ammazzamenti, colpi di scena, acrobazie d’ogni genere, citazioni d’altri film, quando tutti sono finalmente sull’elicottero, accade che un finto serpente ricrei un momento di tensione ulteriore; si tratta, però, di uno scherzo (come se fosse normale scherzare in quel modo dopo una decina d’ammazzamenti e quant’altro), che getta una luce ironicamente retrospettiva su tutto ciò che è stato visto in precedenza. Era tutto uno scherzo, non soltanto quella parte finale, siamo dentro i recinti prestabiliti del genere avventuroso e con quella scena Spielberg ce lo ricorda; infatti, egli non vuole certamente proporci un film tragico. Veronesi, invece, lo vorrebbe, ma la sequenza è talmente sovraccarica di colpi di scena che essa alla fine risulta tragicamente falsa, un escamotage che serve a traghettare il lettore verso il secondo escamotage: la scelta di Paladini, che decide di vivere nella sua automobile parcheggiata davanti alla scuola della figlia Claudia. Da questo secondo escamotage, si approda al terzo, (l’incontro con la donna salvata in mare, con prevedibile scena di sesso in differita.) Nel mezzo si ha la sensazione che il romanzo proceda solo in attesa della scena madre successiva e che gli altri incontri, molti dei quali scontati peraltro, servano a riempire un vuoto.