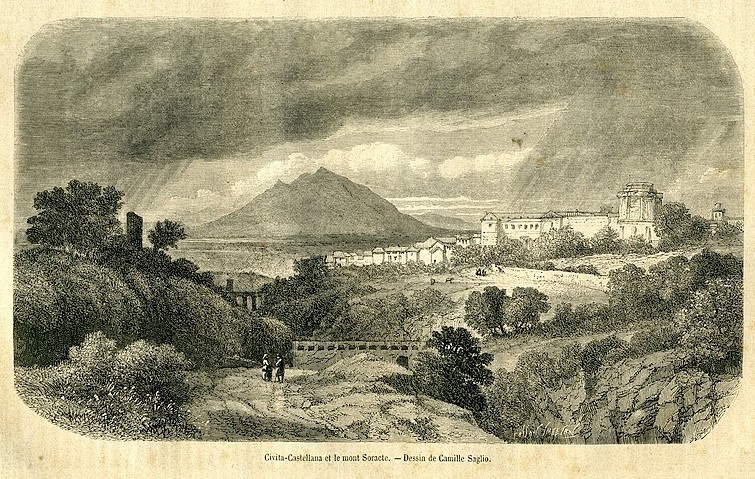DIARIO BERLINESE: SECONDA PARTE

26 Settembre 2010.
Il ritorno a Berlino coincide questa volta con il primo giorno di scuola. Mi sono iscritto a un corso di tedesco. Arrivato ieri mi ritrovo oggi catapultato in un’aula insieme ad altri e altre giovani, ben più giovani di me. Infatti mi guardano con curiosità. Proprio durante la prima mattina ho avuto l’ennesima conferma che Berlino è un luogo del tutto particolare anche per i tedeschi. La nostra insegnante, di Monaco di Baviera e assai severa in tema di regole sociali, almeno all’apparenza, ci ha raccontato un aneddoto molto comune i Germania. Quando in una famiglia ci sono un figlio o una figlia un po’ matti (verrükt), che non vuole dire semplicemente pazzerellone, ma qualcosa di più (in italiano potrebbe stare per trasgressivo, senza regole o anche matto), i genitori e specialmente le madri lo apostrofano così: “Figlio mio, tu sei pazzo, devi andare a Berlino.”
In effetti la città ha goduto di privilegi assai significativi, specialmente per la popolazione giovane e che hanno contribuito ad attirare verso di essa, uomini e donne ribelli. Una misura per tutte: chi si trasferiva a Berlino era esentato dal servizio militare. Berlino era una città assediata anche dopo la fine del blocco sovietico: il suo ripopolamento però era necessario per cui occorreva incentivarlo con misure e bonus di varia natura. Questo favorì il trasferimento nella città di oppositori trasgressivi di ogni tipo. Le occupazioni dei centri sociali erano più che tollerate e costituivano una sorta di welfare aggiuntivo per chi arrivava in città. Tutto questo rese appetibile Berlino anche per molti giovani europei e questo ne faceva una città che agli occhi di molti tedeschi appariva senza regole.
7 Ottobre
Ieri sera il canale di storia ha mandato in onda un lunghissimo servizio unico nel suo genere e che finora non avevo visto neppure qui. Si tratta di una ricostruzione degli ultimi mesi di Guerra, dal febbraio del ‘45 fino al 9 maggio, data in cui l’Ammiraglio Donetz firmò la capitolazione della Germania senza condizioni. Niente di strano fin qui, solo che la ricostruzione storica era giorno per giorno! Il materiale cinematografico, in larga parte di fonte americana, era basato sia su documentazioni giornalistiche di inviati al fronte al seguito delle truppe, sia da filmati di cine operatori improvvisati, soldati stessi incaricati dagli ufficiali. Un materiale dunque diversificato: a volte s’intuiva una totale assenza di regia, in altri casi il contrario, una regia molto sorvegliata che aveva lavorato di tagli e montaggio in modo assai raffinato. L’accompagnamento di voce, sempre in tedesco, faceva pensare a un lavoro d’equipe successivo, anche se ogni tanto il commento fuori campo era in inglese e poi veniva tradotto. Se ne deduceva in generale che la parte tedesca avesse accettato del tutto tale documentazione ritenendola fedele in linea di massima ai fatti. Il mio giudizio di spettatore è assai problematico. Difficile valutare la natura dei tagli: non tanto perché la regia edulcori la guerra dal momento che ne mostra tutti gli orrori seppure senza indulgere in immagini che oggi definiremmo pulp, se non in rarissimi casi. Non trascura di mostrare atti di violenza gratuita da parte delle truppe alleate, anche verso soldati che si erano già arresi. L’effetto generale però appare sconcertante perché filmare ogni giorno di guerra dal febbraio rivela anche un atteggiamento un po’ maniacale. Tre particolari mi hanno colpito e in attesa di vedere le prossime puntate nelle prossime sere. L’assenza di scene di massa all’arrivo delle truppe americane come invece avveniva in Italia, il profluvio di bandiere bianche in segno di resa, sventolate non solo dalle truppe che si arrendevano, ma anche dalla popolazione civile; infine le poche immagini di campi di concentramento. Una sola scena inquadrava i morti accatastati e magrissimi che ci siamo abituati a vedere in altre immagini della Shoah. Naturalmente può essere che trattandosi di materiali mostrati molti anni dopo, la selezione abbia tenuto conto di molti altri documentari, ma se rimaniamo al discorso della presa diretta, si rimane lo stesso perplessi; ma per dare un giudizio definitivo su questo aspetto, attendo che il filmato arrivi a Buchenwald, il solo campo collocato nella parte ovest della Germania,
8 Ottobre.
L’uso della bandiera bianca in segno di resa da parte della popolazione civile, continua a sconcertarmi. Difficile da interpretare. Da un lato potrebbe significare che nell’avanzata delle truppe città per città e con i combattimenti strada per strada era difficile distinguere fra soldati e civili asserragliati nelle case, per cui tutti dovevano considerarsi in qualche modo belligeranti e quindi bersagli potenziali. Questo però contrasta con un altro particolare. L’avanzata delle truppe anglo-americane in territorio tedesco, pur lentissima, non sembra essere stata contrastata più di tanto dopo il fallimento della controffensiva tedesca a ridosso dei confini con Belgio e Olanda. Le scene mostravano interi plotoni che si arrendevano, quelle che hanno filmato veri e propri combattimenti sono poche. O i tagli sono stai fatti in modo tale da non riprendere la resistenza dell’esercito tedesco ai fini di mostrane la rotta più di quanto non fosse, oppure le cose sono andate davvero così, la tenuta della Wehrmacht fu poca cosa; ma questo non spiega (da un punto di vista militare), la lentezza dell’avanzata in territorio tedesco. L’unica supposizione è che ci fosse un accordo con l’Unione Sovietica per cui le truppe anglo americane non dovessero superare certi confini e specialmente lasciare alle truppe sovietiche il compito di entrare a Berlino. Yalta c’era già stata e la famosa mappa consegnata da Churchill a Stalin, con i confini d´Europa già tracciati e definiti quanto a sfere di influenza, era stata vistata dal leder sovietico con un certo entusiasmo, anche se poi – alla richiesta del leader britannico di esserne lui il custode – l’astuto georgiano aveva opposto un cortese rifiuto.
9 Ottobre.
Oppure la spiegazione è un’altra e cioè che quella porzione di popolo tedesco mostrata dai vincitori, doveva apparire sconfitto come i soldati: in altre parole, i tedeschi tutti erano schierati con il regime e dunque alzavano la bandiera bianca in segno di resa perché si sentivano soldati come chi effettivamente combatteva. In effetti, i volti dolenti e sconfitti della popolazione avevano la stessa espressione delle truppe in divisa che tenevano le mani alzate. Un popolo dunque compatto che si sente partecipe della stessa sconfitta? Solo in una scena si vedono tre donne sorridenti che sventolano la bandiera bianca e che sono del tutto felici di vedere apparire le truppe alleate. Se tagli ci sono stati, eliminando del tutto le scene di entusiasmo così comuni in Italia è evidente che le ragioni andranno cercate non nella Guerra in corso, ma nel disegno del dopo. Accreditare del tutto l’asservimento del popolo italiano al Fascismo era impossibile perché la Resistenza era stata troppo forte per permetterlo: gran parte delle città erano state liberate prima dell’arrivo dei liberatori. In Germania le cose andarono diversamente ma oggi sappiamo anche che ci sono forti indizi che andarono così anche perché fu cancellata la memoria della resistenza tedesca, che pure vi fu, sebbene minoritaria in Germania ma niente affatto residuale nel resto d’Europa. 2000 disertori tedeschi hanno combattuto nella Guerra di Spagna e altri combatterono nelle resistenze europee e anche in Italia e in Unione Sovietica. Per accreditare il mantra della colpa collettiva del popolo tedesco bisognava mostrane il volto dimesso della sconfitta, le bandiere bianche in mano alla popolazione civile, significavano anche questo. Il resto fu cancellato in fretta e su di esso fu imposto il silenzio. Che Buchenwald fosse stato liberato dalla popolazione locale e dagli insorti del campo stesso è stato cancellato per decenni dalla storia tedesca, mentre è stata accreditata e alquanto sopravvalutata una presunta resistenza di settori cattolici e alto borghesi (Stauffenberg, la Rosa Bianca), perché si doveva occultare che c’era stata in Germania anche una attiva resistenza comunista che non aveva mai smesso di agire. In sostanza gli anglo americani, mentre stavano finendo di combattere una guerra ne avevano già iniziata un’altra. Al comune di Buchenwald, che aveva già eletto i propri rappresentanti dopo l’insurrezione, i liberatori americani imposero come borgomastro un vecchio rottame conservatore, cancellando manu militari la decisioni popolari e così avvenne da altre parti. Anche in Italia, peraltro, le trame atlantiche cominciano nel ‘44, quando si capì che la Guerra con il nazifascismo era ormai vinta e si trattava solo di una questione di tempo.
12 Febbraio 2011.
Va in onda in prima serata un programma dal titolo Nicht alles war schlecht. Il canale Phoenix si occupa di grandi inchieste e il titolo m’incuriosisce: si potrebbe tradurre con non tutto andava male oppure anche con non tutto era cattivo. Quando le prime immagini e le fogge dei vestiti mi riportano agli anni ’70 e le riprese inquadrano Berlino intorno ad Alexander Platz, comprendo subito, prima ancora che si cominci a parlare, che l’oggetto dell’inchiesta è l’ex DDR. I servizi sulla Repubblica Democratica tedesca si sono intensificati negli ultimi anni, ne ho visti diversi, però capisco che questo reportage avrà dei toni e degli accenti differenti dal solito e infatti sarà così. Peraltro, un titolo così esplicito e senza punto interrogativo lo faceva presupporre. Il taglio della ricostruzione era l’immersione nella vita quotidiana, per poi da lì risalire all’economia, alla politica, alla struttura dello stato e alla sua ideologia. Come sempre avviene in questi programmi, il reportage s’interrompeva per far parlare alcuni protagonisti che esprimevano opinioni contrastanti: seguivano poi i commenti da studio, affidati a due diversi storici con approcci differenti. Infine, l’inchiesta si avvaleva di veri e propri momenti di sceneggiatura teatrale, dove venivano messi in scena simulazioni di situazioni in cui la vita comune delle persone entrava in conflitto con l’ideologia ufficiale. In una, per esempio, uno studente delle superiori viene trattenuto alla fine delle lezioni dall’insegnante che lo redarguisce aspramente per la foggia dei suoi vestiti e i capelli lunghi e le scarpe troppo occidentali. Mi stupisco, perché nelle scene precedenti, le immagini di concerti rock a Berlino est inquadravano masse urlanti di giovani niente affatto diverse da quelle delle piazze occidentali degli stessi anni; anzi, veniva sottolineato come l’idea che il rock fosse bandito negli stati socialisti era più il frutto di propaganda che non di realtà. Seguendo il colloquio, capivo che il problema era in effetti un altro e cioè che lo stesso abbigliamento non poteva essere adoperato a scuola e in un concerto; un problema di decoro e di rispetto per lo studio e la funzione della scuola. In sé, la cosa poteva pure avere un senso, se non fosse che la minaccia esplicita che si intuiva durante la sceneggiatura, era quella di sanzioni talmente pesanti e non solo di natura amministrativa, da rendere il tutto quantomeno assurdo. Tornando al titolo: che cosa non era tutto da buttare? Qui l’inchiesta si affidava molto di più alle testimonianze e allora anche le più critiche insistevano su fattori che erano stati ricordati più volte e che da noi venivano presi per semplice propaganda mentre era anche di sostanza: la sanità gratuita, l’accesso allo sport e allo studio, una certa libertà nell’uso del proprio corpo che sfociava nel nudismo come pratica quasi abituale. Un pugile, in particolare, sottolineava fortemente questi aspetti, che non erano negati neppure dai più critici, senza trascurare peraltro la grande questione del doping di massa, spacciato per medicina sportiva. Niente di nuovo sotto questo aspetto, nel senso che il lavoro garantito (anche quando non serviva a nulla) e servizi sociali efficienti, erano gli aspetti del capitalismo di stato comuni a tutti i paesi del socialismo reale, con maggiore o minore efficacia sociale e certamente quelli della ex DDR efficienti lo erano, tanto che ancora oggi nelle parti più orientali di Berlino, per esempio, alcune di quelle istituzioni sono rimaste in piedi e continuano ad essere elementi di aggregazione e di resistenza al degrado. L’inchiesta, a questo quadro sociale che in alcuni momenti appariva (se riportato alle immagini di vita quotidiana), di una decorosa esistenza, un po’ grigia ma non diversa da quella delle società occidentali degli anni ’50, giustapponeva l’altro aspetto, quella della mancanza di libertà, di tutta una serie di restrizioni – alcune delle quali assurde – e per ultima, ma non all’ultimo posto, la presenza abnorme e ingombrante del muro. Fra questi due aspetti, anche in questa inchiesta, c’era un gap, un vuoto nel mezzo che non può essere colmato da un servizio giornalistico per quanto accurato e serio. Il vuoto cui alludo è quello di una riflessione più profonda e che faccia un bilancio non solo politico di quelle società ma anche antropologico e anche teorico, partendo anche da una domanda molto semplice: ma era proprio necessario tutto quell’apparato poliziesco per arrivare a quello che le socialdemocrazie nordiche avevano realizzato a partire dagli anni ’30, senza pagare gli stessi prezzi? La risposta a questa semplice domanda non è naturalmente semplice ma occorre affrontarla se si vuole rimettere al centro la proposta politica una società diversa da quella esistente, patriarcale e capitalistica, ma lontana (seppure in modi diversi), sia dal socialismo reale sia delle socialdemocrazie nordiche che hanno finito il loro ciclo propulsivo sia al loro interno, sia come eventuale modello di riferimento.
6 Ottobre.
I modi in cui la televisione e la stampa tedesca riferiscono delle vicende di Berlusconi, è emblematico per capire la mentalità diversa dei due popoli e delle due culture, ma è anche un indice del fatto che i tedeschi hanno verso di noi un atteggiamento di interesse continuo, che li affascina al di là della facile ironia cui a volte sui abbandonano. Era già accaduto con la bocciatura della proposta Augello che aveva fatto scrivere nei titoli dei telegiornale: Italienisch Senat wählt die Ausschluss von Berlusconi. Letteralmente: il senato italiano vota l’espulsione di Berlusconi. Lo stesso schema linguistico si è ripetuto alcuni giorni dopo con il voto della giunta. Berlusconi verliest Senats mandat: Berlusconi perde il mandato di Senatore. Entrambi i titoli sono basati sul concetto di conseguenza logica derivante da un atto già compiuto. Se la giunta del Senato ha tolto il mandato se ne deduce che Berlusconi è decaduto da Senatore. Il problema è che il concetto di conseguenza logica e della sua stringente consequenzialità viene esteso a una materia per sua natura controversa. In politica esiste la conseguenza logica stringente? Non sempre, neppure per loro e infatti dall’esito elettorale alla formazione del governo, i tempi si allungano anche qui. L’argomentazione che questo avviene perché la Merkel non ha la maggioranza assoluta, come viene scritto dai giornali italiani, è però una obiezione tipicamente italiana, che solitamente qui non ha alcun corso, dal momento che nessuno contesta la sua legittimità a governare. In altri momenti meno delicati di questo, il governo sarebbe probabilmente già nato. Rimane però un fatto indubitabile. Anche per le caratteristiche della lingua tedesca, il concetto di conseguenza logica è fondamentale e discriminante rispetto alle altre culture e lingue europee.
2 Dicembre.
La morte di Christa Wolf sta passando in un silenzio piuttosto greve qui in Germania. La televisione le aveva dedicato un servizio tre settimane fa. Il mio tedesco non mi permette di capire se fosse un coccodrillo anticipato, la sensazione è che si trattasse di un reportage normale. Pochi i commenti alla notizia della morte e anche girando in rete fra quelli italiani prevale, tranne che in alcuni interventi (primo fra tutto quello di Rossana Rossanda sul Manifesto), una certa acidità. Tutti a ricordare la storia che è poi un falso: quella dei suoi rapporti con la Stasi. Christa Wolf ha ricostruito più volte come sono andate le cose. Non ha negato di essere stata contattata dal servizio, ma a fronte della sua reticenza è stata oggetto lei stessa di attenzioni e spiata. Ci sono personaggi ben più imbarazzanti nella ex DDR, che hanno saputo abilmente riciclarsi. La colpa di Christa Wolf è un’altra: non avere abiurato l’idea comunista pur prendendo tutte le distanze del caso (ma con le armi della critica e della riflessione e non con quelle della rimozione), dalla storia dei regimi orientali. Rossana Rossanda, sul Manifesto, aggiunge altre considerazioni assai acute. Su Wolf ha pesato anche il fatto di non essere amata dalle femministe, proprio perché s’era impicciata di cose come il comunismo. La sua mancata abiura, e la sua tranquilla resistenza, permettono di scoprire molti altarini. È stato divertente in questi giorni leggere che proprio coloro che parlano a proposito e a sproposito di autonomia dell’arte e dell’artista da ogni pensiero, ideologica ecc. rivendicando che solo l’opera fa testo, parlando di Wolf si siano completamente dimenticati dell’opera e abbiano criticato le sue scelte politiche. La Wolf scrittrice avrà tutto il tempo che vuole per tornare a imporsi. Ha saputo risalire alla mitologia greca in un modo originalissimo, lontana sia dai cliché della parodia sia della rivisitazione del mito in chiave postmodernista. Ha certamente attualizzato il mito, ma anche questa parola non le rende giustizia: può renderla a Dürremmatt e a Borges, ma non del tutto a lei. Credo che Wolf abbia cercato nel mito arcaico le radici di una possibile utopia e dunque lo ha proiettato nel futuro, facendone una fonte dinamica d’ispirazione non soltanto letteraria. È questo che rende diverse le sue Cassandra e Medea da altre. Lei interroga questi miti nelle loro parti opache, a volte come in Medea li riscrive completamente, presupponendo tutta un’altra storia che sottostà a quella conosciuta; ma non lo fa sempre, come se seguisse un programma di riscrittura dell’intera storia occidentale al femminile. Altre volte li interroga in modo riflessivo, senza approdare a un’ipotesi necessariamente alternativa. Bisognerà certo ritornare con altri e più affilati strumenti a ripercorrere la sua opera, ma non riesco a sottrarmi, anche in questo caso, dallo scriverne a caldo, in diretta con gli eventi, spettatore partecipe. Anche per il solo fatto di trovarmi qui a Berlino, la sua morte è un altro di quei segni che tirano la riga su un’epoca. Con lei muore una seconda volta la Germania Orientale e forse sono destinate finalmente a morire anche le polemiche, dopo questi brevi fuochi residuali. Il mondo del capitalismo reale nel quale viviamo ci trascinerà in nuove tragedie, ma il passato non ci serve a nulla in questo momento, anche perché a differenza di quello che ha fatto lei, molti altri hanno semplicemente abdicato e rimosso. La sua opera di grande scrittrice del secondo ‘900 potrà invece vivere più liberamente.