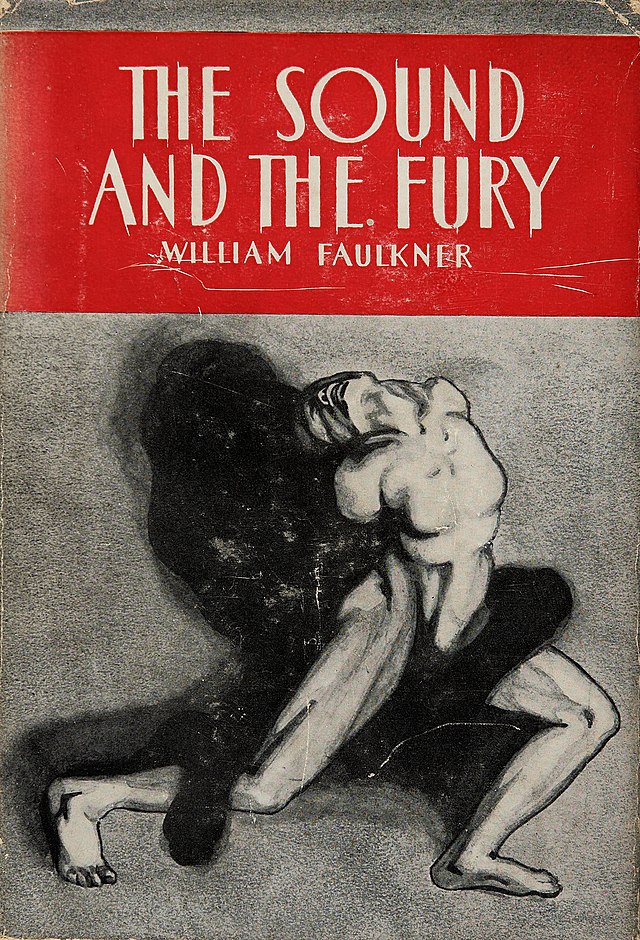INTERVISTA A VINCENZO CONSOLO
A cura di Franco Romanò

Premessa
Questa intervista fu pubblicata sulla rivista Il Cavallo di Cavalcanti nel 2008: ad essa seguirono altri incontro pubblici cui partecipò lo stesso Consolo allo Spazio Coop di via Arona. La ripropongo oggi nel blog per la sua ricchezza e attualità, con due precisazioni. Nella mia introduzione di allora notavo che molti dei suoi libri erano introvabili: per fortuna oggi la situazione è cambiata e questa è una buona notizia. La seconda precisazione. Nella parte finale, pur senza citarlo Consolo mette in evidenza i cambiamenti negativi indotti dal governo Berlusconi. Nel contesto di allora la sua frase era chiarissima, oggi è forse bene ricordarlo in modo esplicito.
——-
Mi accingo a incontrare Vincenzo Consolo con due pensieri in testa: prima di tutto che i suoi libri sono quasi introvabili, a parte quello d’esordio – La ferita dell’aprile – ristampato di recente da Mondatori. Per fortuna li avevo quasi tutti, e per qualcuno sono ricorso ad amici, ma mi sembra un cattivo segno dei tempi che si faccia fatica a trovare in libreria un autore che ha dato così tanto alla narrativa italiana. Il secondo pensiero riguarda la lingua. Nel prepararmi a intervistarlo mi sono ricordato di un saggio che T.S.Eliot dedicò in anni lontani alla poesia di Marianne Moore: in esso il grande poeta anglo statunitense afferma, fra l’altro (ricordo a memoria), che un poeta va prima di tutto valutato rispetto a quello che ha dato alla lingua d’appartenenza. Penso che questo sia estendibile anche ai narratori e nel caso di Vincenzo Consolo il giudizio di Eliot è quanto mai calzante e di bruciante attualità. Il poeta, infatti, avvertiva già in quegli anni lontani, che l’inglese correva il pericolo di un impoverimento dovuto alla sua estensione planetaria come lingua veicolare, sottoposta quindi a un processo di semplificazione e di impoverimento. Per ragioni diverse anche le altre lingue – e quella italiana in particolare – sono oggi minacciate (sebbene da altri e ben più distruttivi fattori) e questo sarà proprio uno dei temi dell’intervista.
Lo scrittore mi riceve nella sua bella casa milanese; l’ampio salone è pieno di libri e al tempo stesso molto luminoso, due caratteristiche che non sempre vanno a braccetto quando si entra nello studio di un artista della parola; chissà che la solarità della sua terra non abbia a che fare con questo! Entriamo subito in argomento e gli ricordo una frase contenuta in Fuga dall’Etna:
Franco Romanò:
Vorrei partire da questa sua affermazione: “Mi sono sempre sforzato, di sfuggire, nella vita, nell’opera, ai miti. La letteratura per me, ripeto ancora, è il romanzo storico-metaforico. E poiché la storia è ideologia, come insegna il Carr, credo nel romanzo storico ideologico,… cioè nel romanzo critico.” È una dichiarazione del ’93: ha qualcosa da aggiungere, o da modificare, a tale affermazione?
Vincenzo Consolo:
No, sono convinto di questa mia idea del romanzo storico metaforico, critico e nel momento stesso anche ideologico. Quanto alla parola romanzo, però, credo che oggi questo genere letterario non si possa più praticare; io parlo di narrazione piuttosto. Credo che il romanzo d’intreccio, oggi, non sia più possibile perché una volta l’autore aveva presente qual era il suo interlocutore. Si facevano persino delle indagini e si chiedeva agli scrittori a quale tipo di lettore pensavano. Una volta Calvino rispose alla domanda dicendo che pensava a un lettore che la sapesse più lunga di lui ed era assai difficile saperla più lunga di Calvino! Comunque c’era un lettore cui lo scrittore poteva pensare. Oggi in questa nostra società non è possibile pensare a un lettore e allora occorre spostarsi verso la narrazione…
FR:
E come si potrebbe definire la narrazione?
VC:
La narrazione scaturisce da qualcuno che ha fatto un’esperienza, ritorna e la racconta, come ha scritto Walter Benjamin in Angelus Novus. Il fatto di raccontare, di narrare, lo porta a un ritmo che sposta la prosa verso la forma poetica. È quello che ho cercato di fare nei miei libri, dove non c’è mai l’arresto, la riflessione, l’irruzione di quello che si chiama spirito socratico e cioè la filosofia, come era nella tragedia moderna di Euripide. Oggi questo non è possibile perché l’autore non sa più a chi rivolgersi. Io dico sempre che la cavea è vuota. Sulla scena non arriva più l’anghelos, il messaggero, che raccontava al pubblico presente ciò che era successo in un altro luogo e in un altro tempo. Così aveva inizio la tragedia. L’anghelos per me è lo scrittore che non può più apparire sulla scena e la narrazione è relegata al coro, che commenta e lamenta ciò che è avvenuto. Sono quindi per la narrazione e non più per il romanzo, tutti i miei libri di narrativa sono contrassegnati da questa prosa ritmica, a volte con il ricorso spesso alla rima e all’assonanza; questo è stato notato da diversi critici.
FR:
Andare verso la prosa lirica e la narrazione non è forse andare anche verso l’oralità, verso un senso arcaico della narrazione?
VC:
Sì, è anche tipico del mondo mediterraneo. Ce lo hanno insegnato gli aedi, Omero o chi è stato identificato come tale. Fra l’altro gli aedi erano ciechi perché avevano lo sguardo interno. Òmeros, in greco antico, significa ostaggio e ci si domanda ostaggio di chi? Io credo ostaggio della memoria, perché c’era la tradizione del racconto orale. In questo nostro tempo la memoria è minacciata dai mezzi di comunicazione di massa, dal potere economico e politico. L’interesse di questi poteri è di farci vivere in un infinito presente, per cui non sappiamo più da dove veniamo e non riusciamo a immaginare dove vogliamo andare. Quindi io credo che oggi più che mai il poeta, lo scrittore debbano conservare la memoria per cercare di salvarla. Sembra uno sguardo all’indietro ma credo che sia necessario essere ostaggi della memoria e perciò pratico il romanzo storico metaforico. Ho immaginato la trilogia a partire dal 1860 fino ai giorni nostri, ma la metafora era sul tempo storico che stavamo vivendo.
FR:
Quest’idea di romanzo si è affermata subito in lei o si è modificata nel tempo? Nel romanzo d’esordio La ferita dell’aprile, prevale ancora una narrazione più realistica. Gli stessi eventi storici entrano nel libro in modo diverso da come accadrà per esempio nel romanzo successivo Il sorriso dell’ignoto marinaio, che ha pure una forte carattere visionario.
VC:
Sì la visionarietà è una forma di fantasia…
FR:
Qualcuno ha parlato anche di incrocio fra memoria e profezia.
VC:
Sì. Per quanto riguarda il romanzo d’esordio, naturalmente era un libro di ricordi, il tono era ironico e talvolta sarcastico, era una ribellione ai padri e a tutto ciò in cui loro avevano mancato; ma dal primo, uscito nel ’63, al secondo sono passati tredici anni. Il mio silenzio era dovuto al fatto che stavo riflettendo su quella prima esperienza di restituzione dei ricordi personali e anche su quello che sarebbe stato il mio futuro letterario. A cavallo degli anni ’60 Pasolini ci disse cos’era successo in Italia, io avevo studiato molto e quindi ho intrapreso la strada del romanzo storico metaforico dopo la restituzione dei miei ricordi di adolescenza.
FR:
Lei è uno scrittore che ha dato molto alla lingua italiana. Cosa ci può dire su questo, specialmente sulla mescolanza fra l’italiano e i dialetti; cosa questa che mi è sempre apparsa molto interessante.
VC:
Sì, le dicevo che in quegli anni di silenzio avevo riflettuto molto sul momento storico che stavamo vivendo e anche sulla trasformazione della società italiana, quella che Pasolini chiamava la mutazione antropologica, che era anche e soprattutto una mutazione linguistica. La lingua italiana stava diventando orizzontale e anch’io ho sentito l’assillo che hanno tutti gli scrittori da Dante in poi… È sempre l’assillo delle lingua. Anch’io mi sono domandato in quale lingua scrivevo e ritornando in Sicilia con la mia memoria ho capito che lì – un po’ in tutta Italia, ma in Sicilia soprattutto perché c’è stata una stratificazione di civilizzazioni (io non le chiamo dominazioni) – c’erano dei giacimenti linguistici importanti. Ho pensato che andasse recuperata anche la memoria linguistica e quindi anche dei vocaboli che esistono nel dialetto siciliano, ma senza scadere nella regressione dialettale, secondo l’esempio che ci avevano dato il plurilinguismo gaddiano, oppure il romanesco pasoliniano. Io ho pensato che andassero recuperati vocaboli provenienti dall’arabo, dal greco dallo spagnolo e di italianizzarli, farli emergere ma innestandoli sempre nella lingua centrale. Oltre che della mia memoria linguistica mi sono servito dei vocabolari siciliani dei termini arabi nel dialetto siciliano. C’è per esempio un dizionario prezioso di padre Gabriele da Aleppo, sulle parole arabe presenti nel dialetto siciliano. Proprio per un’esigenza di memoria e anche di memoria linguistica, dal momento che questa nostra lingua, a causa della mutazione antropologica, stava perdendo purtroppo quella che Leopardi chiamava l’infinito che aveva in sé. Ecco io credo che sia un dovere dello scrittore, del poeta di recuperare anche la memoria linguistica.
FR:
Infatti leggere un romanzo come Retablo, per esempio, è anche un po’ immergersi in una storia della lingua. Sempre a questo proposito cosa ne pensa dei manifesti in difesa della lingua che periodicamente sono stilati?
VC:
Il manifesto serve come allarme, ma è un po’ una lotta con i mulini a vento. Questa nostra lingua è stata distrutta dai mass media; inoltre l’italiano, diversamente dal francese o dallo spagnolo che hanno dei bacini di parlanti molto vasti, è parlato solo in questa nostra stretta penisola. Siamo invasi continuamente dall’americanismo. Credo che lo scrittore abbia il dovere, al di là dei manifesti, di difendere questa nostra memoria linguistica e sapere cosa ci sta dietro. Una cosa che cerco di fare è anche operare una scrittura palinsestica – così la chiamo – e cioè una scrittura su altre scritture. Nella mia scrittura ci sono sempre citazioni e recuperi di altri scrittori o poeti, a volte più esplicite a volte meno.
Mi ricordo, a questo proposito, la polemica fra Leopardi e Niccolò Tommaseo – che non amava Leopardi – e definì la sua poesia un palinsesto mal cancellato. Il povero Leopardi si offese terribilmente e scrisse un saggio contro Tommaseo; ma la scrittura deve essere palinsestisca!
FR:
Rimanendo alla lingua, anche per lei si può parlare di plurilinguismo…
VC:
Sì qualcuno ha parlato, nel mio caso, anche di plurivocità, nel senso che riporto nella narrazione anche altre lingue. In Sicilia, per esempio, ci sono sette isole linguistiche. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio ne riporto una che ancora esiste: il gallo italico o medio latino. Si tratta di una lingua che hanno portato i Normanni con le truppe mercenarie raccolte nella pianura padana: finita la riconquista, come accade agli immigrati, si sono chiusi nella loro comunità e hanno conservato la lingua. Ne parla anche Vittorini in Conversazione in Sicilia, precisamente del gran lumbardo che parlava con la ü francese. Nel finale del libro (Il sorriso dell’ignoto marinaio, ndr.) quando riporto le scritte sul muro dei carcerati, quelli sono esempi nella lingua gallo italica.
FR:
Un programma linguistico più dantesco che manzoniano…
VC:
Certo, certo. Dante parla delle due lingue: quella di primo grado che impariamo in casa e la seconda che lui definisce grammaticale. Lui dice però con un bel ossimoro che la più nobile è la lingua volgare, che era nata in Sicilia.
FR:
Retablo Mi porta a un’altra considerazione. In alcuni momenti mi ha ricordato Fiori blu di Queneau, con una differenza fondamentale però: la qualità pittorica del testo, assente invece in Queneau. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio, i protagonisti sono tanti, ma anche in quel caso si parte da Antonello da Messina e dal suo quadro. Ecco, cosa rappresenta per lei la pittura?
VC:
Per me è un’esigenza di equilibrio fra svolgimento nel tempo e lo spazio. Per me la parola, come la musica, si svolge nel tempo, quindi ho bisogno di riferimenti iconografici e pittorici per equilibrare il tempo e lo spazio. Per me l’ispirazione della pittura è costante: a volte esplicita come è nei due romanzi che lei ha ricordato, a volte nascosta. C’è Guttuso e finanche pittori moderni come Ruggero Savinio, il figlio di Alberto. In Nottetempo, casa per casa, c’è tutto un brano in cui io leggo la pittura di Savinio in forma lirica. Sono delle figure che emergono dalle profondità delle spazio, come affreschi appena dissepolti. Mi interessano finanche pittori contemporanei; per esempio, uno che mi ha ispirato un’immagine è Mario Merz. Una volta vidi un quadro proprio in casa editrice Einaudi di cui ero collaboratore: in un suo quadro veniva raffigurata una lumaca che disegnava un tracciato che era una spirale e da lì sono partito.”Vidi una volta una lumaca…”
FR:
Milano e Palermo, Sicilia e Lombardia. C’è una continua tensione fra queste polarità e la sensazione che siano come due patrie dalle quali però lei si sente sempre anche un po’ esule.
VC:
Sì è proprio così, anzi più che esiliato mi sento estraneo negli anni. Ho fatto i miei studi a Milano e poi sono tornato in Sicilia perché avevo già concepito l’idea di diventare scrittore, dopo aver fatto il servizio militare. Avevo una laurea in legge, ma mi sono rifiutato di fare l’avvocato e ho insegnato diritto ed educazione civica nelle scuole agrarie. Ho insegnato per cinque anni e poi, riflettendo, ho pensato che quei ragazzi che si sarebbero diplomati in agraria sarebbero stati costretti a emigrare come i loro padri. Le racconto un episodio che non posso più dimenticare. Insegnavo nei monti Nebrodi, a Mistretta e Caronìa, che era poi l’antica Calacte… Mi colpì a Caronìa il numero di suicidi di donne che si era verificato in questo piccolo paese. Erano donne il cui marito era emigrato: la solitudine, lo sconforto le aveva portate a quel gesto. Riflettendo sulla loro vicenda anche la scuola mi sembrò una finzione. Consigliai molti di andare nelle scuole alberghiere, dove almeno avevano uno sbocco e non erano costretti a emigrare; alcuni l’hanno fatto. Poi però dopo cinque anni sono stato io a fare le valigie e a emigrare. Mi consigliai con due persone: Leonardo Sciascia e Lucio Piccolo. Quando ero libero andavo a Caltanissetta a trovare Sciascia e stavo lì dei giorni. Con Piccolo, invece, l’accordo era che andavo a trovarlo tre volte la settimana. Per me sono stati due riferimenti importanti. Ho anche fatto in modo di farli incontrare perché entrambi mi dicevano sempre di salutare l’altro. Sciascia una volta ha dichiarato che le due persone che più l’avevano colpito, fra le molte incontrate, erano Borges e Lucio Piccolo. Piccolo aveva una cultura sterminata. Mi diceva venga venga Consolo, che facciamo conversazione: la conversazione era che parlava sempre lui e io ascoltavo.

Ho imparato molto. Insomma mi consigliai con loro e Piccolo mi disse no, no, non vada via perché quando si è lontani dai centri si ha più fascino. Lui parlava da barone che viveva isolato nella sua villa di campagna. Sciascia invece mi disse che se fosse stato giovane come me e non avesse avuto la famiglia, se ne sarebbe andato anche lui perché – mi disse – “qui non c’è più speranza.” Per me l’unica città possibile era Milano, ma quando tornai non la riconoscevo più. C’era stato il miracolo economico e ora c’era il ’68 e quindi molti fermenti. Si parva licet, ho avuto nei confronti di Milano lo stesso atteggiamento che ebbe Verga quando si trovò a Milano nel 1872, nel momento della prima rivoluzione industriale. Verga rimase spiazzato perché era un mondo che non conosceva e di cui gli mancava memoria e lingua. Però da quell’esperienza nacque la grande conversione verghiana. Anch’io rimasi spiazzato e quindi ho riflettuto su questa realtà milanese e su quello che stava accadendo. Da tutto questo nacque Il sorriso dell’ignoto marinaio, a tredici anni dal primo libro. Non sono tornato fisicamente in Sicilia come Verga, ma con la memoria sì.
FR:
Il Risorgimento è molto presente nei suoi libri e anche nelle opere di molti scrittori siciliani. Mi ha colpito molto il bassissimo profilo delle commemorazioni garibaldine.
VC:
C’è questa regressione verso i localismi e l’individualismo. Le racconto un episodio successo a Capo d’Orlando. Durante una manifestazione pubblica il sindaco ha fatto togliere da una piazzetta del paese la targa con il nome di Garibaldi, intitolandola poi al 4 di luglio. La data si riferisce a una battaglia navale che ci fu nelle acque di Capo d’Orlando fra arabi e normanni. L’anti italianismo è ormai dilagante. Il signor Lombardo, attuale Presidente della Regione Sicilia, ha chiamato Autonomia siciliana il suo movimento; ma la Sicilia è già una regione autonoma, lui intendeva un’altra autonomia e infatti ha fatto riferimento anche alla Lumbardia di Bossi. Siamo alla regressione, alla stupidità e all’ignoranza. Non capire cosa è stato questo evento memorabile che fu l’unificazione d’Italia, per cui morirono eroi e persone degnissime è molto grave. Garibaldi riuscì davvero a compiere il miracolo di unire questo paese campanilistico; che era poi il sogno dei grandi italiani da Virgilio a Dante a Machiavelli. Questa regressione localistica è tipica dei momenti bui della storia. Il Risorgimento aveva acceso molte speranza. Garibaldi era un socialista mazziniano, poi capì che l’unità era più importante, ma comprese che le cose non erano andate secondo le speranze e lui prese la via dell’esilio. Da quello scaturirono anche le rivolte, le vendette nei confronti di quelli che erano stati gli oppressori, i famosi gattopardi, i proprietari terrieri… La prima rivolta fu quella di Alcara di cui parlo nel mio romanzo. Non lo dico nel libro ma risulta che dopo avere domato la ribellione di Alcara gli emissari si spostarono a Bronte.
FR:
Infatti gli episodi sono molto simili.
VC:
Sì, sì, tutta la letteratura siciliana poi ha affrontato questo tema perché è un nodo cruciale. Da Verga a De Roberto. Con I vicerè De Roberto ci ha fatto capire cosa sia il trasformismo, fino a Pirandello e al nostro Lampedusa. Tutti hanno affrontato questo momento importante della storia nazionale .
FR:
Sciascia è stato per lei un punto di riferimento, ma nella sua narrativa e anche nella sua prosa, che non è mai del tutto disgiunta dalla narrazione, io trovo un riferimento anche alla tradizione europea del romanzo saggio e non solo a Sciascia.
VC:
Sì, il romanzo saggio; forse questo c’è di più in L’olivo e l’olivastro, la cui matrice, tuttavia, si trova nel nostos, il viaggio di ritorno, che è assolutamente antico. Colui che l’ha riproposto e insegnato di nuovo è stato Vittorini con Conversazione in Sicilia, che è un viaggio nella terra delle madri e della memoria, anche se poi se ne allontana di nuovo, sollecitato anche dalla madre stessa che lo esorta a fare il suo mestiere di tipografo e compositore di parole, cioè il suo dovere di intellettuale. Pensi che nel 1941 sono usciti contemporaneamente Conversazione in Sicilia e Don Giovanni in Sicilia di Brancati, che sono di segno opposto. In Vittorini c’è la rivisitazione del profondo della memoria e poi il ritorno ai suoi doveri di intellettuale. In Brancati c’è la regressione. Quando Giovanni Percolla ritorna dalla madre e dalle sorelle, mangia e poi si mette a letto a un certo punto afferma: “Un’ora di sonno è stata come un’ora di morte.” Il personaggio di Brancati rimane di nuovo prigioniero delle viscere materne.
FR:
Beh ci sta dietro il mito della grande madre mediterranea…
VC:
È curioso come tutta la nostra narrativa, a parte i grandi poemi come L’orlando Furioso e altri che hanno una geografia straordinaria, il romanzo dell’800 da Manzoni in poi, si svolge sempre in piccoli centri, nella piccola città, quel ramo del lago di Como, piuttosto che Vizzini o Acitrezza. Chi inaugura per la prima volta il movimento è proprio Vittorini e questo scaturiva anche dal rapporto che lui aveva con la letteratura americana. La letteratura inglese e americana è contrassegnata dal viaggio, dal movimento.
FR:
Lei è considerato un autore dal forte impegno civile; tuttavia, seguendola in alcune presentazioni mi ricordo anche il suo fastidio costante rispetto a una retorica dell’impegno. Cosa pensa dello scrittore che si impegna direttamente in politica, pensando anche all’esperienza di Sciascia stesso.
VC:
Mi sembrò allora a quel tempo da parte di Sciascia fosse doveroso accettare l’invito. Lui mi raccontò che dopo la sua elezione al Comune di Palermo, insieme a Guttuso e poi dopo le dimissioni, tutti lo invitarono a entrare nei rispettivi partiti. Lui accettò il radicale e mi disse che lo aveva fatto perché era il meno partito di tutti. Anch’io ebbi un invito in anni lontani a presentarmi al Senato per il PCI. Il segretario del partito mi telefonò dicendomi “ti devi presentare” e al mio rifiuto motivato con il fatto che dovevo lavorare mi disse “è un tuo dovere”; ma io risposi che il mio dovere era quello di scrivere. Tuttavia penso che lo scrittore, come dice Roland Barthes, ha a disposizione anche la scrittura d’intervento, sui giornali, per esempio. Tutti i grandi l’hanno fatto: da Zola, che è stato il maestro con l’Affaire Dreyfus, a Pasolini, Moravia e Sciascia ecc. Io ho sempre praticato la scrittura d’intervento, ho scritto per L’ora di Palermo, l’ Unità, per Il Corriere della sera. Però la spettacolarizzazione mi disturba molto. Anche la manifestazione di Piazza Navona del giugno scorso, non mi è piaciuta, siamo all’indecenza. Gli intellettuali sono diventati i comici, oppure gli scrittori che fanno spettacolo. Purtroppo, se vivessero oggi, Pasolini, Sciascia, Moravia, non avrebbero più lo stesso impatto. I giornali sono in crisi , le case editrici sono in crisi, il nostro è un popolo che non legge più. Io ho definito quello italiano un popolo telestupefatto… È un’espressione che hanno ripreso in Francia: lo ha fatto Christian Salmon nella sua rubrica su Le Monde. Questo dei mass media e della televisione in particolare è stato una specie di tsunami provocato da questo signore che oggi è il capo del Governo. Anche il suo consenso è dovuto a questo mezzo di distruzione di massa che è la televisione, che è quanto di più volgare, stupido e ignorante che si possa immaginare.
FR:
Cosa c’è nei suoi programmi futuri?
VC:
È difficile parlare di programmi futuri. Sono tanti anni che taccio e non pubblico, scrivo di nascosto e nascondo. Ho un progetto di romanzo storico-metaforico che riguarda una storia di Inquisizione. Ho trovato dei documenti presso la biblioteca di Simancas in Spagna; naturalmente si svolge sempre in Sicilia e mi sembra che in questo momento di fondamentalismi religiosi di ogni tipo che rischiano di diventare teocrazie, che sono momenti terribili della storia umana, mi sembra che sia una storia da raccontare. Quando la smetterò di fuggire mi devo sedere a tavolino a scrivere questo libro.