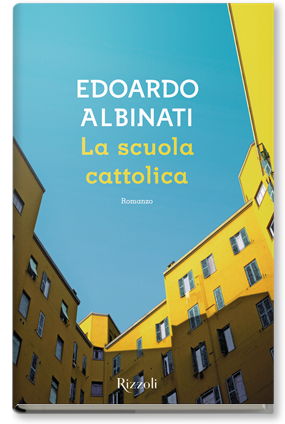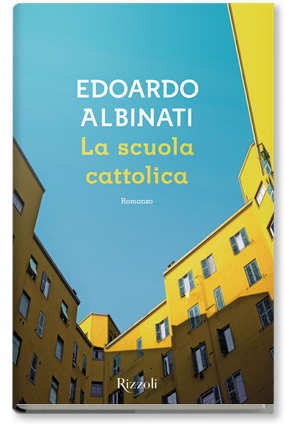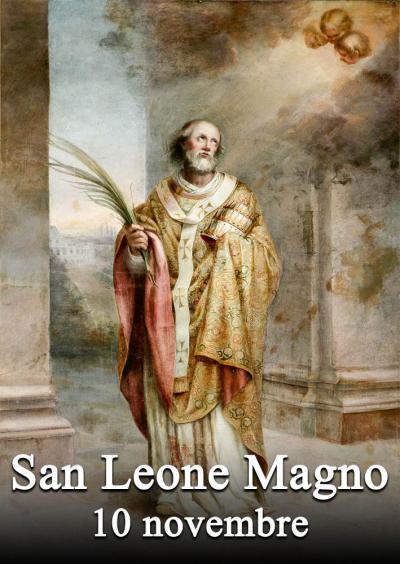BORGES
Premessa
Una prima versione di questo saggio si trova anche nella rivista A-verare, diretta da Eva Gerace.

Impossibile evitarlo se si vuole parlare di Argentina e di Buenos Aires e non solo da un punto di vista letterario. A una prima ricognizione superficiale, Borges esprime in un modo diverso rispetto a Ernesto Sabato, l’immobilità argentina e il suo mistero. Sabato ha espresso tutto ciò in un capitolo fondamentale del suo gran romanzo Sopra eroi e tombe. Il capitolo s’intitola I Ciechi. Borges esprime la medesima sensazione usando la metafora del labirinto.
Il narratore
La definizione che Borges dà della tradizione e dei modi in cui un argentino può viverla e servirsene, trova in Finzioni una rappresentazione particolarmente coerente. Lo scrittore sostiene che un argentino, non avendo una tradizione propria (ma vedremo anche come in parte si contraddirà lui stesso su questo punto), può avvalersi di tutte le tradizioni, a patto però che sappia trovare un punto di vista non canonico e canonizzato all’interno di quelle diverse tradizioni. A furia di cercare un punto di vista spiazzante, però, diventa in alcuni casi ripetitivo, tranne in quei racconti in cui non si affida solo alla ingegnosità delle concatenazioni: capolavori come Il giardino dei sentieri che si biforcano I due teologi, La lotteria di Babilonia, La casa di Asteriore, I due re e il labirinto, o Biografia di Taddeo Isidoro Cruz, L’Aleph, appartengono a quella raccolta ideale di opere del secolo scorso che avranno davanti a sé una lunga vita. In altri il gioco dell’ingegnosità finisce per diventare manieristico. C’è poi un racconto su cui occorre soffermarsi a lungo e non solo per ragioni strettamente letterarie e stilistiche: Deutsches requiem.
Il racconto non si discosta dai cliché borgesiani: un misterioso narratore racconta la storia della sua vita la notte prima di essere fucilato. Comprendiamo subito che si tratta di un nazista, tuttavia, prima di arrivare al momento in cui egli stesso lo rivela, il narratore ci fa conoscere i suoi antenati e costruisce una genealogia del tutto inventata da Borges, che gioca abilmente come sempre, mescolando dati di realtà con invenzioni, nomi che sembrano veri ma che poi trovano solo parziali riscontri perché le date di nascita e morte risultano false. Questo il gioco. Deutsches requiem è un canto funebre, ma il titolo è spiazzante. Requiem tedesco, come se fosse la nazione stessa, attraverso le parole del protagonista, Otto Dietrich zur Linde, a pronunciare il proprio requiem; ma l’espressione significa pure che si tratta sì di un requiem dalle caratteristiche tedesche. Infine il titolo è anche quello del requiem di Brahmas e quindi con tale scelta Borges costruisce una genealogia ancor più complessa. Seguendo passo dopo passo la storia personale del protagonista e narratore, non troviamo in realtà nulla di veramente eclatante. Si è iscritto al partito nel 1929, ha creduto che il nazismo fosse una ribellione morale, ha creduto alla propaganda sul cosiddetto uomo nuovo, nonostante disprezzasse i suoi camerati, ha seguito tutto il cursus honorum, compresa una ferita poco eroica; finché non è stato nominato vicedirettore di un campo di concentramento ed è probabilmente questa la ragione della sua condanna a morte. Otto è dunque un funzionario medio, uno di quegli uomini che Annah Arendt avrebbe posto nella categoria della banalità del male. Tuttavia, nel crescendo che Borges abilmente imprime al testo, Otto Ditriech zur Linde assume una statura diversa, non da uomo medio, ma da agente di un destino storico: è dunque una personificazione di Hitler? No, il gioco è più sottile. Il salto di qualità inizia a compiersi dal momento in cui egli smette di parlare dei suoi antenati ed entra perentoriamente in scena: “Sono nato a Marienburg nel 1908.” Poi ci parla dei suoi interessi per la musica e la metafisica e comincia a disseminare il suo racconto di alcuni grandi nomi che hanno concorso alla sua formazione: Brahms, Shakespeare e specialmente Schopenhauer, un filosofo che torna spesso anche negli scritti di Borges. Otto prende su di sé un lembo dello scrittore, o – al contrario – è Borges a identificarsi con lui, con un sorriso sarcastico e sinistro quando gli fa dire: “Sappia, chi indugia meravigliato, …. davanti a un qualunque luogo dell’opera di quei beati, che anch’io, l’abominevole, vi indugiai.”
Chi parla è il narratore oppure è Borges stesso? Fatto sta che il ritratto di Otto assume aspetti molteplici e sinistri. Due altri nomi sono alle porte: il primo è scontato (anche per gli equivoci che si porta dietro), e si tratta di Nietsche, il secondo un po’ meno: Spengler e subito dopo Goethe, ma in modo ellittico, come vedremo. Alla fine di questo percorso di formazione Otto, all’età di 21 anni, entra nel partito nazista. Appartiene dunque a quella generazione giovane che più ha creduto, che ha vissuto la fase della irresistibile ascesa del movimento dopo la crisi del ’29. La descrizione dei primi anni nel partito è opaca, finché nel ’39 viene ferito in modo causale e questo gli costa l’amputazione di una gamba. In ospedale legge ancora Schopenhauer, Parerga und paralipomena e accoglie la teoria della predestinazione (“… tutti i fatti che possono accadere a un uomo dall’istante della sua nascita a quello della sua morte, sono stati preordinati da lui…”), tanto cara infondo anche a Borges, così che Otto viene ad assumere sempre di più le fattezze di alter ego dello scrittore, ma anche i tratti di un’entità funesta e oscura. Otto si domanda che cosa gli ha fatto scegliere le pallottole che l’hanno ferito e quella mutilazione. Crede di trovare la risposta in uno strano discorso che per ora lasciamo in sospeso perché sarà meglio chiarito più avanti, ma le cui conseguenze sono decisive, perché è proprio alla fine di questo percorso di individuazione di sé che Otto viene nominato vice direttore del campo di concentramento: siamo nel 1941. In esso incontra un ebreo, un poeta dal nome fin troppo ovvio – David Jerusalem – tanto ovvio da sospettare che si tratti dell’ennesima invenzione di Borges. È così, ma come sempre il gioco di specchi e la macchina che travolge il lettore con la stessa logica con cui Otto dirige il campo di concentramento, richiede un passaggio ulteriore. In una nota, Borges ci avverte che nel campo di Tarnovitz, in effetti, venivano radunati e torturati molti artisti, per cui non si può escludere che in mezzo a loro ci fosse anche un David Jesusalem e che il suo nome sia stato cancellato e non trovato negli elenchi. Otto si sofferma su di lui parlandoci delle sue opere come se niente fosse, ma il suo vero intento è quello di cancellare dentro di sé qualsiasi forma di connivenza con un sentimento come la pietà. Riuscirà così a spingere Jerusalem al suicidio. Alla fine, quando questo si compie, Otto si domanda se David abbia compreso che “lo distruggevo perché … avevo capito che si era trasformato nel simbolo di una detestata zona della mia anima. Agonizzai con lui, morii con lui, in qualche modo mi sono perduto con lui; perciò fui implacabile.”
Il racconto di Borges si muove come un dispositivo a orologeria che riflette nel suo andamento il funzionamento del campo di concentramento. A ogni dente del meccanismo che fa girare ruota dell’ingranaggio corrisponde un avanzamento del crimine ma anche della consapevolezza; finché si giunge all’epilogo, il Terzo Reich che muore. La narrazione subisce una nuova svolta che sembra in prima istanza imprevedibile, ma che lo sarà di meno quando, arrivati alla fine, saremo di nuovo costretti a ripercorre l’intero racconto dall’inizio: come sempre Borges ci ha portati dentro un labirinto, che è fatto a sua volta di molti labirinti. Improvvisamente, Otto avverte un sapore misterioso e terribile di felicità, anche se sa benissimo che la sconfitta del Reich sarà la causa della sua morte. In una escalation di grande efficacia, egli cerca nella sua coscienza le ragioni di questa felicità, ma le vive come tentazioni e questo mi ricorda un altro grande testo della seconda metà del ‘900: Assassinio nella cattedrale di Eliot. In quell’opera, l’Arcivescovo Beckett, prima di prendere la decisone che gli costerà il martirio, si domanda se nel suo atteggiamento ci sia per caso un residuo di rispetto umano; per esempio, se oltre l’amore per la verità e per il suo Dio, ci sia anche la vanità di chi cerca la gloria. Un sentimento analogo spinge ora Otto a domandarsi se nella sua improvvisa felicità ci sia qualcosa di umano troppo umano. Il primo dubbio e più ovvio è di sentirsi colpevole e quindi meritevole di una punizione che presto arriverà: è il senso di colpa cristiano. Otto va oltre: forse semplicemente è contento che la guerra stia finendo perché è stanco e prova un sentimento volgarmente umano di debolezza. Va oltre anche questo e arriva alla terza motivazione, la più elevata di tutte, ma pur sempre una tentazione: è contento della sconfitta perché è accaduta e bestemmiare contro un fatto reale è come bestemmiare contro l’universo, mentre invece di fronte a ciò che accade bisogna solo chiedersi perché e quale anello nella catena della predestinazione esso rappresenta. Otto scarta anche quella ipotesi e afferma subito dopo di avere individuato in altro la causa della sua felicità. Prende le cose da una certa distanza e cioè da una diceria – probabilmente inventata – che classifica gli uomini secondo categorie antagoniste e irriducibili entrambe destinate a seguire nei secoli la loro strada: “… gli esseri umani sono aristotelici o platonici …” La Germania incarna una delle catene di questi destini, la seconda la scopriremo dopo, anche se a pensarci bene, essa è già evidente; ma seguiamo la prima. Troviamo così che Arminio, il vincitore di Varo, non sospettava di essere il precursore di un impero germanico, ma lo fu; Lutero, traduttore della Bibbia, non sospettava che con la sua Riforma stava forgiando un popolo che avrebbe distrutto la Bibbia, ma lo fece. Fino a Hitler; ma anche a lui, Otto zur Linde, che una pallottola poco eroica tolse dalla guerra, cioè dal combattimento che porta alla gloria e che lo aveva portato a servire la causa da direttore di un campo di concentramento, diventando come “… un mago che tesse un labirinto ed è costretto a errarvi fino alla fine dei suoi giorni, o a David che giudica uno conosciuto e lo condanna a morte e poi ode la rivelazione: Tu sei quell’uomo.”
Otto è dunque il narratore segreto, colui che dice la verità su una Germania di cui Hitler è solo l’ultimo anello di una delle due catene destinali? E qual è la seconda catena? Il finale del racconto, nella sua parte più ovvia, lo dice, ma è nulla rispetto alla forza dell’invettiva e della visione terribile che pronuncia: “… Altri maledicano e piangano; io sono lieto che il nostro dono sia circolare e perfetto. Si libra ora sul mondo un’epoca implacabile. Fummo noi a forgiarla, noi che ora ne siamo le vittime. Che importa che l’Inghilterra sia il martello e noi l’incudine? Quel che importa è che domini la violenza, non la servile viltà cristiana. Se la vittoria e l’ingiustizia e la felicità non sono la Germania, siano per altri popoli. Che il cielo esista, anche se il nostro luogo è l’inferno.” Ma il cielo evocato da Otto non è quello dei cristiani ma il luogo in cui domina la violenza, l’epoca implacabile che sorgerà dalle rovine e l’inferno è solo per la Germania, ma quel cielo sarà per tutti.
Il racconto però non è finito. Fin qui il narratore ci ha raccontato la sua verità dei fatti, ma lui chi è? Le ultime quattro righe del racconto suggeriscono qualche ipotesi, ma lo sappiamo bene: da labirinto non si esce facilmente.
“Guardo il mio volto nello specchio per sapere chi sono, per sapere come mi comporterò fra qualche ora, quando mi troverò di fronte alla fine. La mia carne può avere paura; io no.”
Otto è un Cristo rovesciato, più che un Anticristo. Se, per il mito cristiano, Gesù di Nazareth si sacrifica sulla croce per salvare l’umanità intera, Otto si sacrifica per dannarla tutta e potrebbe persino pronunciare davanti al plotone d’esecuzione la fatica frase “tutto si è compiuto.” Otto ghigna ai suoi fucilatori dicendo loro che ha vinto perché ha imposto loro, per distruggere la Germania, di usare la stessa implacabilità e ferocia che ormai li ha infettati e che segnerà il destino delle epoche future: pensando all’oggi più di un brivido viene.
Dicevo in precedenza che i labirinti sono a loro volta fatti di altri labirinti, tanto più in questo racconto, costruito secondo la logica di un campo di concentramento, in cui di volta in volta, un elemento elide l’altro togliendolo di mezzo, finché alla fine non rimane nulla e nessuno, soltanto la morte, oppure il ritornare su se stesso del labirinto. E Borges dov’è finito in tutto questo? Possiamo dare diverse risposte e pensare che la frase che attribuisce a Otto quando afferma che ha spinto Jerusalaem al suicidio morendo con lui, siano riferite anche a se stesso, ma forse ripercorrendo un altro labirinto dentro quello più grande e che potrebbe essere definito anche un sottotesto o uno dei molti sottotesti di questo racconto, potremo trovare qualche risposta in più e anche riprendere qualche questione lasciata in sospeso.
Il sottotesto è la nomenclatura che costella il racconto ai suoi bordi e di cui ci siamo già un poco occupati. Anche questa non è una novità assoluta: in Borges le citazioni e la comparsa di nomi veri e inventati è costante, sia nei racconti sia nei saggi e svolge quasi sempre una funzione che non è solo stilistica, cioè il modo con cui Borges cattura l’interesse del lettore, ma anche di vera e propria narrazione altra. Alcuni di questi nomi li abbiamo già visti, altri non ancora, ma è proprio ritornando a essi a cose fatte, che alcuni di loro più di altri acquistano un significato importante. Dei primi tre e cioè Brahms, Shakespeare e Shoperhauer solo il terzo merita qualche riflessione in più. Borges delinea una cornice di appartenenze che sono anche sue, ma che hanno un peso diverso: il Bardo fa parte di un Pantheon che nessuno scrittore può ignorare, il filosofo e quel filosofo, no.

Se c’è un’antinomia nella filosofia tedesca di quegli anni è proprio quella fra Shopenhauer ed Hegel, sia perché erano contemporanei e docenti nella medesima università, sia perché la loro alterità ne fa idealmente i rappresentanti delle due catene destinali che Borges metterà in bocca al suo personaggio; e non vi è dubbio da che parte si collochi lo scrittore argentino. Dunque con questo primo nome egli allude a un pensiero e a una tradizione che sono anche sue e che si precisa meglio non tanto con il nome di Nietsche, che nel contesto mi sembra un depistaggio, ma con quello di Spengler che viene subito dopo e che è la premessa di una digressione che continua anche in una nota: abbiamo lasciato in sospeso proprio questo passaggio. Dopo avere citato il filosofo della storia e scrittore, Otto cambia discorso e riferendosi a un autore del diciottesimo secolo che si comprenderà essere Goethe, afferma che “… nessuno vuol essere debitore dei suoi contemporanei; io, per liberarmi di un’influenza che sentivo opprimente, scrissi un articolo intitolato Abrechnung mit Spengler…” Spengler era un autore molto celebrato e discusso in tutta Europa agli inizi del ‘900 e poi relativamente dimenticato. Borges lo resuscita e lo mette al centro del racconto, ma l’anomalia sta nel titolo dell’articolo scritto che attribuisce a Otto e il cui significato è fare i conti con Spengler o addirittura resa dei conti con Spengler. Il libro più famoso di quest’ultimo è Il tramonto dell’Occidente, al centro del quale c’è un concezione della storia che applica alle civiltà la stessa dinamica che appartiene ai corpi umani: nascono, invecchiano, muoiono. Spengler ritiene tuttavia che sia anche possibile individuare i segni che indicano lo stato in cui si trova una civiltà e per quanto riguarda l’Occidente, l’ultima delle civiltà che prende in considerazione, essa sarebbe ormai destinata all’estinzione, visto che secondo lui, fin dal diciannovesimo secolo, si affida ormai a modelli culturali che per Spengler sono già morti. Qualcosa di analogo trova in poesia anche nell’opera di William Butler Yeats. Sono tutti autori che fanno parte di un Pantheon ideale di Borges, ma poiché quelle di Spengler non sono metafore ma una concezione della storia, ecco che il suo libro può essere inteso in un senso destinale e dunque assai prossimo alle concezioni di Shopenhauer. Rimane da capire perché il probabile alter ego di Borges e cioè Otto Dietrich zur Linde voglia una resa dei conti con Spengler: in che senso lo dice? Borges risponde a modo suo e cioè disseminando di indizi la scena del crimine e obbligando il lettore a improvvisarsi detective. Spengler aveva definito quella occidentale una società faustiana, riferendosi evidentemente a Goethe, solo che per Otto-Borges “… il monumento in cui appaiono più chiari i tratti che l’autore (Spengler) definisce faustiani, non è il composito dramma di Goethe, ma … il De rerum natura …”
La perfida nota che Borges inserisce a questo punto del testo, chiude il cerchio e chiarisce. La resa dei conti con Spengler consiste in questo. Goethe è ancora il prototipo di una comprensione ecumenica e dunque cristiana, mentre l’uomo veramente faustiano è quello di Lucrezio, che scopre il mondo solo nel momento in cui si è liberato di tutti gli dei; ma il compimento destinale dell’uomo faustiano è quello di trascinare nella sua morte il mondo intero. Il filosofo della storia Spengler andava dunque portato alle estreme conseguenze, cosa che Spengler uomo non seppe fare perché, nazista della prima ora, si tirò poi indietro, a differenza di Otto Dietrich zur Linde. E Borges? In quest’ultima frase ho rotto di nuovo il legame fra lui e il suo alter ego e mi sono domandato se lo scrittore argentino sia andato o no fino in fondo oppure abbia trovato il modo di uscire dal proprio labirinto. Credo di avere trovato la risposta che consentirà anche a me – finalmente – di uscire dal labirinto, in un saggio di Borges dal titolo Emmanuel Swedenborg, ma anche in una presa di posizione chiara in cui lo scrittore dichiarava di essersi sempre augurato la sconfitta di Hitler e del nazismo. Il pretesto per scrivere del filosofo svedese glielo fornisce Voltaire, che esalta Carlo XII come uno degli uomini più eccezionali della storia. Borges obietta che non lui, ma un suo illustre suddito merita un giudizio di eccezionalità e costui è proprio Swedenborg.

Il ritratto che Borges ne fa è assai interessante e del resto che si tratti di una figura eccezionale è del tutto vero in questo caso. Lo si potrebbe definire il Leonardo da Vinci del nord Europa, sia per la vastità degli interessi sia per il tipo di cultura olistico-rinascimentale che nel 1600 e tanto più nel 1700 era già tramontato nell’Europa occidentale e meridionale. Forse proprio per questo da noi è poco conosciuto, perché fuori tempo. Swedenborg appartiene a quella schiera di umanisti che in Italia e in Europa si chiamano Pico della Mirandola, Leonardo, Marsilio Ficino, Paracelso. Sono tutti grandi figure di eruditi che mantenevano però una concezione olistica del pensiero e del mondo e che spesso si trovavano sul crinale fra scienza, magia ed esoterismo, fra chimica e alchimia, a parte Leonardo, il più moderno fra loro. Sono tutti uomini travolti e superati dalla rivoluzione scientifica e dalla grande sistematizzazione di Cartesio, che li ha relegati in un tempo anteriore, ma anche in un filone della cultura europea che di solito si raccoglie nella definizione di irrazionalismo, della cui congruenza o meno non intendo qui occuparmi. Nel nord Europa, la loro influenza durò più a lungo, ma non bisogna dimenticare neppure che il più grande scienziato della prima modernità e cioè Newton, fu per molti anni sullo stesso crinale. L’uomo che con i suoi calcoli, le sue parabole, la legge della gravitazione universale contribuiva a demolire definitivamente l’universo tolemaico, l’uomo che giocava in borsa, era lo stesso che per lunghi anni si dedicò ad esperimenti alchemici e che vagheggiava una riforma religiosa che non aveva le sue radici in quella protestante ma in una visone esoterica del cristianesimo. Di questo retaggio umanistico-rinascimentale Swedenborg fu certo l’esponente più importante e inaugurò un filone di pensiero europeo minoritario ma sempre presente, che avrebbe avuto in William Blake e i suoi Libri profetici il suo ultimo e più importante esponente. E cosa c’entra allora Borges con tutto questo e per quale ragione sceglie proprio Swedenborg ripercorrendo le tappe della sua formazione e della sua opera in Svezia e poi a Londra e un po’ dappertutto in Europa? Più leggevo il saggio e più mi rendevo conto che forse parlare di lui era un modo traslato per parlare di sé. Fino che punto regge un’eventuale identificazione di Borges con Swedenborg e fino a che punto può costituire un altro nome di quel pantheon ideale di Borges che comprende la nomenclatura che abbiamo visto nel racconto Deutsches Requiem? Swedenborg di quella nomenclatura fa parte anche se Borges non lo cita nel racconto, ma il panegirico che ne fa nel saggio ci aiuta a capire meglio i suoi riferimenti. I punti di contatto ci sono eccome anche se lo scrittore argentino non ha mai avuto l’ambizione del riformatore religioso; ma se pensiamo agli aspetti pre moderni in lui, al suo enciclopedismo erudito, alla vastità dei suoi interessi e anche a un certo stile personale aristocratico, Borges assomiglia assai di più a un umanista europeo, anche se i suoi riferimenti filosofici sembrano andare in una direzione diversa. Trascurando momentaneamente questo aspetto, i lati umanistici nella sua opera e nel suo stile ci sono eccome e del resto. Borges, pur essendo venuto in contatto con l’avanguardia europea negli anni ruggenti (era a Parigi e a Madrid negli anni ’20 e ’30), se ne allontanò subito ritornando in Argentina. Il suo circolo e non solo lui, pur continuando a guardare all’Europa e specialmente alla Francia, era ben determinato a fondare in Argentina una tradizione autoctona, a cominciare dalla madrina di Borges e del gruppo che si radunò intorno a lui e cioè Victoria Ocampo, fondatrice della rivista Sur e mecenate, oltre che grande intellettuale del suo tempo. Borges, all’interno del gruppo era di certo il più pre moderno e dunque una certa identificazione con Swedenborg è realistica e forse almeno in lui c’era l’ambizione di fondarla sul serio una tradizione argentina e questo poteva essere fatto solo abbandonando l’avanguardia europea: la parodia e la dissacrazione sono utili dove una tradizione c’è già stata e non dove deve invece formarsi. Esiste però un legame fra questo modello umanistico e il racconto? Esso va visto a mio avviso nella convinzione latente in Borges che il destino dell’Occidente non coinvolgesse l’America latina e l’Argentina in particolare. C’è infatti un’ultima battuta di Otto Dietrich zur Linde di cui non ci siamo ancora occupati e cioè quando nel finale afferma: “… che importa se l’Inghilterra è il martello e noi l’incudine…” Borges mette sulle labbra di Otto una frase vistosamente parziale che sicuramente è più sua che non del suo personaggio. Nonostante il ruolo che l’Inghilterra ebbe nella prima parte della Seconda Guerra Mondiale, Borges fa finta di non sapere che senza il contributo di Stati Uniti e specialmente dell’Unione Sovietica con il suoi 70 milioni di morti, la guerra sarebbe durata ancora a lungo e non è neppure detto che i nazisti l’avrebbero persa! Nel binomio Inghilterra Germania Borges vede consumarsi una tragedia da cui spera di salvare l’America Latina e di salvarsi lui stesso, conservando di quel mondo solo alcuni riferimenti filosofici: Swedenborg come modello di umanista, Hume e Berkeley come filosofi e cioè lo scetticismo assoluto dell’empirismo britannico. Questo è il sogno che Borges attribuisce ai suoi dei, al centro del quale mette se stesso come via di mezzo fra un aristocratico inglese del 1700 e un anarchico di destra di primo ‘900, un po’ gaucho. Quel sogno, tuttavia, aveva al suo centro il buco nero di un colossale rimozione: gli Stati Uniti d’America e i troppi esuli fuggiti dall’Europa, vittime dei peggiori cattivi maestri. I guai cominciarono negli anni ’60 e ancor più ’70. Fino a quel tempo, infatti, l’eccentricità del continente latino americano e il suo decentramento rispetto alla tragedie immani del ‘900 europeo, lo avevano preservato e poco importa se qualche reggimento di quei paesi si era schierato con questo o quell’altro esercito dei vecchi colonizzatori. L’America Latina restava ai margini della grande storia, in una specie di limbo, fatto anche di eccellenze. Tutto questo cominciò a finire con Peron ma ancor più con la rivoluzione cubana del 1959. Borges se ne accorse eccome e per questo fu violentemente antiperonista più che anti castrista, ma il limbo era destinato per forza di cose a finire e l’intera America Latina sarebbe stata trascinata al centro dello scontro fra est ed ovest. Finiva la sua eccentricità e con essa finiva il sogno aristocratico di Borges e cominciarono anche certe sue dichiarazioni che possono essere lette in tanti modi, ma prima di tutto e aldilà del loro contenuto direttamente politico, proprio come un sentimento struggente di perdita, la nostalgia irriducibile per un sogno svanito nel nulla.