Bertolt Brecht: Tre poesie

Ecco gli elmi dei vinti
Ecco gli elmi dei vinti, abbandonati
in piedi, di traverso e capovolti.
E il giorno amaro in cui voi siete stati
vinti non è quando ve li hanno tolti,
ma fu quel primo giorno in cui ve li
siete infilati senza altri commenti,
quando vi siete messi sull’attenti
e avete cominciato a dire sì
Al momento di marciare di Bertolt Brecht
Al momento di marciare molti non sanno
che alla loro testa marcia il nemico.
La voce che li comanda è la voce del loro nemico.
E chi parla del nemico è lui stesso il nemico.
Quando chi sta in alto parla di pace
Quando chi sta in alto parla di pace
la gente comune sa che ci sarà la guerra.
Quando chi sta in alto maledice la guerra
le cartoline precetto sono già compilate.
Dulce et decorum est

Quella che segue è una poesia di Wilfred Owen che Woolf cita più volte nel suo libro Le tre ghinee come esempio di un maschile che ha saputo distaccarsi dall’esaltazione della guerra. Vale la pensa di ricordare che a centro anni e più dalla Prima Guerra Mondiale e nonostante che Owen sia morto in quel conflitto, le sue poesie di denuncia sono tenute fuori dalle antologie.
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.
Gas! Gas! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling,
And floundering like a man in fire or lime . . .
Dim, through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.
***
Piegati in due, come vecchi straccioni, sacco in spalla,
le ginocchia ricurve, tossendo come megere, imprecavamo nel fango,
finché volgemmo le spalle all’ossessivo bagliore delle esplosioni
e verso il nostro lontano riposo cominciammo ad arrancare.
Gli uomini marciavano addormentati. Molti, persi gli stivali,
procedevano claudicanti, calzati di sangue. Tutti finirono
azzoppati; tutti orbi; ubriachi di stanchezza; sordi persino al sibilo
di stanche granate che cadevano lontane indietro.
Il GAS! IL GAS! Svelti ragazzi! – Come in estasi annasparono,
infilandosi appena in tempo i goffi elmetti;
ma ci fu uno che continuava a gridare e a inciampare
dimenandosi come in mezzo alle fiamme o alla calce…
Confusamente, attraverso l’oblò di vetro appannato e la densa luce verdastra
come in un mare verde, lo vidi annegare.
In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti,
si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega.
Se in qualche orribile sogno anche tu potessi metterti al passo
dietro il furgone in cui lo scaraventammo,
e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto,
il suo volto a penzoloni, come un demonio sazio di peccato;
se solo potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo,
fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava,
osceni come il cancro, amari come il rigurgito
di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti –
amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto fervore
a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta disperate,
la vecchia Menzogna: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
Pensieri di pace durante un’incursione aerea (agosto 1940) di Virginia Woolf

La riflessione proposta è un classico di recente ritradotto da Nadia Fusini. Il testo può essere considerato una sorta di appendice al libro Le tre ghinee e fu pubblicato postumo nel 1942. Lo avevo proposto all’inizio della guerra fra Russia e Ucraina e lo ripropongo oggi anche con la breve introduzione di Tomaso Montanari, quando una nuova guerra di sterminio ancora più atroce è scoppiata nel Medio Oriente. Lo stato di impotenza nel quale siamo immersi è il risultato di una politica sempre più necrofila: ma che altro possiamo fare se non cercare di tenere accese quelle poche luci di un pensiero critico?
“Nadia Fusini ha tradotto in questi giorni questo testo struggente, e lo ha fatto come atto di resistenza alla guerra: a questa sporca guerra di conquista nazionalista, e ad ogni altra guerra. Pubblicarlo qui oggi è il nostro modo di essere vicini alle donne ucraine sotto le bombe russe, e alle donne russe le cui vite sono ora diversamente distrutte. Nessuno come Virginia Woolf ha saputo esprimere la radicale alterità delle donne rispetto alla guerra: eterno “gioco” bestiale dei maschi, frutto della loro (della nostra) puerile e omicida volontà di potenza. Se qualcuno avesse ancora un dubbio sul fatto che liberarsi dal dominio maschile (nei pensieri, nelle parole, nelle opere) non è un obiettivo (solo) delle donne, ma di tutta l’umanità, questo drammatico 8 marzo di guerra serve a toglierselo una volta per tutte.” (Tomaso Montanari)

… I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi – non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati – rimarremo al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio disarmata stanotte. Eppure se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà, e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti o cibo. Ma c’è un altro modo di combattere per la libertà senza armi; possiamo combattere con la mente. Possiamo ‘fabbricare’ idee, che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone nella mente. Ce n’era uno questa mattina, che ronzava nel Times; era una donna che diceva: “Le donne non hanno voce nelle questioni politiche”. Non c’è nessuna donna nel Gabinetto; né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee, e sono in grado di attuarle, sono uomini maschi. Ecco un pensiero che affossa il pensiero, e incoraggia l’irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Ma rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un’arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità, solo perché la nostra capacità ci espone magari all’insulto, al disprezzo? “Non cesserò di combattere con la mente” scrive Blake. Combattere con la mente2 significa pensare contro la corrente, e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta. Straripa a parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo, e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d’aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera: lui imprigionato nella sua macchina con un’arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all’aperto, a ballare, o a teatro, o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? “Hitler!” esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos’è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo, e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo, e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. “Le donne capaci” così diceva Lady Astor nel Times di stamani, “vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell’inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini”. È vero, noi siamo ostacolate. E questa sera siamo tutti egualmente prigionieri: gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso; e lo stesso vale per noi. E allora pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l’inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione; il desiderio di dominare e schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano, e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto ‒ donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba. I vetri della finestra tremano. I cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone, che imitano i colori delle foglie d’autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle nove ci dirà: “Quarantaquattro aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, dieci dal fuoco antiaereo”. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, dev’essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell’avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi. Il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello ‒ un’altra citazione: “Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale e la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti, e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni, quello era il colmo della speranza… A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto…”. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell’ultima guerra. Davanti alle quali, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo “disarmo” su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Otello non farà più il suo mestiere, ma sarà sempre Otello. Il giovane aviatore su in cielo non è guidato soltanto dalle voci degli altoparlanti; è guidato da voci che ha dentro di sé ‒ antichi istinti, istinti incoraggiati e nutriti dall’educazione e dalla tradizione. Lo dobbiamo biasimare per questo? Si potrebbe forse sopprimere l’istinto materno, al comando di un gruppo di politici seduti intorno al tavolo? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: “Fare figli sarà ristretto a una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate” ‒ lo accetteremmo? O non dovremmo dire: “L’istinto materno è la gloria della donna. A questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto…”. Ma se fosse necessario, per il benessere dell’umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata, e l’istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero. Gli uomini le aiuterebbero. Le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli. Offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra3 lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l’amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l’istinto al combattimento, l’inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l’uomo per la perdita delle armi. Il rumore di sega sulle nostre teste aumenta. Tutti i riflettori puntano in alto. Verso un punto che sta esattamente sopra questo tetto. In qualunque momento può cadere una bomba in questa stanza. Uno due tre quattro cinque sei… passano i secondi. La bomba non cade. Ma durante i secondi di attesa, il pensiero si blocca. Anche il sentire si blocca, tranne la sensazione opaca della paura. Un chiodo crocefigge l’essere tutto contro un’asse di legno duro. L’emozione della paura e dell’odio è sterile, non fertile. Non appena la paura passa, la mente si riprende e d’istinto rivive e cerca di creare. Siccome la stanza è al buio, creare può soltanto grazie alla memoria. Si protende verso il ricordo di altri agosti ‒ a Bayreuth, a sentire aWagner; a Roma, a passeggiare per la campagna romana; a Londra. Riaffiorano le voci degli amici. Frammenti di poesia. Ognuno di questi pensieri, anche nella memoria, è assai più positivo, rinfrescante, consolatore e creativo di quell’opaco spavento, fatto di paura e di odio. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, gli dobbiamo aprire l’accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all’aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese, se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l’aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano. Poi smettono. Probabilmente l’incursore è stato colpito dietro il colle. L’altro giorno, uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese, ha detto a chi l’ha catturato: “Come sono contento che il combattimento è finito!”. Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta, e una donna inglese gli ha dato una tazza di tè. Questo starebbe a dimostrare che se si riesce a liberare l’uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d’estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all’altro. E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: “Si svegliano i cacciatori in America…”. Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino, e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, a nanna …
MARCEL PROUST
Ci sono tre fuochi che alimentano il grande romanzo di Proust e che funzionano da veri e propri attrattori. Il primo è assai noto: la petite madeleine. Il secondo e il terzo li possiamo rinvenire una volta arrivati alla fine, al Tempo ritrovato, che chiude il cerchio della narrazione e permette uno sguardo retrospettivo anche da parte del lettore.

La madeleine è l’infinitamente piccolo che spalanca le porte su un universo narrativo. L’innesco della memoria soggettiva, potenzialmente senza limiti, appare come una specie di big bang emozionale, l’istante da cui tutto prende avvio e poi acquisisce la sua forma strada facendo, adattandosi plasticamente all’ambiente che si metamorfizza insieme a esso. La madeleine non è dunque una metonimia: essa non rappresenta nella parte il tutto, bensì l’evento che dà vita al tutto, la singolarità irriducibile che anche per i fisici è una barriera che non può essere superata. Cosa c’era prima del Big Bang è una domanda assurda e lo è anche il chiedersi cosa c’era prima della madeleine. Per Proust è l’evento singolare da cui prende vita un cosmo; egli non ha bisogno di alcuna metafora di partenza, solo di un innesco e degli altri due fuochi che incontreremo più avanti. Marcel Proust quell’innesco lo ha cercato più volte e altrettante volte perduto durante tutta la sua vita, sia di narratore sia di uomo; fino a quando incontra l’interazione che fa nascere il suo cosmo interiore. La madeleine è questo. Nel Tempo ritrovato, tale cosmo (che per Proust è finito e non infinito come pensavano certi suoi critici) implode come un universo – appunto – che si riduce alla fine a quel nucleo denso nel quale torna a rinchiudersi. Il Narratore, a quel punto, esce dal teatro che ha costruito e nella parte finale dell’opera ci offre le sue meditazioni sull’arte e sul tempo, che non per caso è proprio l’ultima parola del romanzo.
Nel cosmo tutti i tempi sono presenti e potenzialmente sono tutti contemporanei o addirittura – secondo la descrizione quantistica della materia – è il tempo stesso a non esserci, almeno nelle modalità percettive che ne abbiamo noi esseri umani e le interazioni che accadono fra le particelle possono non portare a niente. Anche i salotti rappresentati dal Narratore non portano a nulla, le orbite intorno ad amori più o meno consumati o immaginati, i meandri di relazioni mai del tutto risolte, cioè tutto quello che costituisce il grande teatro messo in scena nella Recherche, non alludono ad altro se non a se stessi: nel cosmo non ci sono metafore.
La direzionalità e la scelta progettuale sono gli altri attrattori che ancora mancavano. Nel cosmo di Proust avvengono sì delle interazioni per lo più inutili come quelle delle particelle elementari, ma elevando un certo gusto francese per gli eccessi della frivolezza a etica ed estetica della scrittura, alla fine il Narratore trova l’interazione che permette a quel cosmo, prima di esistere e di essere narrato, poi di venire ridotto a un nucleo d’inesistenza e insignificanza. Cos’è allora il tempo ritrovato? Non è il riscatto di quel mondo, ma una liberazione dal medesimo. Ci sono pagine e pagine durante le quali non avviene niente, non perché nei romanzi si cerchino per forza la trama e l’intreccio ottocenteschi (che pure non mancano nella Recherche)1, ma perché il gioco di rimandi, divagazioni, descrizioni, sembra non avere alcun nesso fra ciò che precede e ciò che segue. Poi, improvvisamente la materia s’addensa e allora i flussi di narrazione danno vita a una costellazione e a un sistema di pianeti che girano intorno a soli più o meno grandi che possono essere il salotto dei Guermantes, oppure le estenuanti vicissitudini degli amori di Swann; ma specialmente l’amicizia del Narratore con Robert de Saint-Loup, che occupa una posizione rilevante nel romanzo e nella quale il Narratore condensa molte esperienze reali di amicizie amorose del suo alter ego che vive e non scrive. 2
L’io vivente che il Narratore rappresenta accanto a Robert, è un uomo che perde molto della sua goffaggine, appare persino spontaneo, può abbandonarsi a slanci che con una donna non riesce a concedersi, se non in modo traslato. C’entra l’omosessualità più o meno inconscia? C’entra eccome; tuttavia, e pur non sottovalutando affatto tale questione, scelgo un diverso punto di vista, anche perché la centralità del tema omosessuale riguarderà maggiormente altre parti dell’opera piuttosto che il rapporto con Saint Loup.
Le ultime due pagine de All’ombra delle fanciulle in fiore, dicono molto al proposito. Siamo a Balbec (una località inventata nella quale sono condensate molte di quelle che videro Marcel ospite insieme alla madre), a fine stagione; l’umidità – che Marcel sia il Narratore soffrono in modo particolare a causa della sua grave forma di asma cronica – sarà la ragione della rapida partenza, che lo costringerà a lasciare Albertine Simonet e le sue amiche. Questo è il registro, in parte autobiografico per quel che attiene la malattia. Vi è però una seconda causa di quella repentina partenza e cioè la telefonata grazie alla quale il Narratore si rende conto delle condizioni di salute della nonna. Tuttavia, tale telefonata sarà più importante per un’altra parte del romanzo, proprio quella dedicata al ricordo della nonna defunta, fra le pagine altissime dell’opera.
Quando il filo della memoria comincia a svolgersi risalendo a Balbec, il Narratore non rivive gli incontri mattutini con Albertine e le sue amiche – le fanciulle in fiore – ma il suo ritiro serale, anzi una vera e propria clausura protetta dalla solerzia inattaccabile della governante Francoise. Diretto in modo inflessibile da lei, che spilla le tende della camera affinché il suo addormentamento al buio non sia soggetto a deroghe e nemmeno a spiragli, rimangono i suoni del concerto, le voci delle amiche che – colui che vive e non scrive – non può raggiungere sul molo. Quel mondo femminile gli è precluso in molti modi e per lui rimane un geroglifico; se ricorda le sere in cui non poteva essere con loro, è anche perché il Narratore può accendere meglio l’immaginazione. Al di là della natura del suo rapporto personale con Robert, per il Narratore è il mondo maschile quello in cui si trova a proprio agio. Quando una sera andrà a trovare Robert in caserma, si scopre improvvisamente libero, ha persino l’ardire di chiedergli se può dormire lì. Robert lo accoglie con amorevole amicizia, solo stupendosi un poco che l’amico preferisca passare la notte in una caserma piuttosto che nell’elegante e comodo albergo dove alloggia: non c’è nulla che faccia pensare ad altro. La scelta, infatti, ha una sua logica interna e psicologica, che ha un precedente nella vita reale di Marcel Proust e cioè la scelta di arruolarsi volontario nell’esercito dopo la scuola, periodo di cui serberà un buon ricordo.2 Il Narratore sperimenta, la notte in cui dorme in caserma, il sapore della libertà, ma anche di una relazione che può vivere, non importa di che natura sia; al contrario di quelle con le donne, rispetto alle quali riesce sempre a mettersi in una posizione asimmetrica. La caserma per lui diventa il rovescio di quella stanza totalmente oscurata nella quale stentava ad addormentarsi. Trascorrendo i giorni insieme all’amico, s’interessa persino alle strategie militari, alle tattiche, segue affascinato tutto ciò che riguarda quel mondo maschile nel quale finalmente si sente a proprio agio e libero. Il militarismo e la guerra, però, non c’entrano; anzi Marcel – quando si deciderà finalmente a diventare Proust Narratore, scriverà alcune delle pagine più mirabili e memorabili della Recherche proprio contro la guerra.
Finzione e verità.
Il tempo ritrovato è dunque il suggello e il precipitato dell’intera Recherche. Si tratta di una circostanza del tutto evidente, ma a rendere ancor più concreta tale costatazione, ma specialmente ad attribuire a tale particolare di per sé ovvio, una decisiva importanza, sono state per me le pagine illuminanti scritte da Mariolina Bongiovanni Bertini proprio nelle introduzioni alle diverse parti del romanzo (mi riferisco all’edizione di Einaudi), ma specialmente a quella de Il Tempo ritrovato. Bertini ricostruisce la genesi dell’intera opera, ma nel mettere bene in fila fatti già noti e specialmente dando l’importanza che merita a un intervento polemico di Proust verso i suoi critici, permette di considerare in modo diverso e specialmente con uno spessore diverso, il problema della genesi dell’opera. Partiamo dai fatti e cioè la difficoltà incontrata da Proust nel pubblicare la sua opera. Bertini va subito al nocciolo della questione ricordando che più di un critico la riteneva fatta solo di divagazioni, senza una progettualità o un filo che cucisse insieme quelli che ho definito i pianeti del cosmo proustiano, come se fossero invece frammenti disordinati e caotici, non di un cosmo, ma di un caos. Bertini a quel punto ricorda la perentorietà con cui Proust si decise a tagliar corto con quella polemica rivelando di avere scritto l’ultimo capitolo e anche l’ultima pagina del romanzo subito dopo avere scritto il primo capitolo e di questo offre ampia testimonianza come ricorda Bertini stessa. Di per sé la rivelazione potrebbe non sembrare importante, nel senso che solo il lettore ingenuo può pensare che se sta leggendo un romanzo dall’inizio alla fine esso sia stato anche scritto dall’inizio alla fine. Non è quasi mai vero, ma è diverso il peso specifico di questa circostanza rispetto a un autore piuttosto che un altro. Nel caso di Proust è un dato rilevantissimo, perché dimostra come egli avesse bene in mente che il suo era un cosmo finito e non un caos, prima di tutto; che aveva una conclusione e che le divagazioni erano una scelta stilistica sostenuta però da altrettanto rigore nell’avere in mente fin da subito la conclusione dell’opera. Il progetto c’era eccome! ma questo porta con sé anche qualche altra conseguenza. Nel Tempo ritrovato il Narratore non finge di spiegarci il suo cosmo a posteriori e quindi con il senno di poi, ma lo fa in anticipo nascondendolo al lettore fino alla fine. La direzionalità e la scelta della conclusione permettono al Narratore di distruggere la prigione in cui il vivente s’era trovato rinchiuso e che si decise a rompere dopo la morte di entrambi i genitori, ma specialmente della madre.
Nella seconda parte del tempo ritrovato, quando Marcel Proust si ritrova a una matiné salottiera dopo tanti anni che non vi si recava, rappresenta quel mondo come una sfilata in maschera di personaggi grotteschi; ma mentre noi saremmo condotti a credere che questo sia semplicemente il finale della storia con le sue consapevolezze postume, il Narratore questo finale lo aveva scritto anni prima! Il Narratore è un grande cattivo, nel senso che è consapevole fin dall’inizio che quelle interazioni, quei salotti, quei personaggi, sono maschere grottesche e in molti casi sordide, meschine e persino oscene! La parte essoterica del suo progetto è il teatro, il grande teatro, evocato dalla petite madeleine, e lo fa anche per portare Marcel fuori dalla prigione, che non era costituita solo da quelle interazioni inutili, ma anche dal suo male, dalla sua speciale malattia che non è l’asma e che finalmente il Narratore nomina nel romanzo: la pigrizia, la paresse, così parente dell’ennui baudleriano. Il gioco fra memoria volontaria e memoria involontaria permette a Proust di giostrarsi fra i due registri esoterico ed essoterico, ma è la memoria volontaria indirizzata a un progetto a governare il suo cosmo, un cosmo – per uscire dalla metafora fisica – in cui sono l’intelligenza e la sagacia del Narratore a immettere il soffio di vita che altrimenti non ci sarebbe e la sola madeleine come innesco non sarebbe bastata. Cosa rende possibile questo? Il tempo ovviamente, perché a differenza delle interazioni quantistiche, il tempo della vita ha una dolorosa direzionalità, ma è proprio questa che dà senso alla vita: se il tempo che ci spetta fosse eterno, come pensava inconsciamente il giovane Marcel, che molto ne perdeva, la vita non avrebbe senso.
Ho definito prima il Narratore un grande cattivo: mi domando ora se nell’opera ci sia una forma di pietas, oppure no. I personaggi grotteschi che nel Tempo ritrovato sfilano per l’ultima volta davanti al Narratore, nella loro decadenza già decaduta, possono far pensare a una sorta di giudizio universale, ma è proprio allora che il Narratore abbassa i toni. Lo fa nel solo momento in cui poteva farlo e nel solo modo in cui poteva farlo e cioè riportando per l’ultima volta anche Marcel, il vivente, all’interno dell’opera e di quei salotti. Di quel mondo Proust ha fatto parte nella sua prima vita e non può e non vuole ergersi a giudice, tratta se stesso come loro, vede con ironia, nella loro vecchiaia, la sua incipiente: solo nell’arte e nel linguaggio può diventare giudice, perché è quella per lui la sola misura etica che può esplicitare anche nell’opera. Il suo grande teatro è ottocentesco e anche precedente; forse per un francese la questione della fuoriuscita dell’aristocrazia dalla porta della storia e dei molti rientri dalla finestra, ha un peso specifico diverso che non per altre culture, visto che lì una rivoluzione c’è stata. La finzione di un tempo che è sia contemporaneo sia rivolto all’indietro è presente dall’inizio alla fine nel romanzo, ma il tempo ritrovato può esserlo solo nell’arte e nella scrittura. Infatti, dopo essersi congedato per l’ultima volta dal grande teatro, il Narratore, nella parte finale dell’ultimo libro, ci offre un’ampia meditazione sulle ragioni dell’arte e sul tempo. In questo la sua finzione è del tutto moderna e consapevole perché la sua poetica entra come riflessione nell’opera stessa. Quanto alla pietas, essa compare qui e là nel testo, verso un personaggio o l’altro, una situazione o l’altra, ma essa non può svolgere alcuna funzione redentrice e su questo il Narratore è inflessibile: alla fine non salva nessuno di quei personaggi, neppure Robert de Saint Loup. Addirittura nella parte iniziale del tempo ritrovato rappresenta quasi tutti i personaggi nelle situazioni più sordide che si possono immaginare, visto che il tempo non è solo tiranno ma anche veritiero, nel senso che accentua i tratti di ciascuno per quello che è e vuole essere: dunque siamo lontani da una pietas cristiana, se mai vicini a un atteggiamento che può ricordare l’esortazione che Virgilio rivolge a Dante alla fine del quarto canto dell’Inferno: Non ragioniam di lor ma guarda e passa. Se c’è una pietas, come io penso, essa sta nell’atteggiamento finalmente umile di chi si pone di fronte alla propria vita in modo etico e consapevole, decidendo di affrontare il proprio male di vivere. La Recherche, sia nel titolo sia nelle sue modalità è proprio questo. Alla fine il Narratore, lo abbiamo visto, nomina il tarlo che aveva roso il vivente Marcel: la pigrizia, una malattia della volontà che si traduce in un atteggiamento di apparente noncuranza, che lo ha rinchiuso per anni nell’insensatezza delle abitudini, che gli ha fatto fare le scelte più astruse e tutte inconcludenti, scrivere tante pagine inutili di quel romanzo – Jean Santeuil – lasciato incompleto al suo destino, dal momento che era soltanto uno dei molti modi di sfuggire all’opera che gli urgeva. Alla fine si arrende e da quel momento e non senza qualche apprensione, che ci rivela proprio nel tempo ritrovato (Sono ancora in tempo?), comincia una delle più grandi avventure del secolo: un romanzo che è anche, aldilà dei suoi grandi meriti letterari, una straordinaria esperienza di autoanalisi, diversa da quella del fondatore della psicoanalisi per gli strumenti che usa, ma non meno decisiva.
L’arte, lo stile, il tempo.
La parte finale del Tempo ritrovato è dedicata alla meditazione sull’opera stessa, che Proust autore riporta nella partitura del romanzo, mentre sull’arte come forma più alta di verità vi è poco da aggiungere alle sue parole, se non per constatare la classicità di tale espressione. Il suo pensiero si rifà a un canone che verrà messo in crisi dalle avanguardie storiche, dall’avvento della cultura di massa, dalla riflessione di filosofi e critici: per esempio la caduta del dogma dell’autorialità, posta da Benjamin nel suo saggio sulla Riproducibilità tecnica dell’opera d’arte. Il Narratore non ignora affatto tutto ciò e di questo vi è traccia nel grande teatro che mette in scena. Sono brevi incursioni, flash, ma quanto basta per comprendere che l’idea di un Marcel Proust (metto insieme il narratore al vivente in questo caso), lontano e avulso dalla storia del suo tempo sia da abbandonare: basti ricordare quanto spazio ha sia nell’opera sia nella sua vita l’affaire Dreyfus, che Proust seguì personalmente anche nelle sue fasi processuali con una partecipazione emotiva non tanto diversa – in definitiva – da quella di Zola; non manca persino un pensiero sulla Rivoluzione Bolscevica. Lo stesso vale per i giudizi sulla guerra e il nazionalismo. Tuttavia, rispetto a quella che sarà la revisione novecentesca dei canoni letterari e artistici, egli si mantiene fedele a una sensibilità precedente. Giova tuttavia ricordare quanto la sua convinzione che l’arte avesse un valore conoscitivo e non solo estetico, fosse lontana anni luce da quello slogan così in voga in quegli anni: l’art pour l’art. Proust si allontana dal canone realista e dalla verosimiglianza in tutte le sue forme, ma salva un nucleo centrale di quella grande poetica e cioè proprio il valore conoscitivo e non solo estetico dell’arte. Alla crisi del romanzo realista, egli non oppone uno scivolamento nel decadentismo e nelle forme estetizzanti dell’art pour l’art, pur risentendo come tutti del clima culturale in cui vive. Il contesto decadente è per lui un punto di partenza e non di arrivo e certe descrizioni di alcuni personaggi, nel loro impasto di comicità e tragicità (Charlus nel bordello di una Parigi in guerra per esempio), non sono poi così lontane dal Balzac.
Sul suo stile sontuoso è difficile aggiungere qualcosa rispetto a ciò che hanno scritto illustri critici come Giovanni Macchia e altri: la capacità di mantenere dall’inizio alla fine un registro alto, in qualche caso altissimo, ma che non scade nell’estetismo fine a se stesso. Su tali passaggi dell’opera non c’è molto da dire. Vorrei allora affrontare da un punto di vista che già è stato posto da altri, cui ho accennato io stesso qui e là, ma forse non del tutto elaborato: la strategia compositiva, che è cosa diversa sia dallo stile, sia dalla progettualità consapevole di cui si è già detto – e dei referenti filosofici e scientifici eventuali della medesima. Torniamo sia alla formazione di Proust, sia al contesto culturale e scientifico in cui l’opera è stata scritta. L’unico debito che Proust riconosce per iscritto è verso il suo docente filosofia del liceo Condorcet, Darlu, ma solo per dire che la sua influenza fu negativa. Poi ci sono i giudizi espliciti e impliciti che si trovano a profusione nel romanzo. E allora ecco Niestche, Wagner, ma anche Bergotte e Vinteuil figure chiave e maschere dietro le quali si nascondono illustri poeti e narratori. A tutto questo va aggiunta la sua assidua frequentazione dei corsi di Bergson alla Sorbona, una frequentazione non estemporanea e indice, di un vivo interesse. Proust, nelle poche interviste rilasciate e interventi, ha sempre negato l’influenza di Bergson sulla scrittura del romanzo e non si può davvero credergli in questo caso; ma forse quello che lui intende con la negazione è qualcosa di diverso. È difficile pensare che il concetto di memoria involontaria, per esempio, così centrale nella riflessione di Bergson, sia estraneo all’opera di Proust e che dunque un qualche debito nei suoi confronti andrebbe riconosciuto; ma a ben vedere si tratta di un’influenza esterna, che lo ha aiutato a distinguere le funzioni diverse della memoria volontaria da quella involontaria e di giostrarsi così fra i due diversi registri: il grande teatro lasciato alla memoria involontaria, la direzionalità del progetto a quella volontaria. Tutto questo a ben vedere fa parte dell’impalcatura che serve a costruire l’opera. Poi c’è lo stile di cui si è già detto, infine c’è la tessitura di tutto questo nel farsi dell’opera; infine il tempo, il grande convitato di pietra e proprio intorno alla questione del tempo erano accadute cose non da poco all’inizio del secolo. Con la relatività ristretta di Einstein (1905) e poi quella generale, era venuta meno la concezione tradizionale del tempo, in particolare rispetto a due concetti chiave: l’essere da un lato lo sfondo neutro seppure direzionato dal passato al futuro delle azioni umane (Kant), poi il concetto di simultaneità, forse la cosa più sconvolgente e cioè che osservatori diversi a velocità diverse non solo vedono cose diverse ma non abitano lo stesso tempo ma due tempi diversi. Proust ne tiene conto e il suo romanzo ne risente? La mia risposta tende a essere affermativa; ma più in generale la strategia compositiva sembra essere influenzata proprio da una riflessione sul tempo che non era affatto estranea alla filosofia francese di quel momento storico e cito tre nomi importanti: Bergson, Roupnel e Bachelard. Si aprono qui due ipotesi entrambe affascinanti: Proust si è avvalso di queste fonti? Oppure è giunto per strade sue a una strategia compositiva in cui la concezione del tempo viene sconvolta fino a risultare assai prossima a quella proposta dalla nuova fisica? Vediamo di districare la matassa, partendo dalla filosofia.
I tre che ho citato in precedenza hanno in comune il fatto che sono tornati a porsi dei problemi filosofici in relazione alle scoperte scientifiche. Si può dire che con loro torna la filosofia naturalistica, che dopo Newton, Kant, Leibnitz e Cartesio, era finita un po’ in secondo piano, potendo contare su epigoni o continuatori dei quattro grandi che ho citato; oppure nel caso di Leopardi, per sottolineare l’indifferenza della natura rispetto alle vicende umane. Durante tutto l’ottocento, ma anche per gran parte del ‘900 sono i filosofi della storia o dell’etica a dominare il campo con poche eccezioni e un discorso a se stante per quanto riguarda Nietsche. Con Wittgenstein siamo in un altro universo che ha a che fare con il linguaggio. I tre filosofi francesi sono i primi (Heidegger verrà dopo), a porsi un interrogativo che è fondamentale per una filosofia naturalistica e cioè che cos’è il tempo. Tale interrogativo, dimenticato di fatto dopo Kant, torna invece in primo piano dopo la relatività ristretta di Einstein e Bergson, Roupnel e Bachelard sono i primi a porsi la domanda, forse non tutti e tre con la stessa pregnanza. Cominciamo da Roupnel e Bergson perché nel loro caso è facile, dal momento che le due tesi non potrebbero essere più estreme e contrarie e dunque chiarissime. Per il primo il tempo è l’istante per il secondo la durata. Bachelard, nel saggio dal titolo La filosofia dell’istante, tenterà una sintesi che tiene conto proprio della relatività, anche se si apre su un orizzonte più vasto che ci riporterà proprio a Proust e al suo romanzo. Il tentativo di Bachelard è importante perché non si tratta di una conciliazione fra Bergson e Roupnel. Bacherlard sta dalla parte del secondo, anche per lui il tempo è l’istante, ma cerca di dedurre quello che per Bergson è la durata, partendo dalle proposizioni di Roupnel e giungendo alla definizione di durata come abitudine.
Cosa c’entra Proust in tutto questo? Proviamo a porci alcune domande. Che cosa è il tempo nella Recherche? Se pensiamo agli attrattori, a che cosa li possiamo avvicinare? La petite madeleine, per analogia, è un istante o una durata? I flussi narrativi, ricorrenti, che in certi momenti addensano la narrazione e innalzano di colpo lo stile come vanno come vanno considerati? La progettualità cosciente che gli fa scrivere l’ultimo capitolo subito dopo il primo c’entra o non con il tempo o si tratta solo di un brillante artificio letterario? E nella strategia compositiva interna, nella tessitura, dove finisce il tempo? L’istante, quello che all’inizio di questo saggio ho indicato con il termine di big bang emozionale, costituisce l’innesco e la petite madeleine come infinitamente piccolo può essere paragonata all’istante; ma essa come abbiamo visto è solo l’innesco. Se pensiamo invece ai flussi narrativi, li possiamo suddividere in diverse tipologie. Alcuni di essi si possono rapportare a quello che Bachelard indica come abitudine, ma anche alla coazione a ripetere, in altri casi no e questi sono forse i più interessanti. Torno allora a quelle due pagine finali de All’ombra delle fanciulle in fiore di cui si è già detto. In esse la memoria involontaria torna alle serate di clausura a Balbec, durante le quali il protagonista poteva solo udire i suoni di ciò che accadeva all’esterno e immaginarsi persino di udire le voci delle sue amiche sul molo. Prima, in tutta la parte precedente, del romanzo e a dispetto del titolo, è la relazione con Robert de Saint Loup a tenere banco. Sappiamo, tuttavia, che vi era una seconda ragione di quella partenza. Invitato dall’amico Robert a servirsi di una delle mirabili invenzioni della tecnologia del momento e cioè il telefono, aveva chiamato la nonna e aveva capito che qualcosa di grave stava accadendo. La nonna stava male e ciò lo spinse a un rapido ritorno. Tuttavia, quando alla fine del volume, la memoria lo riporta a Balbec sono le serate di clausura al centro del suo ricordo. Non c’è niente di male che siano due le cause di quella improvvisa partenza, ma si tratta – per come vengono trattate nel romanzo – di due memorie diverse e che danno vita a flussi di narrazione assai diversi che corrispondono anche a tempi diversi. A leggerli sembra di rivivere in altro modo le pagine in cui Bachelard sostiene che non vi è in realtà nessuna continuità fra l’io che si muove in certi momenti con le azioni che lo stesso io compie in altri. In sostanza il tempo non è un continuum che si possa sommare: si possono sommare solo quei tempi che appartengono a una medesima tipologia di azioni. Su questa ipotesi, che farebbe la felicità di Borges, oggi possiamo sorridere perché – pur riconoscendo che sono speculazioni importanti nate dalle scoperte della fisica novecentesca – abbiamo ormai a disposizione molti testi di ottima divulgazione che ci aiutano a capire come la descrizione quantistica della materia non ci aiuti a capire meglio cosa sia il tempo umano. Nelle interazioni fra le particelle elementari il tempo è reversibile o addirittura non esiste per come lo viviamo e quelle interazioni non sortiscono in nulla. La vita è una singolarità eccezionale ed è in quel momento che nasce tutto, dal tempo umano alla sua direzionalità. Allora, tornando all’inizio di questo saggio, inutile domandarsi cosa esistesse prima del Big Bang o prima della madeleine. Entrambi nella loro enorme diversità sono due singolarità che danno vita a interazioni sensate. Credo che per lungo tempo si sia cercato inconsciamente se nei meandri della nuova fisica vi fosse una strada verso l’immortalità, oppure verso dio: siamo sempre lì! Invece tali interazioni quantistiche portano al niente, neppure al nulla che è pur sempre un significante filosofico, ma al niente, come è stato rappresentato in modo involontariamente straordinario in un testo teatrale come La classe è morta di Kantor.
Quello di Proust, volendo trovare una conclusione a questo scritto sulla sua opera è un universo parallelo, un organismo simile a quello in cui il vivente vive, ma nel quale non scrive o viceversa, per parafrasare il celebre detto di Proust medesimo. Nel realismo, la pretesa è quella della verosimiglianza e cioè – sempre parafrasando Proust – un mondo in cui vivere e scrivere possono marciare insieme. Questa fu l’unità ottocentesca durante la quale si consolidò la grande arte borghese, ma tale unità entrò in crisi nei decenni finali del secolo quando altri soggetti sociali, prima di tutto, posero fine all’illusione universalistica del pensiero borghese. Proust come altri – Huysman e Zola per esempio – reagirono alla crisi, che era anche una crisi del romanzo, in modi diversi: il primo fuggendo in un estetismo decomposto ancor più che decadente, il secondo accentuando ed estremizzando alcune caratteristiche del realismo medesimo. La Recherche si muove da un contesto estetico più vicino al decadentismo che a Zola, ma poi vira in una direzione diversa anche se forse non ancora del tutto compresa ed esplorata. Il disagio psichico, la malattia, la perversione, non sono nella Recherche soltanto un segno di decadenza, ma anche l’espressione di un allargamento della coscienza all’esplorazione del sé: la psicoanalisi è sullo sfondo anche se non entra direttamente nel testo e Freud non viene mai citato, mentre è del tutto assente in Zola, la cui illeggibilità (specialmente in certi romanzi), è data fra l’altro anche dalla disperante meccanicità dei personaggi. Essi non rappresentano più neppure certe tipologie umane, come avviene nel grande romanzo realista o nelle distorsioni caricaturali di Daumier, ma sono marionette senz’anima, unidimensionali fino ad apparire del tutto irrealistiche.
1 Alberto Beretta Anguissola, nella sua puntuale ricostruzione del romanzo, riconduce ai suoi termini reali una leggenda che è circolata da subito sulla Recherche: che in essa non sarebbe rintracciabile alcuna trama, per usare un termine tradizionale della narrativa ottocentesca. È possibile invece sfatare tale convinzione, anche se tale trama costituisce una specie di sottotesto che non sempre segue un andamento lineare, ma essa esiste eccome, ma non bisogna intenderla pensando ai canoni del realismo ottocentesco. In: Proust guida alla Rcherche. Carocci editore, Bologna 2018.
2 Questa espressione la troviamo in forme diverse anche in Proust medesimo, per il quale le due azioni di vivere e di scrivere sono sostanzialmente in alternativa. Il tema viene ripreso anche da Giovanni Macchia.
2 La biografia di Marcel Proust è costellata di aneddoti ed episodi su cui lui stesso si è diffuso più volte. Parlarne è necessario perché essa è strettamente collegata all’opera. Il giovane Marcel teneva un po’ in ansia suo padre perché era difficile capire bene cosa volesse fare nella vita. Oggetto di cure e protezioni per via della sua grave forma di asma, alcune sue scelte sembrano segnate da una forma di ribellione verso quel’eccesso di attenzioni da parte della madre. Come considerare per esempio la scelta inopinata dell’arruolamento volontario subito dopo gli studi? Dopo la carriera militare finita nel nulla è la volta degli studi giuridici, poi improvvisamente, Marcel scopre la borsa e la finanza e vi si butta a capofitto. Il giudizio comico e lapidario del suo consulente, può bastare a chiudere anche quella strada: “Marcel Proust appartiene a quella categoria d’investitori che comprano i titoli quando il loro prezzo sale e li vendono quando il loro prezzo scende.” Tuttavia e a dispetto dal titolo del suo romanzo che ci rivela fra le altre cose, quanto tempo il giovane Marcel abbia effettivamente perso, si sbaglierebbe a ritenere tutto questo legato semplicemente a certe caratteristiche di ceto o di classe – se vogliamo: a un atteggiamento tipico dei rampolli dell’alta società, per cui in fin dei conti, comportarsi da flaneur non metteva a repentaglio più di tanto le loro vite e i loro patrimoni. C’è una sofferenza reale nella sua inadeguatezza al mondo, una difficoltà nel potere e nel saper scegliere che lo accompagnerà fino alla decisione di scrivere l’opera che non si decideva a scrivere, auto imponendosi come scelta volontaria la clausura che aveva segnato come obbligo esterno la sua vita. Fu allora che il brutto anatroccolo (perché si può esser brutti anatroccoli anche se circondati di cure, soldi e benessere), decise di trasformarsi in un cigno.

IL NOVELLONE DI PAOLO BORZI

Inoltro a tutti il link di youtube relativo alla presentazione del libro.
ARTI E LETTERE NEL ‘900 ITALIANO: FRA RIVOLUZIONE E INDUSTRIA. Parte prima

PREMESSA.
Nel ‘900 italiano ci sono delle peculiarità interessanti nei rapporti fra arti e industria, da un lato, arte e movimento operaio dall’altro. Si può parlare addirittura di una tradizione plurima che si è nutrita di ideali socialisti e utopie capitaliste, come quella dei Crespi, una famiglia di cotonieri di fine ‘800. Una tradizione esaurita, che ebbe notorietà fino alla fine degli anni ’70 e che fra l’altro ha diffuso anche in Italia l’interesse per l’archeologia industriale, assai più sviluppata in altri paesi europei.1 Gli esempi sono molti e distribuiti sull’intero secolo. Ne ho scelti alcuni perché meno noti di altri.

1 I cotonieri Crespi fondarono fra le altre cose anche il famoso villaggio che porta il loro nome e si trova a Trezzo d’Adda, a pochi chilometri da Milano. Furono i primi a incarnare una forma di utopia industriale fondata sul rapporto organico, seppure gerarchicamente definito, fra imprenditori, classe operaia e territorio: il villaggio ne è l’espressione emblematica, sia per la concezione architettonica che lo ispira, sia per l’ideologia che veicola e cioè l’idea di un corporativismo illuminato, con al centro la fabbrica, i quartieri operai vicino ad essa e dotati di servizi essenziali; nel punto più alto del villaggio l’abitazione della famiglia degli imprenditori e la chiesa. In rete sono facilmente disponibili siti che ne ricostruiscono la storia. La tradizione della famiglia continua in pieno ‘900 con Giulia Maria Crespi, proprietaria del Corriere della Sera e poi fondatrice del FAI.
PARTE PRIMA
Il centro Italia, fra artigianato e industria
La prima testimonianza nasce, in modo del tutto casuale, da una visita compiuta anni fa al Museo della Ceramica di Civita Castellana. La storia di questa cittadina laziale è emblematica per molte ragioni ed è piena di sorprese, legate all’artigianato e alla nascita delle prime fabbriche negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, tanto da costituire un piccolo ed eccellente polo industriale e artigianale che si è spento lentamente solo pochi decenni fa. Il Museo costituisce oggi la maggiore ricchezza della città, un esempio di cura dell’archeologia industriale e un prezioso concentrato, denso di storie che ne richiamano altre. Il Museo si trova all’interno della ex chiesa di san Giorgio, dove nel 1915-16 Ulderico Midossi aprì la Regia Scuola Professionale per l’Arte Ceramica. La tradizione falisca e civitonica, però, risale alla fine del diciottesimo secolo, quando fu fondata la fabbrica Treja per la produzione di vasellame e stoviglie. Dall’artigianato all’industria, il proliferare di piccole entità produttive continuò a crescere nel tempo. Il tornio divenne il cardine della produzione e un esemplare assai bello è conservato nella sala centrale del Museo: un manufatto degli anni ’50 che apparteneva a Osvaldo Cirioni, fondatore della ceramica MAISC. Il passaggio dalla manifattura alla fabbrica portò con sé anche un ulteriore salto di qualità verso la ceramica d’arte. Tale scelta, di cui fu sempre promotore Ulderico Midossi, diede nuovo impulso alla nascita di altre realtà produttive nei primi decenni del’900; tanto che la produzione evolse sempre più in quel senso. Artisti di fama internazionale come Duilio Cambellotti, Basilio Cascella e Assen Peikov furono coinvolti in diversi progetti; fino agli anni ’70 quando cominciò il declino e si tornò in parte a una produzione più legata all’arredamento domestico, per esempio con la produzione di sanitari. Proprio fra questi mi aggiro nella parte finale del Museo e l’occhio si sofferma sulla tazza del water closet di un colore rosso scuro, intenso e bellissimo. Il pensiero corre all’orinatoio di Duchamp e a tutto l’infinito dibattito sull’arte moderna, il design, il post moderno. Il gesto di Duchamp fu provocatorio perché a compierlo fu lui e con quel gesto iniziò il rovesciamento di valore fra l’opera e l’artista, a vantaggio del secondo: un rovesciamento che trasformò l’autore in un performer e anticipò la società narcisista o postmoderna di cui vediamo oggi gli esiti più nefasti. Un gesto come quello, infatti, non poteva che aprire la stura alla reiterazione di gesti analoghi che, nel loro essere prima di tutto delle trovate, finivano per diventare dei significanti senza più significati e senso. Fino al gesto più estremo e più intelligente di tutti: la merda d’artista di Manzoni che ebbe il merito d’indicare dove doveva per forza finire quel poderoso movimento dissacratore che ebbe in Duchamps un maestro – almeno in parte – involontario e in Andy Warhol il più grande di cattivi maestri del ‘900. Il gesto che sostituisce l’opera e che mette al primo posto il suo autore è forse il marchio distintivo dell’arte novecentesca in occidente, più dedita alla contemplazione della propria morte, ma che trova la sua origine anche nella mitologia dell’originalità ad ogni costo, che ha pure nel Romanticismo una delle sue lontane radici. La ricerca di un gesto o di una trovata che sia sempre più stupefacente del precedente, porta infatti a una nevrotica serialità e quindi alla pornografia; niente più di quest’ultima è tanto seriale da un lato, quanto sempre protesa a promettere qualcosa di nuovo ai suoi fruitori, dall’altro. Si tratta però di un nuovo impossibile, dal momento che essa non può che proporre una sequenza di pochi gesti identici a se stessi, spogliati di ogni magia e ridotti allo scheletro: come se si venisse invitati a un meraviglioso concerto e scoprire invece che si tratta della ripetizione ossessiva e senza soluzione di continuità della scala delle note musicali. Invece, quanta bellezza e quanta ironia nel bellissimo manufatto di Civita Castellana. Forse nessuno, per via del suo colore così volutamente vistoso, si metterebbe in casa un oggetto che infondo deve solo raccogliere le deiezioni di un corpo umano; ma anche se così fosse, la tazza del water al Museo della ceramica di Civita Castellana si mostra e si offre nella sua gratuità, che è sempre un dono. L’oggetto di Duchamp, invece, visto nella sua proiezione storica e alla luce di quanto è accaduto dopo di esso (o di lui come sarebbe meglio dire) appare come un oggetto inutile.

Il secondo esempio di rapporto virtuoso fra lavoro artigiano, arte e impresa, lo troviamo nell’esperienza di Luisa Sargentini Spagnoli, che fu una straordinaria protagonista dell’utopia industriale italiana. La sua storia particolarissima si presta a molte riflessioni, se non altro per l’epoca in cui è vissuta e anche perché se si facesse una domanda generica chiedendo a cento persone chi fosse Luisa Spagnoli, a quasi tutti verrebbe in mente la casa di moda e niente altro; tanto meno si ricorderebbero del suo cognome da ragazza. Invece, la famosa e prestigiosa casa fu fondata dai figli quando lei era già morta. La sua vera impresa fu precedente. Luisa Sargentini nacque a Perugia il 30 ottobre del 1877 e morì a Parigi nel 1935. Figlia di un pescivendolo e di una casalinga era una ragazza vivacissima e indipendente. Nel 1898 sposa Annibale Spagnoli e insieme rilevano la vecchia drogheria di un anziano negoziante con cui la giovane Luisa, fin da ragazzina, s’intratteneva durante le sue scorribande per la città, fra gli scherzi e le ragazzate che combinava insieme a un’amica cui rimarrà vicina per tutta la sua vita. Fu proprio questo anziano droghiere – in un certo senso un nonno acquisito – a spingerla a rilevare il negozio dopo la sua morte. L’anziano uomo si era reso ben conto delle sue capacità! Insieme al marito avviò un’attività dolciaria, la produzione di confetti. Il successo fu immediato. La mente imprenditoriale era la sua, ma ciò che più conta fu che Luisa Sargentini non dimenticò le proprie origini sociali. S’interrogò per esempio sul motivo per cui le donne non potessero accedere al lavoro e si diede delle risposte ovvie per noi, ma che a quel tempo erano rivoluzionarie: non lavoravano perché non sapevano come conciliare la maternità con la professione e nessuno offriva loro soluzioni. Dalla produzione di confetti i coniugi Spagnoli passarono ad altri generi dolciari, ma la storia della drogheria cambiò radicalmente quando Luisa propose a Francesco Buitoni, produttore della famosa pasta, quella che oggi si chiamerebbe una joint venture: unificare in una sola azienda i loro prodotti. L’imprenditore si recò personalmente al negozio di Sargentini e del marito e da anziano fondatore d’imprese fu subito ammirato dall’efficienza e dalle sue capacità imprenditoriali. Accettò la proposta, non senza qualche resistenza da parte dei suoi figli, il maggiore in particolare. Insieme fondarono la Perugina che all’inizio della Prima Guerra Mondiale poteva contare su 15 dipendenti. Alla fine della Guerra i dipendenti saranno addirittura un centinaio ed è a questo punto che Luisa Sargentini Spagnoli convinse l’azienda a introdurre le innovazioni più rivoluzionarie nel rapporto con i dipendenti: l’asilo nido interno all’azienda e l’allattamento sul lavoro senza diminuzione di salario. Come aveva pensato, l’occupazione femminile aumentò e a queste misure se ne aggiungeranno altre di natura sociale, che riguarderanno i figli delle dipendenti. La guerra mutò radicalmente la sua vita e quella della famiglia. Il marito ritornò devastato dal fronte; inoltre, non avendo alcuno spirito imprenditoriale e un temperamento piuttosto da sognatore, (era un discreto musicista), si ritrovò ai margini dell’impresa, finché nel 1923 decise di ritirarsi anche perché nel frattempo era accaduto altro e cioè l’inizio della storia d’amore fra Luisa Sargentini e Giovanni Buitoni, il minore dei figli di Francesco e di lei assai più giovane. Oltre che essere un uomo brillante, Giovanni aveva uno spirito imprenditoriale simile a quello di Luisa. Sotto il loro impulso l’azienda crebbe ulteriormente, tanto da estendere il proprio raggio d’azione all’intero mercato nazionale, facendo concorrenza all’industria dolciaria torinese. Intorno all’azienda, tuttavia, fu creato anche un ambiente sociale che faceva della fabbrica un centro di aggregazione, d’iniziative culturali e ricreative che coinvolgevano la cittadinanza perugina ben oltre i confini della fabbrica. Fu Luisa Sargentini a inventare il Bacio e l’uovo pasquale con la sorpresa e altri gadgets di cui Giovanni Buitoni aveva studiato l’importanza, grazie ad alcune esperienze all’estero. L’immagine dei due innamorati dei Baci Perugina fu opera di Federico Seneca, che peraltro aveva già collaborato con Buitoni prima della joint venture del pastificio con Luisa Sargentini. Egli s’ispirò al quadro di Hayez Il Bacio. La storia d’amore fra i due è un capitolo a parte di tutta questa vicenda e merita a sua volta qualche attenzione. Quello che è straordinario nella loro relazione è che tutti gli uomini delle due famiglie, superato lo sgomento iniziale, accettarono la situazione e loro due furono molto determinati a proteggere la loro storia d’amore, ben nota alle stesse dipendenti, ma che non suscitò mai un vero scandalo. Luisa Sargentini Spagnoli morì nel 1935 per un tumore alla gola, probabilmente dovuto all’eccesso di consumo di dolci e assaggi (non c’era un solo prodotto che uscisse dall’azienda senza passare dal suo vaglio). L’idea della casa di moda nacque ancora una volta per caso e per una sua intuizione, sebbene Luisa coltivasse l’idea fin da ragazza.

Si rese conto che i conigli d’angora che aveva ricevuto come regalo di natale, non erano solo animali da compagnia ma ancor più da curare amorevolmente e pettinare. Fu ancora una volta lei ad avere l’idea della tosatura per produrre lana d’angora e quindi maglioni e scialli di pregio. Fu una scelta virale, si direbbe oggi, tanto che a metà degli anni ’30 erano ben 8.000 gli allevatori che mandavano i loro conigli per la tosatura all’Angora Spagnoli, ormai sul punto di diventare una grande azienda. Luisa Sargentini morrà prima di vederla nascere, quasi all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sarà il figlio Mario a guidarla ma con l’aiuto dello stesso Giovanni Buitoni e degli altri famigliari. Nel ’47 nascerà La città dell’angora a Perugia. Va ricordato, infine, che l’influenza delle sue idee non venne mai meno nella gestione dell’azienda, successive alla morte di lei. Nel periodo più duro della guerra gli Spagnoli regalarono ai loro dipendenti generi di vestiario per cifre ingenti per quell’epoca. Infine Giovanni Buitoni, pur ancora giovane, non si sposò e visse, come peraltro tutti gli altri uomini della famiglia, nel culto di Luisa Sargentini Spagnoli e delle sue imprese.2 Pur nella consapevolezza che stiamo parlando di un modello paternalista ma gestito al femminile anche dopo di lei – rimane comunque giusto rilevare come le lavoratrici italiane abbiamo goduto di diritti simili e neppure tutti, solo durante la stagione degli anni ’70, grazie prima di tutto alle loro lotte e anche a quelle di quegli anni.
2 Anche Umberto Boccioni ebbe un passato da cartellonista, eseguendo diversi lavori in merito. Uno degli artisti simbolo dell’Art Nouveau, Alfons Mucha, operò ampiamente in campo pubblicitario per diverse aziende, ma anche per il cinema, ad esempio. Era la routine per molti al tempo che si affermo ancora di più alla fine degli anni ’20 e poi ’30. Un’esperienza a parte, anche per la sua durata nel tempo, fu il sodalizio di Fortunato Depero con la Campari, che si manifestò sia nelle campagne pubblicitarie negli anni ’20 e ’30, sia del disegno della bottiglietta del Campari soda nel 1932.
Il doppio effetto dell’amore, desiderio e frantumazione dell’io nella poesia di Guido Cavalcanti. Di Paolo Rabissi

| Il messaggio di un poeta ducentesco in una sorta di autocoscienza maschile. Pubblicato sulla rivista Overleft.it. Noi siàn le triste penne isbigottite… Bastano i versi del sonetto XVIII delle ‘Rime’[1] per venire a conoscenza di buona parte del mondo poetico cavalcantiano. A sorpresa, con una tecnica compositiva non insolita nel Dolce Stil Novo, scopriamo che a parlare sono gli strumenti antichi della scrittura, la penna d’oca, le forbici per farle la punta, il coltellino per raschiare la pergamena, gli oggetti che, per scrivere, l’autore ha maneggiato. Come suoi sostituti si presentano a noi (nel senso di lettori gentili, dotati di ‘intelletto d’amore’) ci pregano di ‘tenerli’, di accoglierli con pietà nella loro misera condizione, riflesso di quella cui appartiene il cuore dell’autore distrutto dall’amore. |
Il treno
Lo scompartimento si sta lentamente riempiendo. Il convoglio è un po’ vecchiotto e calure di origini diverse si sovrappongono le une alle altre, mescolandosi. Le campate in ferro e vetro della Stazione Centrale di Milano rilasciano un umidore dall’inconfondibile olezzo metallico, che sommato alla cappa che grava sulla città, produce un impasto dolciastro e fumigante… poi ci sono i treni che arrivano e rilasciano calore senza vapore. Infine, i corpi sudati …

La giovane donna in divisa da ferroviere alza il braccio e fischia, il treno si muove cigolando e mentre sta per uscire del tutto dalle campate, si ode un avviso emesso dal centro messaggi della stazione …
A causa di un convoglio guasto, fermo sulla linea, i treni in direzione di …
La lontananza dalla fonte emittente rende confusa l’ultima parte del messaggio, nessuno ha udito bene e nello scompartimento c’è un attimo di sospensione, gli sguardi cercano quelli altrui.
Entra una giovane donna: porta sulle spalle uno zainetto, ha un’aria decisa e borbotta:
“I ritardi possono essere fino a un’ora, non ci posso credere, non ci posso credere!”, continua a ripetere…
“Ho un concerto alle 21 …”
Gli altri passeggeri seguono il suo sfogo senza intervenire, lei si accascia sul sedile, arrivano altri che s’erano sbagliati carrozza e raggiungono finalmente i loro posti, sbuffando. Intanto il treno ha superato di slancio Lambrate e si sta avvicinando alla stazione di Rogoredo.
Salgono in tanti e tutti chiedono ai nuovi venuti se ci sono notizie fresche.
“I problemi sono sulla linea di Torino”.
“E anche su questa a Lodi”.
Il treno riparte e l’altoparlante di bordo comincia a gracchiare.
“Ecco, adesso ci dicono qualcosa”.
Macché! La comunicazione riguarda bevande e merendine che transiteranno con il carrellino. Tutti ritornano alle loro occupazioni, un uomo seduto al finestrino scuote la testa e ridacchia.
“Mai che avvisino di qualcosa, inutile sperarlo.”
“Ma se il ritardo è su Torino perché mai dovrebbero avvisarci?”
“È vera la notizia del guasto a Lodi? “
“Sembra di sì, un comunicato della stazione diceva questo.”
“Cosa esattamente?”
“Beh, non so di preciso, me lo hanno riferito”.
Qualcuno afferra il telefonino sospirando e comincia ad annunciare il presumibile ritardo. L’uomo al finestrino si rivolge alla ragazza:
“Perché non va a chiederlo direttamente al capotreno?”
Lei lo guarda sorpresa, poi assente decisa.
“Ma sì, ci vado, almeno faccio qualcosa di utile per tutti.”
Nel silenzio che segue gli sguardi si piegano verso la campagna assolata e immobile, che contrasta con il rumore di ferraglia, amplificato dai finestrini tutti aperti. Capannoni e campi coltivati, gente per le strade o intenta ai lavori agricoli. Quando la ragazza rientra gli sguardi sono puntati su di lei.
“Non ne sa nulla.”
L’uomo al finestrino scuote la testa e ride.
“È la solita Italia di sempre, se neppure il capotreno sa cosa sta succedendo.”
“Mi ha detto che abbiamo un ritardo di cinque minuti per via di un passaggio a livello incustodito.”
Detto ciò, la ragazza si rimette gli auricolari, ma poi ci ripensa:
“È un uomo strano il capotreno.”
“Cosa intende?”
“Ma, non so, qualcosa di indefinibile nello sguardo.”
“O dio, non saremo guidati da un matto!” esclama una signora.
“No, un matto no.”
Lodi è prossima: nessun rallentamento, poi ecco la stazione e nello scompartimento si diffonde sui volti una ventata di ottimismo. Sono in tanti sul marciapiede in attesa, ma quando il serpentone si ferma, c’è smarrimento sulla banchina, alcuni formano crocchio, c’è una grande incertezza e sono in pochi a salire.
“Il treno viene dirottato su Voghera e poi su Genova.”
“Come?”
“Sì, lo hanno appena detto.”
“Ma siete sicuri?”
L’altoparlante della stazione toglie ogni dubbio. Dopo la deviazione si proseguirà fino a Livorno e da lì ripartirà per Firenze riprendendo poi il percorso verso sud.
“Sapete se ferma anche a Levanto?” chiede un uomo con apprensione, mentre un altro comincia a dare in escandescenze.
“Ma io devo andare a Bologna.”
“Vado a chiederlo al capotreno”.
“E io come faccio!, che devo essere a Bologna, devo raggiungere la mia fidanzata… ci sposiamo proprio domani pomeriggio.”
“Oh congratulazioni!” esclamano tutti.
“Chiedo anche per quello, ma non ci dovrebbero essere problemi; da Firenze lei prende un treno per Bologna e in un’ora e mezza ci arriva.”
“Sì, ma meglio chiedere.”
Quando la ragazza esce, gli altri si rivolgo al futuro sposo, mentre la voce del matrimonio si diffonde in tutta la carrozza.
La campagna fra Lodi e Voghera mette allegria, con tutti quei campi ben squadrati e coltivati, immagine di un ordine che è lavoro e amore per la terra.
La ragazza ritorna dopo una decina di minuti.
“Lei è fortunato”, dice rivolta all’uomo che vuole scendere a Levanto e prosegue rivolta allo sposo: “per Bologna bisogna domandare più tardi, ci potrebbero essere dei ritardi anche sulla tratta inversa da Firenze, ma non è certo.”
“Ma mi tolga una curiosità.” dice poi un altro rivolto all’uomo che deve scendere a Levanto.
“Prego” ribatte lui.
“Come mai è salito su questo treno se doveva andare in Liguria visto che in teoria dovremmo essere sulla linea per Roma e Napoli?”
Gli altri, intanto, sono tutti affaccendati: chi ad avvisare ancora, chi ad agitarsi per cercare di avere ulteriori informazioni.
L’uomo si stringe nelle spalle e tergiversa, tanto che, chi ha posto la domanda, sente il bisogno di scusarsi; poi l’annuncio di una donna a voce alta distoglie l’attenzione di entrambi.
“Ecco Voghera, forse ci diranno qualcosa di più!”
Lo sposo sta telefonando, un po’ preoccupato.
“E il capotreno che impressione le ha fatto questa volta?”
“Si è voltato verso di me per parlarmi, mentre prima non lo aveva fatto; è un uomo molto anziano, mi ha sorpreso che ci fossero macchinisti della sua età, oppure non so, li porta male.”
La signora la guarda diffidente quanto mai e allora la giovane donna prosegue:
“Non si preoccupi, è un uomo per bene, con gli occhi dolci, pieni di malinconia.”
“La sua è un descrizione molto romantica, non mi dica che ci ha fatto un pensierino.”
Scoppiano tutti in una sonora risata. Poi è l’altoparlante della stazione ad azzittire tutti.
A causa dei noti inconvenienti e al fine di alleviare il disagio dei passeggeri, la direzione delle ferrovie ha deciso di aggiungere a questo treno un vagone ristorante che entrerà in funzione fra poco.
La notizia è accolta con un giubilo che corre lungo tutto il treno, come un’iniezione di energia elettrica.
“Offro un brindisi” comunica lo sposo che ha riacquistato il proprio buon umore dopo la telefonata.
“Evviva lo sposo!”
Intanto, il treno ha ripreso la sua corsa verso Genova: Arquata Scrivia, Ronco, le montagne e le valli ancora assolate, il treno lento da una galleria all’altra.
La ragazza del concerto chiama l’amica e le comunica che non arriverà, poi decide di proseguire il viaggio.
“Che ci vado a fare e poi le ho tutte qui le sue canzoni, ho i suoi Cd, preferisco rimanere con voi fino alla fine di questa avventura.”
“Ma di quale concerto stiamo parlando.”
“Vecchioni e De Andrè insieme.”
“Che strano, non ne ho mai sentito parlare.”
“Per il brindisi aspettiamo di vedere il mare, che ne dite?”
“Ma dove sarà diretto poi il treno? Riprenderà il suo tragitto normale e poi? Dopo tutto questo tempo?”
“Già, ma non si era detto Livorno?”
“Sì, ma poi di nuovo a Firenze sulla tratta originaria.”
“Non avvisano mai, la conosco questa storia; non avvisano mai, arriva quando arriva” ripete sconsolatamente l’uomo al finestrino.
Intanto, il treno si è infilato nella galleria che porta alla stazione di Porta Principe.
Sono in molti a salire e pochissimi a scendere, ma anche chi riparte si concede una sigaretta sui marciapiedi.
“Per il brindisi aspettiamo di vedere il mare, che ne dite?”
“Ma certo!” ribadisce lo sposo.
A Brignole salgono pochi altri.
La ragazza ha di nuovo raggiunto il capotreno e subito dopo informa tutti i presenti, come se parlasse a un comizio.
“La corsa proseguirà fino a Roma di certo, ma la meta definitiva non è ancora chiara.”
Ecco il mare, è il momento del brindisi.
Le spiagge si stanno svuotando e la fila di ombrelloni mossi dal vento nasconde il vuoto. Tutto sembra scivolare lentamente verso l’immobilità, ma le voci nella carrozza ristorante si fanno sempre più allegre.
“Si è informata se stiamo recuperando il ritardo?” chiede ancora l’uomo che deve scendere a Levanto.
“Pare di sì, vedrà che alla fine sarà solo un quarto d’ora. Non si unisce a noi?”
L’uomo, finalmente tranquillizzato, accetta volentieri, mentre un altro lo guarda perplesso.
“La vedo in apprensione.”
“Beh, un po’ sì, sono atteso e non mi piace arrivare in ritardo.”
“Forse c’è dell’altro. ”
L’uomo si schernisce un poco e arrossisce:
“Sì, sono atteso da una donna.”
“Si vede caro amico, si vede.”
Lo sposo sta parlando con una signora anziana.
“Mi maritai sessant’anni fa, proprio in questi giorni, lei mi ha fatto tornare con la memoria a quel momento e le sono grato, anche se mio marito mi ha lasciato da tempo. Sto andando da lui, a Pompei, è sepolto là; lei me lo ha un po’ restituito. ”
Lo sposo le accarezza la spalla con un gesto affettuoso, poi la guarda: gli occhi tristi e lucenti al tempo stesso, sembrano persi in una lontananza senza fine. Lo sposo l’osserva irretito, poi la donna si rivolge di nuovo a lui con un sospiro e un sorriso.
“Ma ora alzo il bicchiere, non voglio tediarla con la mia tristezza.”
Intanto, si sta per arrivare a Chiavari. In città regna un silenzio irreale, le figure che transitano sotto i portici prospicienti la stazione sono ripiegate su di sé, raccolte, indifferenti agli altri. La spiaggia è completamente deserta.
Dentro il vagone ristorante, invece, la musica, le chiacchiere, il clima conviviale che sta contagiando sempre di più tutti i viaggiatori.
La notizia dello sposo a bordo si è diffusa per tutto il treno ed è un continuo andirivieni nel ristorante, dove i brindisi si susseguono interrotti ogni tanto dalla richiesta di informazioni, cui si presta volentieri la giovane donna.
“Neppure il capotreno sa precisamente dove siamo diretti, dopo Napoli tutto diventa confuso.” ribadisce lei e prosegue: “Però secondo me lui non mi ha detto tutto, mi ha guardato con occhi paterni, rassicuranti, come a dire di non preoccuparmi.”
“Ma come, non si era detto Roma?” chiede un altro perplesso, ma la sua domanda cade nel vuoto.
“Lo vada a trovare ogni tanto, mi sembra che con lei parli questo benedetto uomo.”
“Tutto avviene per caso e all’improvviso, come sempre. La conosco molto bene questa linea, chi sale su questo treno, non sa bene dove va a finire. ”
L’uomo che ha parlato è comparso da poco nel vagone ristorante.
“Lei dove va?”
“Io? Non ho meta, viaggio da tempo durante la notte. Non ho più casa e non posso permettermi di pagare un affitto e allora ho fatto un abbonamento annuale notturno con le ferrovie. Dormo sui treni e scendo il mattino dove capita; in questo modo, con la pensione che mi ritrovo, riesco a vivere.”
“Ma non è dignitoso che un uomo anziano venga trattato così, è indegno di un paese civile!” sbotta una signora che ha orecchiato la conversazione. Il tono alto della voce attira altri e altre nel crocchio che si è formato intorno all’uomo, elegantemente vestito, che racconta.
“Questo abito me lo tengo da conto, ne ho solo un altro che è appeso nel vagone destinato ai controllori, ormai mi conoscono tutti.”
“Sì, la nostra è una società che tratta gli anziani come ferri vecchi.”
“Con i giovani fa anche di peggio.” s’inserisce un altro.
“Vedo che avete ancora voglia di indignarvi, io l’ho persa da tempo questa volontà e poi, tutto sommato, sono contento della vita che faccio. In treno mi rispettano tutti, a volte incontro le stesse persone un anno dopo e anche più, le loro vite entrano nella mia: è bello condividere le vite altrui, dare qualche buon consiglio se richiesto, è come leggere un romanzo che non finisce mai.”
“Sa che forse un po’ la invidio? Ma che fa poi di giorno?”
“Aspetto la sera, là dove mi trovo, a volte è un po’ faticoso, durante l’inverno, ma cerco di andare sempre verso sud quando fa molto freddo: di solito, leggo nei bar e scrivo, qualche volta vado al cinema o a teatro.”
“Ne avrà incontrata di gente e anche qualche avventura, sia sincero!”
L’uomo sorride tristemente a quelle parole, perso in chissà quali ricordi.
“Perché non ci racconta qualcosa.”
Lui si schermisce: “Mah, non so raccontare è difficile non sono così bravo.”
“Ma sì che può farlo, tutti siamo un po’ narratori, la vita è un romanzo per tutti, non solo per i personaggi che poi finiscono nei libri, non crede?”
La giovane donna che ha parlato è appena entrata nello scompartimento e si sta godendo il suo bicchiere di vino. Lo alza in direzione dell’uomo.
“Ma, se proprio volete.”
Fu uno dei primi che incontrai: da poco più di un mese avevo sottoscritto l’abbonamento. Lui salì per ultimo alla stazione di Como. Non mi capitava spesso di raggiungere quella città perché si trova a ridosso della Svizzera e da lì si può solo tornare indietro; poi a me le città di lago non piacciono, mettono tristezza. Lui salì e chiese se fosse libero il posto di fronte al mio e quando si sedette notai anche il suo bagaglio, un borsa piccola che conteneva un album di fotografie. Il treno arrivava a Milano intorno alle undici, poi io avrei preso quello notturno per Roma, che viaggia tutta la notte facendo proprio questa linea; sarei arrivato al mattino presto alla stazione Ostiense. Lui invece proseguiva per Mantova. Aprì subito l’album e si mise a sfogliarlo; intravedevo qualcuna di quelle fotografia lui ogni tanto alzava lo sguardo e mi sorrideva malinconicamente. Non resistetti alla tentazione e gli chiesi dove stesse andando. Lui mi rispose subito, capii che aveva voglia di parlare. Mi spiegò che prendeva tutte le sere quel treno a quell’ora perché molti anni prima aveva incontrato, proprio nello stesso scompartimento dove siamo seduti insieme (Carrozza 6 sei posto 42 mi precisò con meticolosità), una donna che faceva quel percorso in senso inverso rispetto a lui, allora. Lei si recava a lavorare – così mi disse l’uomo – a Milano, senza specificare niente altro, lui tornava a casa a Milano, alla fine di una giornata in ufficio. Non mi disse altro per il momento e continuò a sfogliare il suo album. Mi passarono molti pensieri per la testa, ma rimasi in silenzio. Fu lui a riprendere il discorso. È la sola che ho in cui siamo insieme e mi mostra una fotografia di loro due abbracciati, proprio nello stesso scompartimento in cui ci troviamo ora. Lei indossa una minigonna di plastica rossa e calze nere a rete, molto vistose. “è un angelo” mi disse l’uomo e io non gli risposi nulla…
Intanto nello scompartimento è entrata altra gente, il narratore s’interrompe per fare posto, ma quando s’accinge a continuare ecco che l’altoparlante comincia di nuovo a gracchiare.
“Vede che avevo ragione? Meno di un quarto d’ora di ritardo. Allora è proprio deciso a lasciarci?”
L’uomo diretto a Levanto sorride felice e alza il calice per un nuovo brindisi, mentre il narratore ha ripreso il suo racconto.
“Mi ripromisi di cercarla sempre, quel viaggio fu indimenticabile per me; niente è più vero di ciò che si incontra per caso, perciò viaggio sempre su questo treno.”
Io lo osservavo perplesso, ma gli occhi di quell’uomo erano velati e caldi, la sua era una malinconia che chiedeva silenzio e un’accettazione religiosa.”
Il crocchio intorno al narratore si è fatto ancora più grande e non tutti riescono a sentire.
“Vado a cercare un microfono, lei aspetti a continuare” dice la ragazza che era appena entrata.
“Mah lei cosa ne pensa del racconto, a me sembra assai strano, ma quella ragazza….”
“Sì capisco cosa lei vuole dire, ma sa le storie d’amore sono tutte un po’ strane.”
“Beh ma qui l’amore sembra c’entri poco, incontrare una prostituta che ritorna dal suo lavoro in treno non è poi un incontro così originale.”
“Ma forse non è quello il senso del racconto” s’intromette uno degli ultimi arrivati.
“Mi sono perso la prima parte…”
“O ci vuole poco a riassumerla. Un uomo che se ne torna a casa incontra questa signora e si innamora di lei, tanto che la cerca tutte le sere sullo stesso treno.”
“Ma il narratore non ha detto che si era innamorato di lei.”
“Ma era implicito nel suo racconto.”
“Lei dice?”
“Ma certo! Forse il messaggio è proprio quello: l’amore è imprevedibile, ci si può anche innamorare di una prostituta che si è vista su un treno.”
“Sì ma poi non la vede più.”
“Beh aspettiamo la conclusione per dirlo.”
“Ecco il microfono.”
La ragazza, aiutata da un uomo, piazza l’aggeggio su un tavolino del vagone ristorante, il narratore si siede e ricomincia a raccontare.
Ero molto incerto: come potevo entrare nel mistero di quell’uomo e interrogarlo, senza violarne il bisogno di silenzio? Lui continuava a guardare la fotografia, io sbirciavo per coglierne altri particolari. Lui sospirò a lungo, ripose tutto e si rivolse a me con un sorriso triste.
“Il destino, il destino” mormorò sottovoce, poi si avviò verso la porta. Eravamo giunti a Milano, infatti, non vi era più tempo. Lui mi guardò e allora mi decisi a parlare:
“Domani sarà ancora su questo treno?”
“Sì certo e lei?”
Rimasi un momento interdetto poi mi lasciai sfuggire che ci sarei tornato. Pensavo dentro di me che fosse tutto assurdo, ma ormai lo avevo detto. Sarei tornato a Como per ritrovarlo la sera dopo, e la cosa sul momento m’inquietò. Tornavo in un luogo in cui mi ripromettevo ogni volta di non tornare più; quel lago che ogni tanto tracima, quelle montagne basse e incombenti, mi trasmettevano in senso di paura. Ma ormai mi sembrava di essere legato a quello strano passeggero da un destino comune che pure non sapevo decifrare. Forse è proprio questa la magia: a volte il racconto di una vita altrui è più affascinante persino della propria di ciò che si può ancora farne e volerne fare. Ma ora scusatemi, vi prego, ho sonno, sono molto stanco, se volete possiamo continuare domani.
La fine momentanea del racconto fu accolta da tutti con un senso di meraviglia e sgomento, da altri con stizza o una punta di delusione.
L’altoparlante annunciò proprio in quel mentre che si stava per entrare nella stazione di Levanto e tutti si rivolsero all’uomo che stava per scendere. Egli però era rimasto seduto e immobile al suo posto, il solo movimento visibile sul suo corpo erano le lacrime che scendevano sul volto, pian piano. Il treno si ferma, ma egli non accenna a scendere e allora tutti si rivolgono verso di lui, trattenendo il fiato.
“No, non ne sono più convinto di scendere, anzi non lo sono affatto, resto con voi.”
Poi, quasi a scusarsi, abbassa lo sguardo e si schernisce dietro il fazzoletto: allora è la giovane donna, che lo sta osservando con un sorriso malinconico, a iniziare un applauso che diviene un vero e proprio scroscio di palmi che si battono a un ritmo sempre più accelerato. L’uomo allora ride a singhiozzi e ringrazia.
Il treno è ora fermo sul binario più lontano e in molti s’avvicinano al finestrino e guardano fuori.
Dietro la stazione, verso l’interno, il bosco immerso nel buio del crepuscolo, è forato dalle luci dei pochi casolari.
“Mi è sempre piaciuta quella valle, i suoi silenzi, la sua asprezza che si apre improvvisa su paesaggi immensi, il vento, ma è tardi, è tardi” poi si rivolge agli altri con un sorriso.
Nessuno sale, le porte si chiudono rapidamente, con un rumore che non ammette repliche.
“Ecco un altro che sente ancora fortemente il richiamo della vita.”
“Già, è molto poetico quello che ha detto.”
“Sì, per i poeti che ci stanno oggi era poetico, certo!”
La prima stella in cielo e sul mare sempre più scuro, spalanca la notte, ma nel vagone ristorante nessuno sembra accorgersene: si continua a bere e a chiacchierare.
“Ma perché non ci dice di più di questo capotreno signorina? Ormai è diventato un personaggio, un po’ come questa donna misteriosa del racconto.”
“È un uomo molto anziano, ma i suoi occhi sembrano quelli di un ventenne, neri e bellissimi, emanano una grande forza.”
“Si direbbe che lei se ne stia invaghendo.”
“Le donne giovani come lei sono sempre un po’ alla ricerca di un padre….”
“A dire il vero potrebbe essere mio nonno.”
“Addirittura!”
“Sì è un uomo che sembra provenire da un altro tempo.”
La nuova galleria, distoglie per un momento l’attenzione, mentre l’ennesima bottiglia di spumante fa il suo ingresso in scena con il botto. Si entra nella stazione di La Spezia, proprio sull’ultimo binario, il più lontano dall’edifico, che s’intravede appena sullo sfondo.
Il treno prosegue veloce verso la Versilia mentre l’altoparlante ricomincia a gracchiare. Tutti trattengono il fiato in attesa del messaggio.
Si informano i passeggeri che il treno, dopo Firenze, proseguirà fino a Napoli dove verrà presa la decisione definitiva sulla sua destinazione ultima. Per chi volesse recarsi a Bologna ci sono invece delle difficoltà perché la tratta appenninica è interrotta nei due sensi.

“Oh Dio!, e adesso che faccio? Devo avvisare subito la mia Giulia!”
“Giulia? Un nome nobile e antico.”
“È un professoressa di paleontologia.”
“Nomen homen…”
“Mulier, se mai”
“Perché non le dice di raggiungerci Firenze? Se lei venisse sul treno.”
“Già ma poi dove ci sposiamo?”
“Qui, fra noi, il capotreno è un ufficiale giudiziario in determinate circostanze, come il capitano di una nave: mi sembra che l’emergenza giustifichi questa prassi inusuale.”
“Mah, non so che dire, ma poi noi, noi vogliamo sposarci anche in chiesa!”
“Ma ci sarà pure un sacerdote in mezzo a tutta questa gente!”
“Lei pensa davvero che si possa fare?”
“Ma certo! Signorina, visto che ormai ci è abituata: può recarsi un’altra volta dal capotreno e chiedere tutto a lui?”
La ragazza, felice di potere ancora una volta rendersi utile, esce frettolosamente; intanto lo sposo telefona a Giulia. Nella carrozza ristorante la ressa si è fatta ancora più fitta, insieme a una frenesia contagiosa e sono tutti in attesa della ragazza. Lei entra di corsa nella con un sorriso raggiante, preceduta solo per un attimo dall’altoparlante: è il capotreno a parlare, richiamando l’attenzione di tutti e allora lei, che ha sulla punta delle labbra la buona notizia, si zittisce, lasciando all’uomo al comando di chiedere tramite la radio che un prete lo raggiunga nel locomotore per comunicazioni importanti.
Un evviva corale accoglie la notizia e subito lo sposo lo comunica a Giulia. Sarà lei a raggiungerli in auto sul convoglio, prima di Livorno.
Non è lunga l’attesa, fra un brindisi e l’altro e le voci che ormai si stanno alzando di tono, ecco un pretino fare il suo ingresso nella carrozza: giovane e impacciato come tutti i giovani, visibilmente a mal partito, avanza lentamente cercando con gli occhi chi sia lo sposo; ma è la signora anziana a intervenire e a toglierlo dagli impacci.
“Venga, venga padre e non abbia paura, potrei essere sua nonna sa! Li mi ricorda tanto mio nipote.”
Il sacerdote si profonde in un inchino e si schernisce un poco “era missionario in Africa!” prosegue imperterrita l’anziana signora, mentre il giovane prete si accomoda a un tavolo dove si siede anche lo sposo che gli tende la mano.
“Sono io la causa del suo disturbo padre; io e la mia Giulia e futura moglie. Crede si possa fare questo matrimonio?”
La battuta solleva la risata di qualcuno, lo sconcerto di altri, il silenzio dei più. Anche il pretino sempre più impacciato nel rispondere, incerto forse se cogliere l’implicita ironia della citazione, forse neppure voluta, oppure di passarci sopra.
“Io sono qui e se posso esser utile, ma devo chiedere l’autorizzazione al mio Vescovo”.
“Oh, le hanno sempre trovate le soluzioni, per qualsiasi cosa, vuole che non la trovino proprio ora? Non ci credo. Può farlo subito per cortesia?”
“Ma quando la futura sposa ci raggiungere?”
“Fra non molto è per questo che le chiedevo se può sentire il Vescovo al più presto.”
Il pretino, superato il momento d’imbarazzo, si apparta con il proprio cellulare.
“E così suo nipote era un missionario in Africa?”
La signora guarda l’uomo che le sta di fronte, l’altro allora le tende la mano e si presenta. “Mi scuso per essermi intromesso, ma sono sempre curioso dell’Africa ci andai anch’io per diversi anni: mi chiamo Spartaco.”
“Missionario anche lei?” chiede un po’ incerta la signora.
“No, no, non proprio almeno.”
La signora scuote il capo, poi riprende dopo avere sorseggiato il vino: “Era in Mozambico, in una missione sulla costa.”
“Oh conosco quel paese, pensi che collaborai con il primo governo, li aiutavo a costruire la ferrovia, sono ingegnere.”
“E rivoluzionario.” aggiunge la signora con un sorriso beffardo.
“Sì, diciamo che a quei tempi lo ero o se preferisce ero convinto di esserlo.”
“Già, anche mio nipote era convinto di fare del bene allora.”
“Perché”, ma non c’è tempo di continuare perché il pretino fattosi improvvisamente disinvolto se ne esce con un sonoro: “Sì, si può fare, ho l’autorizzazione del Vescovo.”
L’annuncio è accolto da applausi e altre grida di evviva, mentre lo sposo si è ritirato in un luogo più silenzioso per telefonare a Giulia. Torna poco dopo.
“Mi richiama fra qualche minuto, speriamo che possa raggiungerci.”
“Vedrà che andrà tutto bene.”
Gli altri s’interrogano con lo sguardo, ma poi le attenzioni sono tutte rivolte di nuovo al prete, che discute amabilmente con tutti
Squilla di nuovo il telefono e lo sposo si allontana leggermente per parlare con più calma.
“La mia Giulia ci sta raggiungendo, sarà qui al massimo fra un’ora!”
“Evviva la sposa!”
Al suo arrivo la carrozza è in piena festa, il prete attende un po’ imbarazzato che la cerimonia possa avere inizio.
“I testimoni, ci vogliono i testimoni.”
Si offrono in tanti e si arriva in fretta a una soluzione.
Al termine un nuovo evviva corale accoglie il fatidico bacio fra i due sposi, sotto gli occhi imbarazzati del pretino che si sta togliendo i paramenti.
“Rimanga con noi padre”, ma lui si schernisce.
“Vi lascio alla vostra festa, preferisco coricarmi” e s’allontana rapidamente.
L’accavallarsi delle voci, dei brindisi, l’allegria più semplice, tutto quello che ci si può immaginare stava dentro quella carrozza che diventava sempre più grande, con i suoi ospiti che continuavano ad arrivare da ogni parte.
“Ma qui manca la musica, come si può festeggiare senza musica!”
“E senza ballare” aggiunge una signora. Tutti gli occhi sono di nuovo rivolti alla ragazza.
“Ma lei non doveva andare a un concerto questa sera? E non ha forse detto che ha della musica con sé”
“Certo.”
Senza dire altro la ragazza, prende un computer dal suo zainetto, inserisce il cd e la musica inizia come uno scoppio fragoroso, a un ritmo cui i corpi rispondono subito, a ondate successive.
Ridere, ridere, ridere ancora,
ora la guerra paura non fa,
brucian le divise nel fuoco la sera,
brucia nella gola vino alla sazietà,
musica di tamburelli fino all’aurora,
il soldato che tutta la notte ballò
vide fra la folla quella nera signora,
vide che cercava lui, e si spaventò
Dal fondo della sala qualcuno invoca che si alzi il volume, mentre altri hanno rimediato degli altoparlanti di fortuna che piazzano agli angoli della carrozza.
Il ritmo diviene sempre più frenetico, i corpi sobbalzano e danzano come un’onda di piena.
La danza prosegue incessante al ritmo della canzone che viene continuamente riproposta, finché i corpi esausti cominciano a sciogliersi l’uno dopo l’altro dal gruppo. È notte tarda quando il vagone ristorante si svuota quasi completamente. Gli sposi si sono ritirati in uno scompartimento preparato per loro, solo il viaggiatore notturno, la giovane donna, l’uomo che doveva scendere a Levanto e quello seduto al finestrino indugiano ancora. Poco dopo anche l’anziana signora si aggiunge alla compagnia.
“Alla mia età si dorme poco, ormai, il tempo è tutto contratto, si rinsecchisce come una ruga sul volte e poi mi piace vegliare.”
“Io sono fortunato invece, il sonno mi prende sempre ed è profondo, mi sveglio quando il treno sta per arrivare e così durante il giorno posso andarmene in giro senza problemi.”
“Già per lei sarebbe davvero un guaio l’insonnia, ma vedo che questa sera lei fa un’eccezione.”
La ragazza ha tolto dalla sua borsa alcuni cd e li fa scorrere fra le mani.
“Perché non mette qualcosa?”
“Già buona idea”, ribadisce l’uomo del finestrino.
“Mi raccomando, scelga qualcosa di adatto, non così ritmato.”
Lei armeggia e poi si indirizza decisa su un disco che tiene appena fra due dita.
“È un De Andrè molto particolare, vi piacerà …”
Tutti tacciono in attesa ma il cd tarda a partire.
L’uomo che doveva scendere a Levanto scuote il capo tristemente, fra gli altri solo la signora anziana annuisce; poi è il suono a estendersi per tutto lo scompartimento. I camerieri si fermano, ascoltano come tutti, mentre i bicchieri rimangono sospesi a mezz’aria.
Se dalla carne mia già corrosa
dove il mio cuore ha battuto il tempo
dovesse nascere un giorno una rosa
la do alla donna che mi offrì il suo pianto
per ogni palpito del suo cuore
le rendo un petalo rosso d’amore
per ogni palpito del suo cuore
le rendo un petalo rosso d’amore
Tutti seguono in silenzio le note, senza dirselo hanno formato un cerchio e si tengono tutti per mano.
Quando è di nuovo silenzio si accorgono che il treno sta di nuovo rallentando e allora tutti si accalcano al finestrino. Roma è vicina.
La città è immersa in un sonno profondo, le poche automobili sul tratto di Tiburtina che corre di fianco alla ferrovia sono immobili, pur trovandosi al centro della carreggiata.
Le rotaie divelte e i cantieri, sembrano voragini, squarci nella terra rivoltata e lasciata a mucchi di fianco a macchine utensili e gru che sembrano mostri antidiluviani, nel buio. La stazione è deserta e non appena il treno la supera, vira verso Ostiense e Città del Vaticano. In prossimità del Tevere il convoglio rallenta di nuovo. Il fiume s’intravvede appena, come un nero fondale, un abisso scuro e tranquillo. Superato il ponte ecco profilarsi sullo sfondo la cupola di san Pietro, ricoperta da un fogliame che da lontano sembra una decorazione barocca. La luna incombente e chiarissima illumina a giorno il colonnato della piazza. Su ognuna delle colonne i viluppi di edere e altri rampicanti costruiscono bizzarri disegni che da lontano sembrano corpi travolti in un amplesso senza fine.
“Nessuno ci è più venuto da quando se ne sono andati da qui.”
“Già, tutto lasciato com’era.”
“Quelli di prima si stanno riprendendo il luogo pian piano.”
“Già.”
Il sonno, uno dopo l’altro se li porta via tutti: chi abbandonato sul sedile, i piedi distesi alti o il capo appoggiato al braccio disteso sul piccolo tavolo.
Il primo a risvegliarsi è il viaggiatore. Si guarda intorno e sorride con tenerezza agli altri che stanno ancora dormendo. Il sole è appena spuntato da una collina a sinistra del treno che attraversa una campagna silenziosa; poi curva verso sinistra e infondo alla piana si intravede il mare. L’uomo che doveva scendere a Levanto si avvicina a lui, i due si guardano senza parlare gli occhi puntati in direzione del mare.
“Siamo vicini.”
Intanto il treno si è inoltrato in un piccolo bosco di alberi e cespugli, in mezzo al quale si delinea il profilo di un antico tempio classico. In lontananza e dai quattro punti cardinali si vedono altri convogli, scivolare l’uno accanto sui binari che si moltiplicano con l’avvicinarsi dell’ultimo tratto di corsa in direzione dei templi e del mare. Finalmente le porte della città sono vicine e tutti si accalcano ai finestrini in religioso silenzio. Lo sposo abbraccia Giulia alle spalle e lei si abbandona a lui. La vecchia indica un punto lontano e si asciuga una lacrima; è il cimitero, pensa fra sé lo sposo, ricordando il dialogo fra loro due avvenute tanto, tanto tempo fa.
Le labbra si muovono per dire qualcosa ma il suono della voce è atono, distante. Il treno è ormai vicino all’ingresso e i primi rumori della città vengono accolti con stupore. Il convoglio rallenta ancora e la porta d’ingresso appare ora in tutta la sua grandezza e quando il locomotore è giunto alla soglia il treno si arresta. C’è una fila di convogli all’ingresso, ma l’attesa è breve. Si odono le porte della prima carrozza aprirsi, è il capotreno a scendere per primo, al suo cenno tutti lo seguono dalle diverse carrozze si avviano lentamente con i loro bagagli. Alla porta d’ingresso la Gradiva e un giovane che indossa dei calzari alati salutano chi arriva con un largo sorriso, i bagagli vengono ammassati lì fuori appena prima dell’ingresso.

Si entra e la casa di Meleagro non è lontana. La superano insieme agli altri e arrivano in una larga spianata proprio in riva al mare. La folla è enorme, silenziosa, ognuno cerca un luogo dove mettersi in attesa. In fondo, proprio a ridosso della battigia, una specie di duna di sabbia più alta si sta riempiendo. Nel silenzio sono in molti ad accennare con la mano a questo o a quella che si stanno portando sulla piccola altura in quel momento.
Ora sono tutti fermi e anche la piccola collina è quasi piena, ma nessuno ancora dice qualcosa. Poi, una figura claudicante dai lunghi capelli castani venati dal bianco e una lunga veste si avvicina, sale con fatica, sedendosi a un lato estremo del medesimo. Allora, proprio al centro si alza una di loro e si rivolge alla folla:
“Venga avanti il primo!”
TI AMO
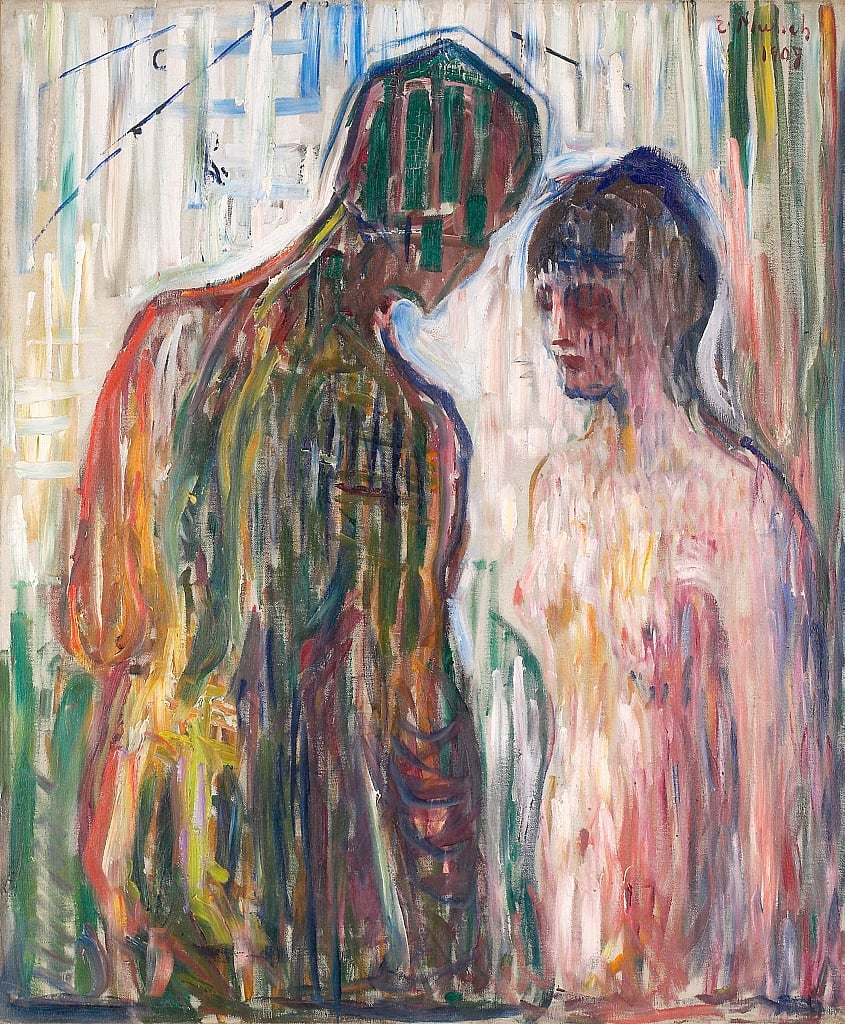
ATTO UNICO
Personaggi: A e B.
La scena è un’ampia sala con annessa cucina. A e B entrano e iniziano i preparativi di un pranzo o cena, in silenzio. Dopo un po’ si sorridono scambiandosi un rapido bacio.
A:Ti amo.
B: Perché mi dici questo? In tono leggermente apprensivo.
A: Perché ti amo.
B: Mi togli il fiato dicendolo così, adesso.
Intanto proseguono nei preparativi, tagliano della verdura, a volte insieme a volte disgiunti e continueranno a farlo durante l’intera rappresentazione.
A: Non capisco.
B: sono parole forti: che responsabilità sentirselo dire, dopo così poco tempo, non mi dai modo di difendermi.
A: è un mio atto di libertà poterlo dire, mi fa sentire bene.
B: vedi dunque che non c’entra nulla con l’amore? Ti fa sentire bene, ma mette in ansia me, è una piccola frase, ma talmente grande, che t’investe e pone nella condizione di non sapere cosa dire, a parte chi – solo per ansia – ti risponde anch’io (enfasi comica), come il cane di Pavlov. E poi non è un gesto, sono parole e le parole valgono di più.
A: diciamo che è un atto gratuito, allora; ma affermando che le parole valgono di più riconosci che non se ne può fare a meno.
B: Il linguaggio amoroso è il vero problema, le sue trappole, i suoi stereotipi. Del resto basta leggere gli epistolari di grandi scrittori e scrittrici: una noia mortale, se li paragoni ai dialoghi nelle loro opere.
A: Ma certo! Perché quando scrivono dei loro amori sono persone come tutti noi, esseri umani comuni con le loro debolezze, le loro ingenuità e persino stupidità.
B: Ma allora mi dai ragione! Se persino loro, così straordinari, così capaci di suscitare emozioni sulla carta, quando scrivono di sé e per sé sembrano dei cretini, pensa a noi che comuni lo siamo, che mai e poi mai potremmo pensare di avvicinarci alle loro altezze.
A: Ma l’amore è comune, persino banale e cretino a volte, un’operetta.
B: Sì, un’operetta che per futili ragioni rischia spesso di trasformarsi in una tragedia.
A: Oh, piantala con il tuo cinismo prèt a porter.
B: E dai era solo una battuta. Si scambiano di nuovo un bacio.
A: e poi esageri con gli epistolari, proprio tutti sono pieni di sciocchezze? .
B: Forse tutti no, ma in questo momento me ne viene in mente uno solo: quello fra Abelardo ed Eloisa.
A: Dino e Sibilla no?
B: Ma dai, un profluvio di paroloni, una volontà di esagerare che si sovrappone al testo, tanto che a volte persino la sintassi diventa claudicante. Sono forzate quelle lettere, devono esibire l’amore!
A: In effetti non hai tutti i torti e la mia era una provocazione: ma perché proprio Eloisa e Abelardo?
B: Nelle loro lettere, per come le ricordo, c’è lo sgomento della scoperta, il candore di una prima volta.
A: Perché quella magia non potrebbe ripetersi?
B: In astratto è possibile, ma nel loro caso lo era per le condizioni in cui avvenne l’incontro: straordinario, troppo straordinario. Ecco, forse soltanto gli incontri straordinari possono generare qualcosa di buono sul piano artistico. L’amore è sempre straordinario per chi lo vive, ma non come materia artistica.
A: Perché nel loro caso sì?
B: Due religiosi, un uomo e una donna che improvvisamente scoprono, ma anche s’interrogano, sull’eros e la sua natura, ne discutono la compatibilità o meno con il cristianesimo.
A: La pagarono cara entrambi, lui specialmente se non ricordo male.
B: Beh in un certo senso sì per la crudeltà con cui infierirono, ma anche lei pagò un prezzo altissimo. La cosa stupefacente è però il tempo che ci misero a condannarli. Un tempo incredibile se pensi alla loro condizione sacerdotale, non identica, ma insomma entrambi religiosi lo erano. Ci si aspetterebbe che in quattro e quattr’otto se ne fossero liberati e invece no.
A: E come te lo spieghi?
B: Mah, la mia è un’ipotesi, ma non l’ho mai ripensata più di tanto, ne parlo ora con te. Erano tempi in cui i dottori della chiesa riscoprivano la cultura greca, Aristotele, Platone: pensa a Tommaso d’Aquino.
A: Sì, ma cosa c’entrano loro due?
B: Ci arrivo. La riscoperta della cultura classica, della logica, della filosofia, aveva riaperto le porte su quel mondo dopo secoli di oblio e censura più o meno esplicita. Perché non riscoprire che vi era una via alla sapienza che passava dall’eros? Qualcuno forse si chiese se insieme alla logica aristotelica ci fosse qualcosa d’altro da recuperare da quel mondo.
A: Mi stai dicendo che di riscoperta in riscoperta si poteva andare lontano.
B: Più o meno sì, naturalmente la mia è un’ipotesi, ma come giustificare altrimenti il tempo che ci hanno messo a condannarli? Se fosse accaduto dopo sarebbero andati per le spicce.
A: o avrebbero coperto tutto.
B: Certo ed è un motivo d’interesse in più. Niente ipocrisia nel loro caso o doppia morale. Tutto è stato discusso alla luce del sole fino alla fine, naturalmente senza dimenticare i tempi. Non sto dicendo che fu un dibattito pubblico come i nostri televisivi, ma che per l’epoca tutto avvenne alla luce del sole.
A: E la conclusione fu terribile.
B: sì, ma anche la crudeltà di infierire sul corpo di Abelardo, se ci pensi, è comprensibile se la leggi in chiave di paura. Ne ebbero davvero tanta di paura e fu l’ultima volta in cui s’interrogarono sull’eros, forse perché capirono che era meglio non farlo. Meglio metterci una pietra sopra una volta per tutte.
A: Certo, non poteva che essere così. Riscoprire tutto il mondo greco voleva dire rimettere in circolo anche l’omosessualità e questo era davvero troppo per un gruppo maschile misogino e omofobico dove tutti sono vestiti da donna e si definiscono spose di Cristo! Un corto circuito vero e proprio!
Ridono entrambi.
B: E poi non sottovalutare Paolo.
A: di Tarso?
B: certo, il buon Saulo, persecutore di cristiani e omosessuale lui stesso. Due cose troppo pesanti per essere portate sulle spalle dopo la conversione. Come tutti gli ultimi arrivati era un fanatico e se ci metti l’omosessualità si raddoppia tutto: aveva troppo da farsi perdonare, altro che peccato originale!
A: accidenti, è interessante quello che dici, ma molto forte!
B: Ci conosciamo ancora poco, ma anche tu ne hai da dire di cose, ho letto sai quello che scrivi.
Si sorridono e si scambiano di nuovo un rapido bacio.
A: Da quel momento in poi sappiamo come è andata a finire, eros fuorigioco, cancellato, rimosso.
B: e le donne addirittura nemiche, il peccato e tutto il resto. L’epistolario di Eloisa e Abelardo per fortuna ci è arrivato, qualcuno non se l’è sentita di bruciarlo, sebbene facesse davvero paura.
A: Tu però, proprio ora, hai detto l’epistolario e non solo il gesto di amarsi: dunque anche per te le parole sono importanti. Non è che ne hai paura del linguaggio amoroso? O del linguaggio in quanto tale? Sorridendo maliziosamente.
Sorride anche B e insieme mettono della verdura che hanno tagliato in una grande padella.
B: Ho paura degli stereotipi. Forse si può dire solo alla fine una frase del tipo ti ho amato o amata: è dopo che lo si sa.
A: quando è troppo tardi.
B: In che senso.
A: detto come lo hai espresso ora sembra che sia da poter dire solo in punto di morte.
B: o sul punto di lasciarsi.
A: Non è un po’ una morte anche quella?
B: Senza esagerare, dai. Sì, partire è un po’ morire e anche lasciare lo è, ma non esageriamo con le metafore, la vita continua anche dopo un amore finito, lo sappiamo anche noi.
A: essere lasciati se mai.
Accendono il fuoco sotto la padella delle verdure, uno dei due prende altro dal frigorifero.
B: Come? Vuoi dire entrambi?
A: Sì, a volte lasciare è più difficile che esserlo.
B: sì questo lo credo anch’io.
Prendono una tovaglia da un cassetto e la distendono sulla tavola, in silenzio. A aggrotta la fronte, B osserva poi riprende a parlare.
B: Stai pensando a qualcosa che non vuoi dirmi.
A: È vero, ma te lo dico subito. Pensavo agli indiani.
B sta portando due piatti in tavola ma si blocca di colpo.
B: Gli indiani? Che c’entrano?
A si avvicina, sorride, prende i due piatti e li depone sul tavolo: si scambiano un rapido bacio.
A: Non gli indiani dell’India ma quelli d’America, i popoli originari del nuovo mondo. Sai come si salutavano loro?
B: No.
A: Noi diciamo comunemente come va, come stai … loro, quando due s’incontravano chiedevano: Come sto?
B segue con attenzione aggrottando la fronte, intanto prende altri due piatti e li porta in tavola, poi si siede.
B: Forse comincio a capire. Solo chi mi vede può dire come sto?
A: Sì, questo intendevano; chi guarda vede tutto, almeno rispetto a te vede anche quello che tu non vedi, come lo dici, per esempio, lo sguardo, l’occhio, il volto tirato oppure solare, il colore della pelle, se qualcosa nell’inflessione della voce comunica allegria oppure disperazione o indifferenza.
B sorride poi:
B: Beh ci sono anche gli specchi.
A rimane un attimo con le posate in mano a pensare.
A: Forse non è la stessa cosa.
B: certo che non lo è e adesso ti racconto anch’io una leggenda, non ricordo se indiana o proveniente da altre culture.
A: guarda che non è una leggenda il modo di salutarsi, ci sono evidenze.
B: e dai, mi vuoi dire che la storia è fatta solo di evidenze?
Ridono entrambi, poi sistemano le posate in silenzio e vanno ai fornelli, controllano che tutto proceda e ritornano al tavolo.
B: la leggenda è questa. Se a notte, nel buio più totale ti metti davanti a uno specchio e ti guardi intensamente, ti sembra all’inizio di non vedere nulla, poi emerge la tua fisionomia come una pellicola che s’impressiona, però i tratti sono deformati e mutanti: se resisti e continui a guardare vedrai il volto del diavolo.
A: gli ortodossi dicono qualcosa di simile, che continuando a guardare un’icona a lungo nel buio, a un certo punto tu credi che sia l’icona a fissarti e non tu lei: certo loro non pensavano al diavolo. La tua leggenda però mi ha fatto venire in mente anche un dramma di Canetti.
Entrambi in silenzio si recano di nuovo a fornelli, poi A ritorna al tavolo e sistema per bene i bicchieri, i tovaglioli.
B: Canetti ha scritto anche per il teatro?
A: sì è la parte meno conosciuta della sua opera e forse una ragione c’è: non credo siano drammi rappresentabili, ma in questo degli specchi ha un’intuizione formidabile.
B segue il discorso continuando a occuparsi delle pentole ai fornelli.
A: Nel dramma, Canetti immagina che gli specchi siano stati aboliti, nessuno può averne in casa e se non ricordo male il loro possesso è punito addirittura con sanzioni molto pesanti. Però il governo ha istituito delle case d’appuntamento, come i vecchi bordelli. Si entra, si paga, si accede a una stanza dove ci sono diversi tipi di specchi: naturalmente che visita sceglie anche quanto tempo restare.
B scoppia a ridere, anche A si associa alla risata.
B: Canetti mi sorprende sempre.
A: Sì ha ragione, però adesso non so più bene dove siamo rimasti.
B si volta verso A dopo avere spento tutti i fornelli.
B: Siamo rimasti che qui è tutto pronto.
A si alza e va al frigorifero da cui prende una bottiglia di vino.
A: E che ci attende anche un grande vino.
B porta una pentola sul tavolo e ve la deposita, A stappa la bottiglia di Champagne. Si siedono e B riempie i bicchieri. Deposita la bottiglia e guarda A intensamente:
B: Ti amo?
A: Ti amo?
Sorridono poi i due bicchieri si toccano. Buio in sala.

