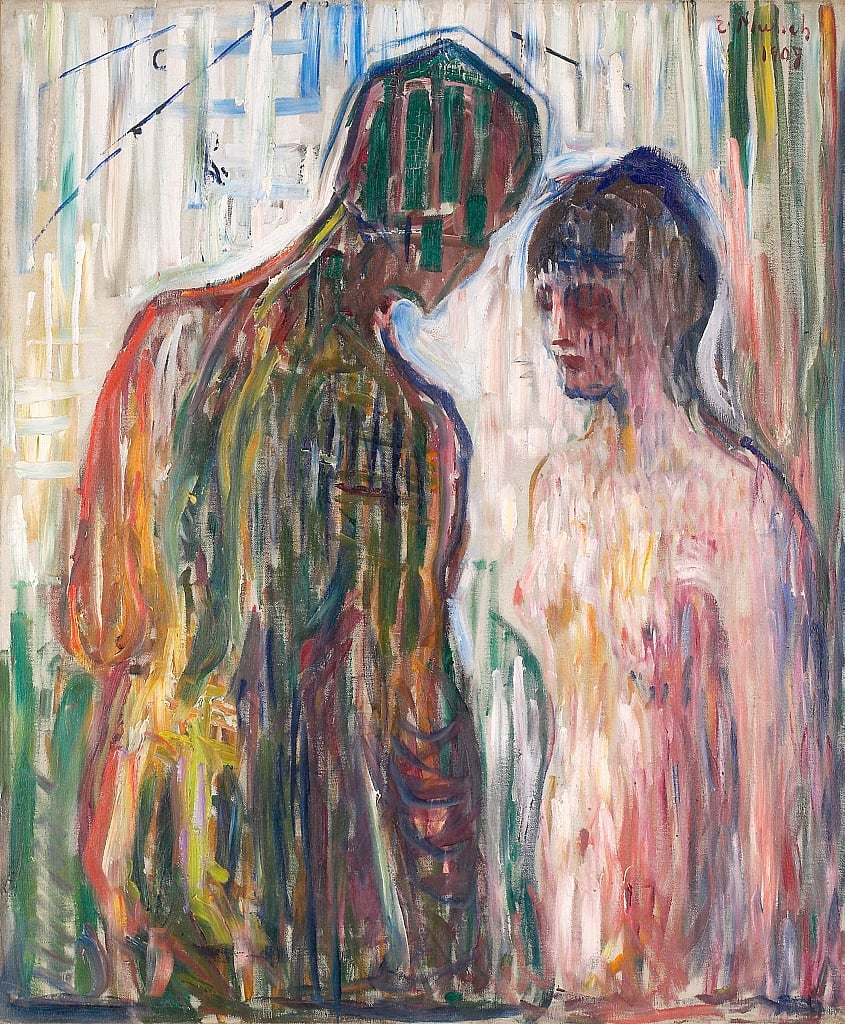ARTE AI CONFINI
Il festival Fuori asse – ai confini del circo, che si è tenuto dal 27 a 29 gennaio alla Triennale di Milano, è stato un evento artistico importante e originale. Il titolo stesso evoca una difficoltà di collocazione, che si complica ulteriormente perché la seconda parte – ai confini del circo – si potrebbe trasformare anche in ai confini del teatro. È proprio la parola confine a essere centrale, nel doppio senso del termine: limite, ma anche possibilità di attraversarlo e trasgredirlo. Per orientare chi non c’era, il festival, ideato e curato da Clara Storti, Filippo Malerba e Gaia Vimercati, è consistito di quattro spettacoli che si sono alternati nei diversi giorni: ho assistito a tre di essi mentre del quarto – ideato da Piergiorgio Milano e dal titolo White out – riporto una parte della presentazione. Il titolo, in particolare, si riferisce al:
… termine con cui in alpinismo si definisce la perdita totale di visibilità. Si crea quando il biancore uniforme delle nuvole incontra un terreno innevato e rende impossibile l’avanzare o il retrocedere … White out fonde danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo.

Seconde nascite e post umani
La scena in cui si svolge Mavara, ideata da Chiara Marchese – Porte 27, è molto semplice: un filo sospeso fra due instabili supporti. La protagonista è una, ma i corpi che si muovono sembrano due e solo da un certo momento in poi si comprenderà bene cosa accade in scena. I movimenti convulsi dell’attrice alludono sia alla nascita – alcuni gesti richiamano il parto – sia alla liberazione del corpo della donna da tutto ciò che lo tiene prigioniero. Fra acrobazie sul filo e contorsioni che rappresentano la fatica e la sofferenza della protagonista, alla fine lo scioglimento va nel senso della liberazione, o di una seconda nascita, sottolineata dall’altalena e dalla colonna sonora: onde marine che si muovono in armonia con le evoluzioni dell’attrice sul filo. Nella breve presentazione dello spettacolo si accenna al fatto che, nell’antica tradizione siciliana, Mavara è la donna che possiede poteri magici e curativi.
Il protagonista del secondo spettacolo, ideato da Alessandro Maida – Magda/Clan, è un uomo che sopravvive in modo assai precario in un deserto roccioso sferzato dai venti. Egli è solo; anzi, tutto fa credere che sia il solo umano rimasto nella porzione di mondo che abita; ma non si tratta di un’attualizzazione di Robinson Crusoe. Il titolo è una citazione letteraria, ma va in tutt’altra direzione: 2984. Siamo alla fine del millennio che abitiamo tutti noi e mille anni dopo 1984 di Orwell. L’evoluzione ha preso una direzione estrema e foriera di momenti di comicità: l’uomo vive in simbiosi con le pietre e si nutre persino di esse. L’arte può fare tali magie, anche se rimango più affezionato all’ipotesi che, in caso di sparizione del genere umano, l’evoluzione ricomincerà da scarafaggi e salmerini. Il sopravvissuto umano ha a disposizione le pietre, una carriola, un vecchio computer che manda segnali strani, una misteriosa bevanda e la sua abilità fisica nel destreggiarsi in quell’ambiente. Fra le pietre spicca la presenza di una sorta di monumento, una specie di moloch o di totem. La natura organica non esiste più, soltanto il sole e la luna continuano a scorrazzare per i cieli sempre più scuri. La colonna sonora è fatta di rumori stridenti e tuoni che nel finale diventano particolarmente sinistri. La scena ricorda per molti aspetti l’ambientazione del romanzo La strada di Cormac McCarthy. Anche in questo spettacolo il protagonista compie dei gesti la cui finalità rimane sospesa fra diverse ipotesi. Le sue azioni attraversano differenti stadi, compreso un delirio di onnipotenza indotto dalla bevanda, i cui effetti però durano poco. Alla fine di questa parte i movimenti diventano più coerenti e determinati nel dar vita a nuove forme, il cui significato vedremo nelle conclusioni.
La leggerezza del gioco
Il terzo spettacolo, Croȗte, di Guillaume Martinet/Defracto, è un ulteriore salto che ci porta nel mondo della giocoleria, anche se il termine è riduttivo. Martinet porta in scena soltanto sei palline di stoffa con le quali si esibisce in alcuni numeri tipici del giocoliere: ma questa parte della performance è in fondo quella più superficiale. Sono il corpo e lo spazio i veri protagonisti della performance. La scelta compiuta dalla regia è stata particolarmente felice, perché lo spettacolo si svolgeva in una parte del salone centrale, a ridosso della scalinata che porta a una delle mostre attualmente in corso di svolgimento. Il pubblico poteva accedere alla mostra e questo creava momenti d’imprevedibile interazione fra spettatori, pubblico ignaro di quanto stava accadendo e performer. In una alternanza fra momenti di comicità ad altri di puro virtuosismo, le azioni consistevano di poche semplici mosse. Più lo spettacolo continuava, più ci si rendeva conto che erano le interazioni fra il corpo e lo spazio più ancora delle abilità del giocoliere il vero motivo di fascino della performance; perché la diversità e anche la scelta, praticamente senza alcun limite, dei luoghi in cui quei gesti possono trovare dimora, fanno di Croȗte, uno spettacolo metamorfico, sempre diverso dal precedente.
Senza parole
Quanto visto m’induce a riflettere prima di tutto sull’assenza di parola. Non è una sorpresa in senso assoluto. John Cage in anni lontani, ma anche alcune esperienze del Living Theatre o di Lindsay Kemp non avevano al centro la parola o essa era addirittura del tutto assente; per non parlare dei Mimi e dell’indimenticabile Marcel Marceau. Tuttavia, la differenza rispetto a quelle esperienze è la possibilità di unificare in uno spettacolo elementi disparati ed eterogenei – un esempio per tutti, saper coniugare un aspetto estremo dell’alpinismo all’arte circense e al teatro – per dar vita ogni volta a performance difficilmente prevedibili. Proprio l’eterogeneità e l’interazione fra elementi così diversi, ma non arbitrariamente fusi insieme, suggeriscono che siamo forse in presenza di una nuova linea nel solco dell’arte totale, da un lato. Dall’altro che l’analogia, piuttosto che la metafora è la figura retorica prevalente.
Un altro tratto distintivo e vistoso è la capacità di usare il corpo e l’interazione fra di esso e alcuni oggetti. Tale elemento, specifico dello spettacolo circense, ma anche prerogativa della danza contemporanea, è posto al servizio di una trama più complessa come avviene – per esempio – in un passaggio particolarmente emozionante di 2984, per quello che il protagonista riesce a fare con la carriola. Oscillando fra aspetti squisitamente comici e grotteschi, ad altri più drammatici, si arriva allo struggente ballo notturno che evoca l’immagine del femminile assente dalla vita. Questo passaggio e un altro successivo, in cui, dall’esplosione di una pietra, emerge un vecchio braccio umano che verrà posto in cima al totem, portano il protagonista a mettere in scena con le sue pietre il sogno di ricostruire l’umanità.
La conclusione di questo spettacolo mi riporta a un confronto con l’altro dal titolo Mavara. Unisco queste due opere in una riflessione conclusiva perché, proprio per la loro grande diversità, portano in scena anche uno sguardo femminile e uno maschile sulla nostra contemporaneità. Mavara è un percorso di liberazione, compiuto da una donna, la quale sente che la propria presenza nel mondo è soltanto agli inizi e ha davanti a sé un futuro tutto da scoprire. La scena finale in cui la protagonista accompagna con il gesto e con il suono felice della voce, la liberazione di tutte le scorie, si apre alla speranza, ma al tempo stesso ha le proprie radici antropologiche in una tradizione di sapienza femminile che è stata repressa dalle società patriarcali. Niente potrebbe essere più lontano, in questo senso, dall’accompagnamento verso la fine del mondo, evocato da 2984. Entrambi gli spettacoli, però, ci mettono di fronte a un dilemma reale: perché se è vero che l’immaginario apocalittico è prevalentemente maschile e affonda le sue radici nella tradizione millenarista cristiana, d’altro canto la speranza di liberazione non può ignorare che il monito sulla possibile fine dell’umanità non viene da Cassandre d’occasione o pseudo indovini, ma da scienziati e scienziate.