Veglia Europa all’Officina Coviello


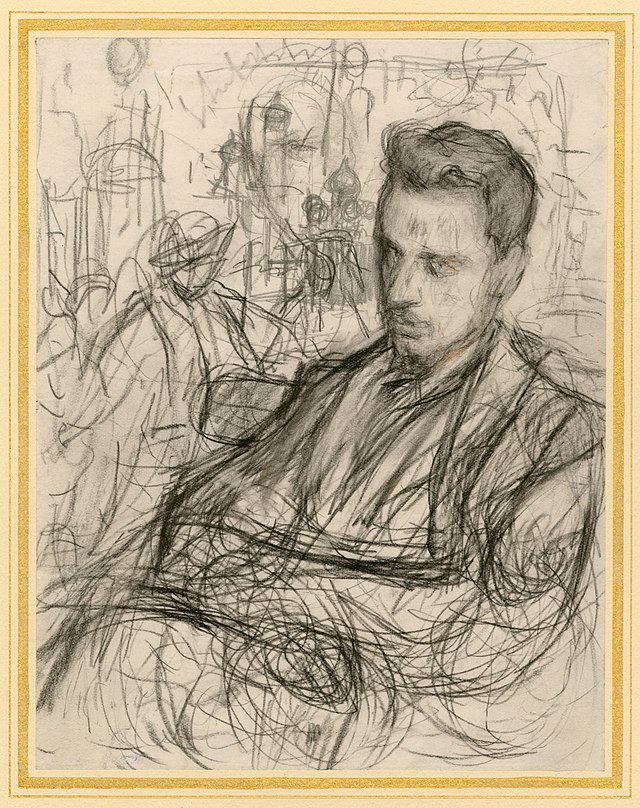
Introduzione
Il settimo sogno è un originale canzoniere amoroso in forma prosastica ed epistolare, in cui la commistione fra amour passion e amour de loinh è la cifra stilistica che lo contraddistingue e che rimanda all’analisi che Denis de Rougemont fa dell’archetipo che secondo lui è alla radice della concezione occidentale del sentimento amoroso: Tristano e Isotta.1 La forma particolare e originale del legame a tre fra Marina Cvetaeva, Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke sta nel fatto che non si sono mai incontrati e che la loro tormentata e tormentosa relazione vive tutta sulla carta scritta, nel loro pensiero e sfera emotiva.2 Questo è il teatrino, a volte drammatico, a volte comico e in qualche caso miserevole, che peraltro contraddistingue la grande maggioranza degli epistolari amorosi che coinvolgono le vite di scrittori e artisti, tanto bravi e straordinari quando mettono i loro personaggi al centro di dialoghi e situazioni, tanto banalmente comuni quando diventano loro stessi i personaggi. Va da sé, inoltre, che esso è scritto da tre personalità fuori dall’ordinario. In ognuno di loro vi è qualcosa di abnorme: prima di tutto il perseguimento di un ideale romantico in cui arte e vita sono fusi insieme. A tale modello si sottrarrà Pasternak nel tempo della sua seconda vita artistica, Rilke morirà prima di poterlo fare, Cvetaeva vi soccomberà. Anche il 1926 ha la sua importanza, perché fu un anno emblematico nelle vite dei tre protagonisti. Rilke morì il 29 dicembre di quell’anno, Pasternak rinunciò definitivamente al progetto di raggiungere Cvetaeva in Francia; quest’ultima avrebbe poco dopo chiuso la sua stagione poetica. Il 1926, tuttavia, fu un anno cruciale anche per l’Urss e l’intera Europa, anche se gli effetti delle svolte in atto si sarebbero manifestati in modo tragico alcuni anni dopo. In Italia, il Fascismo si era ormai consolidato al potere dopo la crisi seguita all’assassinio di Matteotti e il varo delle leggi fascistissime nel biennio 1925-26. In Germania, la possibilità di una rivoluzione proletaria nella quale avevano sperato i bolscevichi al potere, era tramontata per la seconda volta nel 1923, mentre in Urss finiva il decennio eroico della Rivoluzione Bolscevica. Nell’anno successivo, quello del decennale, Stalin trionferà sui suoi oppositori interni al partito. Rivisti oggi sullo sfondo di queste vicende, i 4 mesi febbrili durante i quali l’epistolario prende forma appaiono come un tramonto boreale nel cuore di un’Europa che andava a rapidi passi in altre direzioni e verso nuove e più immani tragedie.
Le lettere del 1926
Premessa.
Da queste occorre partire e cercherò di farlo come se l’insieme di questa corrispondenza fosse una sorta di partitura teatrale che ha un prologo, uno sviluppo tematico che avviene in due momenti, separati da due intermezzi; infine l’epilogo tragico. Il tutto avviene in un arco di tempo talmente breve e concentrato, da poter dire che in fondo e del tutto casualmente, persino le unità di tempo e azione vengono rispettate; in un certo senso anche l’unità di luogo, visto che il mancato incontro finisce per proiettare nei testi medesimi il luogo per eccellenza in cui tutto avviene.
Il prologo
Il 12 aprile, dopo l’esortazione ricevuta da suo padre Leonid, mentore occulto di questa triangolazione così particolare, Boris Pasternak scrive a Rilke una lettera piena di ammirazione. Fra le altre cose, lo scrittore, che sa delle difficoltà in cui si dibatte Marina Cvetaeva a Parigi, lo mette al corrente della stima profonda che anche la poeta russa nutre per lui e lo invita a mandarle una copia delle Elegie duinesi. Infine, gli suggerisce di rispondergli tramite lei stessa oppure il padre Leonid. L’intento di Pasternak è duplice e molto concreto: dal momento che non esistevano rapporti diplomatici fra l’Urss e la Svizzera (dove Rilke risiedeva), la corrispondenza diretta era assai difficile: con Marina si sarebbe aperto dunque un secondo canale di facile comunicazione, dal momento che fra Urss e Francia esistevano normali rapporti diplomatici. In un’altra lettera, indirizzata questa volta a Marina, Boris dice di essere finalmente in grado di partire e di volerla raggiungere in Francia per poi recarsi insieme da Rilke. Il 3 maggio quest’ultimo scrive a Cvetaeva una lettera molto deferente, nella quale parla anche di Pasternak in termini lusinghieri. Cvetaeva risponde a Rilke il 9 maggio e a Pasternak (che le aveva inviato nel frattempo altre due lettere in data 20 aprile e 5 maggio), il 22. L’esaltazione di Pasternak per Cvetaeva cresce: è una passione che a volte si rivolge maggiormente alla poeta altre volte alla donna, in uno scambio fiammeggiante, confuso e simbiotico fra vita e arte. A questa esplosione di sentimenti lei non oppone un rifiuto, ma un atteggiamento che tende a lasciarli decantare. La lettera del 3 maggio di Rilke a Cvetaeva, è uno scritto assai deferente e formale nella sua prima parte. Si rivolge alla poeta con il Voi e, esaudendo la richiesta di Pasternak, le invia due copie delle sue ultime pubblicazioni, aggiungendo poi che presto ne invierà altre due per Pasternak : “se la censura li lascerà passare.“
Poi aggiunge:
“Sono così commosso dalla forza delle sue parole (di Pasternak ndr.), che oggi non riesco a scrivere più nulla, ma mandate il foglio qui accluso da parte mia, al Vostro amico di Mosca. In segno di saluto.”3
La lettera prosegue ricordando il suo viaggio in Russia di molti anni prima e l’amicizia con Leonid Pasternak. Poi accenna al suo soggiorno a Parigi durante l’anno precedente, dove alcuni amici gli avevano mostrato le poesie di Boris. Subito dopo, però, il tono usato da Rilke cambia repentinamente e tale mutazione pone fine al prologo.
Arte e vita
“Ma perché – mi chiedo, perché non mi è riuscito allora d’incontraVi, Marina Ivanova Cvetaieva? Adesso, dopo la lettera di Boris Pasternak, credo che quell’incontro avrebbe potuto dare a entrambi, una profondissima, segreta, felicità. Potremo mai rimediare?”
La curatrice italiana del testo, Serena Vitale individua nell’aggettivo segreta e nella prontezza con cui Cvetaieva ne afferra il significato il “tragico leitmotiv dei loro rapporto.”4
La lettera di risposta del 9 maggio è divisa a sua volta in due parti. Nella prima Cvetaieva, come aveva fatto anche Pasternak, dichiara immediatamente il suo debito letterario nei confronti di Rilke:
“Rainer Maria Rilke posso chiamarVi così? Ma Voi, poesia fatta carne, dovreste sapere… che il Vostro nome non fa rima con la modernità… Viene dal passato o dal futuro, o da lontano...”
Dopo altre espressioni entusiastiche nei suoi confronti, scrive:
“Non parlo dell’uomo Rilke (l’uomo è ciò cui siamo condannati!), ma del Rilke spirito che è anche più del poeta, è lui che io chiamo Rilke.”5
La lettera prosegue su questo tono fino al punto in cui affronta di petto il tema del loro mancato incontro:
“Perché non sono venuta da Voi? Perché vi amo più di ogni altra cosa al mondo. È semplicissimo. E perché voi non mi conoscete. … E ancora, per voi sarò sempre una russa, …. C’è qui tutta la complessità della nostra troppo originale nazione: tutto ciò che in noi – il nostro Io – gli europei considerano russo… Lo stesso succede da noi con i cinesi, i giapponesi …” 6
La frase, di cui avevo già citato l’ultima parte, vista nel contesto della corrispondenza, assume altre valenze rispetto a quelle già indicate. Rilke, nella sua lettera, si attribuiva la responsabilità del mancato incontro: era una forma di gentilezza e di cavalleria, oppure lo pensava veramente? Fatto sta che, al contrario, Cvetaeva attribuisce a una propria scelta e al suo carattere russo il loro mancato incontro; sembra quasi che lei voglia metterlo in guardia rispetto a una complessità che forse all’altro sfugge. Infine, come va inteso quel Vi amo dopo ciò che aveva scritto prima rispetto all’uomo Rilke contrapposto al poeta e allo spirito? Dobbiamo prenderlo alla lettera oppure leggerlo come un esempio del romantico intrecciarsi fra amour passion e amour de loinh, o una metafora rivolta al poeta e non all’uomo?
In ogni caso, se Rilke avesse pensato a un incontro segreto fra loro due, la frase che segue sembra chiudere le porte a una tale possibilità:
“Rainer Maria, nulla è perduto: l’anno prossimo (1927) arriverà Boris e verremo da voi, ovunque voi siate…”
Tutto chiaro? Neppure per sogno perché alla fine di questa lettera ecco cosa scrive Cvetaeva:
“Ho letto la tua lettera sulla riva dell’oceano e l’oceano leggeva con me…. Non ti disturba che lui l’abbia letta? Non ci saranno altri. Sono troppo gelosa (Gelosia – di te.).”7
La gelosia si riferisce solo al poeta o anche all’uomo? Perché ribadire una cosa che dovrebbe essere ovvia e cioè che nessun altro, se non l’oceano, leggerà le lettere che si scambiano loro due? Gli vuole far sapere, fra le righe, che non ne parlerà con Pasternàk? Le contraddizioni e i cambi di registro sono continui e, a volte, anche la sintassi sembra colta da un accesso di furore. Tale tumultuoso avvicendarsi di sentimenti che cozzano gli uni con gli altri, peraltro, è tipico di tutto il carteggio. La risposta di Rilke è del 10 maggio e questo fa sorgere il dubbio iniziale che egli abbia scritto prima di avere ricevuto quella di Marina, che è stata iniziata il giorno 9, ma completata il 10 e spedita quel giorno. Le apparenze ancora una volta ingannano, ma è anche evidente che uno dei due ha sbagliato a scrivere la data. Ecco come Rilke inizia la sua lettera del 10:
“Marina, possibile che un attimo fa non foste qui? Oppure: dove ero io? Perché oggi … è soltanto il 10 maggio ed è strano che voi abbiate scritto questa data prima delle ultime righe della Vostra lettera… Voi pensate di avere ricevuto i miei libri il 10 (aprendo la porta come sfogliando le pagine) … ma proprio questo stesso giorno, il decimo di maggio, questo eterno giorno delle spirito, io ti ho accolto Marina, con tutta l’anima ,… sconvolta da te e dalla tua apparizione, quasi che il tuo oceano, che insieme a te leggeva, mi si fosse rovesciato addosso in un enorme flusso del cuore.“
Non è davvero facile raccapezzarsi nel mezzo di questo linguaggio, ma due cose sembrano evidenti: Rilke aveva già letto la lettera di Cvetaieva, visto il suo accenno all’oceano, anche se rimane incerta la data di spedizione perché non può essere stata spedita e arrivata nel medesimo giorno: in questo profluvio di alti sentimenti sembra a volte che le lettere arrivino prima di essere state scritte! Nessun accenno a quel ti amo di Marina; anzi tutta la lettera si sintonizza sul tono usato da Cvetaieva. Siamo dentro la metafora, si sta parlando di un rapporto fra anime secondo i canoni più stringenti dell’amour de loinh. Serena Vitale ha ragione quando individua lo scorrere di un tragico leit motiv fra le righe di tutta la loro corrispondenza, ma forse tale tragicità sta in altro. Avviandosi alla conclusione, infatti, ecco come Rilke ritorna su un argomento toccato da Cvetaieva:
“Ma stiamo parlando non dell’uomo Rilke e io stesso oggi sono in rotta con lui e con il suo corpo, con il quale prima riuscivo sempre a raggiungere un accordo così totale che spesso non capivo più chi di noi due fosse il poeta: …ma adesso l’anima è vestita in un modo e il corpo in un altro”.8
Quest’ultima parte della lettera, ancora una volta a tono, chiarisce forse definitivamente, che non vi è nessuna delusione dell’uomo Rilke il quale ha capito benissimo il significato di quel ti amo, almeno fino a questo punto della corrispondenza: ma le cose sono destinate a cambiare. Forse, nelle sue parole però, vi è qualcosa d’altro. Quando parla del proprio corpo con il quale si sente in rotta sta usando una metafora, oppure sta cercando di comunicarle qualcosa di più drammatico? Nella debordante lettera successiva, del 12 maggio, Cvetaieva parla d’altro e per un lungo tratto non è facile capire se le sia già arrivata la risposta di lui; lo si vedrà solo alla fine. Lo scritto è un lungo, disordinato e velocissimo viaggio nella poesia di Rilke, nel quale giudizi fulminanti si alternano a divagazioni non sempre facili da seguire, come quando scrive:
“tu hai espresso i rapporti fra Giovanni e Gesù (inespressi in entrambi.)“tu hai espresso i rapporti fra Giovanni e Gesù (inespressi in entrambi.)“
Il centro del suo interesse, in questo scritto, sono proprio i Sonetti a Orfeo, più che non le Elegie:
“Sono due notti che sprofondo nel tuo Orfeo...”
Dalla parte finale, si evince tuttavia che Cvetaieva non ha ancora ricevuto la lettera di lui perché si riferisce alla dedica contenuta in una lettera precedente.
“Ci sfioriamo, con cosa? Con le ali...”
Commentando questo passaggio della dedica la poeta russa scrive:
“Rainer, Rainer, tu mi hai detto questo senza conoscermi, come un cieco (veggente!). Le migliori frecce sono cieche… è arrivata adesso la tua lettera. Per la mia è ora di partire.“
La freccia cui si allude non sarà per caso quella di Cupido? Lasciamo per il momento la cosa in sospeso. Il 13 maggio Cvetaieva scrive un’altra lettera, nella quale affronta tutti i temi che Rilke aveva ripreso qui e là in quella del dieci. Essa inizia con una citazione tratta da una delle elegie e subito dopo così prosegue:
“E dunque: in modo assolutamente umano e con molta modestia: l’uomo Rilke. Ho scritto e mi si inceppava la lingua. Amo il poeta e non l’uomo. (Adesso sarai tu leggendo a incepparti.) Suona in modo estetico, cioè privo di anima, non spirituale, (gli esteti sono quelli che non hanno anima ma solo cinque sensi… affilati…Posso scegliere io? Quando amo non posso e non voglio scegliere… Tu sei l’Assoluto. Finché non mi innamorerò di te (finché non ti conoscerò), giacché non ho nessun rapporto con te (non conosco la tua merce!) … No, Rainer, non sono una collezionista, amo l’uomo Rilke, giacché è lui che porta il poeta. Quando dico l’uomo Rilke, penso a quello che vive, che pubblica i suoi libri… penso alla moltitudine dei rapporti umani. Parlando dell’uomo Rilke penso a quella cosa per cui per me non c’è posto. Per questo tutto quanto ho detto dell’uomo e del poeta è puro rifiuto, rinuncia, perché non voglio che tu pensi che io voglia intromettermi nella tua vita… Il rifiuto per non dover poi soffrire.” 9
In questa lettera ci sono anche dei passaggi imbarazzanti: cosa significa la parola merce in tale contesto? Certi altri sembrano viziati da fraintendimenti assai seri (Rilke l’ha forse accusata, di essere una collezionista (di uomini immagino volesse dire. ndr)? L’ambivalenza viene riproposta continuamente a ogni paragrafo e la conclusione di una parte di questa lunga lettera suona così:
“Caro, io sono molto obbediente. Se mi dirai: non scrivere, le tue lettere mi agitano, servo molto a me stesso – io capirò e sopporterò tutto”.10
Cosa ci fosse nelle precedenti lettere di Rilke che potesse farle scrivere una frase come questa non è chiaro; oppure è lei ad avere paura di continuare il carteggio e ancor più dei suoi sentimenti che stanno cambiando? Da questo momento in poi la lettera parla d’altro, con salti velocissimi da un argomento all’altro, senza una logica apparente che li tenga insieme. Sarebbe sbagliato tuttavia, notare solo questo perché, se si mettono l’una accanto all’altra tali affermazioni rapide e perentorie con altre di differenti lettere, il ritratto che Marina vuole dare di sé ne esce ben delineato nei suoi tratti essenziali. Il suo parlare distratto e lontano da quella che comunemente si definisce realtà è in lei costante, così come l’affastellare, in una medesima frase, elementi disparati e casuali. Josip Brodskj in un saggio scritto su di lei dal titolo Nota in calce a una poesia ne fa un ritratto quanto mai acuto, in cui afferma fra l’altro:
“… Per Cvetaeva la realtà è sempre un punto di partenza, mai di arrivo … Perciò si possono, specialmente in una lettera, affastellare gli elementi più disparati perché accomunati da un sentimento di sprezzatura nei loro confronti, che non concede alcuna rilevanza alle loro differenze.”11
Su questa osservazione di Brodskj, si chiude questo primo momento di sviluppo, cui seguono due intermezzi.
Primo intermezzo: l’amante

E Pasternak? Lo abbiamo lasciato in attesa delle risposte di Rilke, che non arrivano, e anche di altre lettere di Cvetaeva (e non arrivano pure quelle). Il 18 maggio, finalmente, riceve il famoso biglietto dedicato a lui e che il poeta boemo aveva messo nella lettera indirizzata a Marina e questo lo riempie di gioia: lo conserverà gelosamente per tutta la vita. Il 19 scrive a Cvetaeva.
“Ieri ho ricevuto la tua trascrizione delle sue parole: il tangibile silenzio della tua mano. Non sapevo che una scrittura prediletta, tacendosi, potesse sollevare una simile musica funebre.”
La sensibilità di Pasternak è qui notevole, sebbene non dica all’inizio qual è il nucleo della sua delusione. Nel finale emerge il punto dolente:
“Io avevo pensato, se la sua risposta sarà acclusa alla lettera con la tua decisione, obbedirò soltanto alla mia impazienza, non a te né all’altra mia volontà. Ed è veramente bello che in quel momento voi due foste separati. Ma il fatto che tu ti sia separata da lui una seconda volta che insieme a lui sei arrivata non tu ma solo la tua mano, mi ha sconvolto e spaventato. Tranquillizzami… Marina.” 12
Contorto di certo, ma decifrabile. In sostanza Pasternak ha il sospetto che fra Cvetaeva e Rilke sia nata una corrispondenza che lo mette da parte. Cosa significa però quell’accenno al fatto che anche lei si sia separata da lui (da Rilke) una seconda volta? La lettera che Cvetaeva gli spedisce il 22,13 a prima vista, sembra una risposta a quella di lui del 19, ma le cose non stanno così e questo sarà fonte di equivoci a non finire. Nella prima parte, lo scritto è pieno di osservazioni come sempre rapidissime sui versi di Pasternak, poi continua con riflessioni che toccano i medesimi argomenti che Boris aveva trattato nella sua del 19. Tuttavia, poiché non è una risposta a quella di lui ma una riflessione autonoma, le argomentazioni di Marina assumono, agli occhi di Boris, dei significati in parte diversi rispetto a quelli che noi lettori onniscienti siamo nella condizione di capire meglio. Dopo avere ricordato quello che Pasternak le aveva scritto in una lettera di molto precedente: “Che cosa faremmo noi due se ci incontrassimo? Andremmo da Rilke“, Cvetaeva scrive:
“… Ma io ti dirò che Rilke è troppo preso, che non gli serve niente, nessuno… Rilke è un eremita, … Rilke ha superato Eckermann, non ha bisogno di intermediari fra Dio e il suo secondo Faust… Da lui sento soffiare su di me l’estremo gelo di chi possiede, e nei cui possedimenti, io, e a priori rientro...” Ohibò!14
Questo gruppo di lettere, a partire da quella del 19, è importantissimo perché solleveranno una montagna di fraintendimenti. Tuttavia, se pensiamo alla delusione profonda di Pasternak e alla sensazione di essere stato messo da parte, seppure non del tutto volontariamente, egli non si sbaglia affatto! La sua deduzione è indipendente dagli equivoci e dai fraintendimenti; questi ultimi, se mai, sono un’aggravante che aggroviglia ancora di più il suo vissuto e lo fa dubitare della limpidezza di Marina. Anche chi legge può avere qualche sospetto sulle reali intenzioni di Cvetaeva: si è davvero separata da Rilke una seconda volta, oppure sta cercando di convincere Pasternak a non cercare la relazione con il poeta perché vuole averne lei l’esclusiva?
“Ho la vaga sensazione che tu mi stia allontanando da lui. E poiché io tenevo tutto insieme, questo significa che tu ti stai allontanando da me, anche se non nomini direttamente il tuo movimento.”
Seguono ampie dissertazioni letterarie, ma nella parte finale, ritorna sul tema dolente del rapporto fra loro tre in questo modo:
“A Rilke adesso non scrivo. Lo amo non meno di te, mi dispiace che tu non lo sappia… Come mai non ti è venuto in mente di trascrivermi le dediche che ti ha fatto sui libri e in genere come è andata, ma anche delle lettere. C’eri tu al centro dell’esplosione, e di colpo ti sei fatta da parte.”15
Le gelosie che provoca l’amour de loinh sono terribili perché affollate di fantasmi! Il 23 maggio Cvetaieva risponde finalmente alla lettera di Pasternak del 19. Inizia con una lunga serie di divagazioni famigliari, poi il punto dolente emerge improvviso e rapido prima di approfondirsi:
“Boris ti scrivo lettere sbagliate.”
Seguono altre divagazione e poi un discorso sul mare che lei non ama, che sembra essere una metafora letteraria per dire altro. Verso la fine arriva al punto:
“A Rilke non scrivo, è una tortura troppo grande. Mi fa perdere il filo mi distrae dalle poesie. Come trattare uno che è diventato il tesoro dei Nibelunghi? A lui non serve. E a me fa male. Non sono meno grande di lui (nel futuro) ma sono più giovane.”
Il 25 maggio, dopo avere ricevuto la lettera di Pasternàk, ne scrive subito un’altra in cui lo rimprovera di mettere se stesso davanti a tutto, ma non nega affatto la corrispondenza a due che c’è stata fra lei e Rilke; ma una frase nel finale che sembra escludere ogni nuovo contatto:
“Di Rilke. Ti ho già scritto di lui. A lui non scrivo Adesso ho la pace della perdita totale – del suo volto divino – del rifiuto…”16
Si può pensare, leggendo la frase di cui sopra, che lei stia davvero ingannando Boris, tacendogli che la corrispondenza fra lei e Rilke non si è mai interrotta, ma ancora una volta i fatti smentiranno tale interpretazione. Nel momento in cui lei scrive della perdita totale e del rifiuto, Marina è convinta di quello che scrive, ma era caduta in un colossale equivoco, come si vedrà. Pasternak, peraltro, ha nel frattempo del tutto metabolizzato l’impossibilità di una relazione a tre: da un amore travolgente, nel giro di pochi giorni, si passa all’indifferenza. Come in Tristano e Isotta, quando i due non si cercano più, senza che se ne capisca fino in fondo la ragione:
“Ti ringrazio calorosamente per tutto. Cancellami per qualche tempo dalla tua coscienza – per un paio di settimane ma non per più di un mese… Tra l’altro fino ad oggi non ho ringraziato Rilke per la sua benedizione. Dovrò rimandare anche questo...”17
Secondo intermezzo: l’equivoco.
Nella lettera del 17 maggio. Rilke aveva scritto a un certo punto:
“Marina cara, tutto ciò riguarda me. Scusami… se di colpo smetterò di informarti di ciò che mi succede, tu devi scrivermi lo stesso ogni volta che avrai voglia di volare.”
La lettera si conclude così:
“A non spedirti la mia foto del passaporto non mi ha costretto la vanità, ma la coscienza di quanto questa istantanea fosse casuale (anche una fotografia deve essere un Assoluto, perbacco! ndr), però l’ho messa accanto alla tua: abituarsi alla vicinanza dapprima sulla fotografia, d’accordo?”18
Potenza dell’amour de loinh!
Secondo Serena Vitale, con la quale concordo, Cvetaeva aveva letto nella prima delle frasi citate qui sopra un rifiuto da parte di Rilke. Cvetaeva aveva davvero inteso questo, ma si trattava di un equivoco del tutto ingiustificato, che a sua volta aveva alimentato, almeno in parte, tutto il polverone di fraintendimenti con Pasternak. Nella medesima lettera, infatti, Rilke le aveva pure detto di avere posto le due fotografie l’una accanto all’altra perché si abituassero alla vicinanza prima … – di che cosa se non di un incontro reale fra loro due? Credo che la spiegazione logica della frase usata da Rilke in quella lettera sia un’altra. Egli non era più sicuro di poterle scriverle perché le sue forze stavano venendo meno. Non c’era nessun rifiuto da parte sua; forse, soltanto un certo disagio nel comprendere che Cvetaeva non stava affatto capendo la situazione in cui lui si trovava. Dopo un silenzio di due settimane, lei torna a scrivergli il 3 giugno. Il tono è quello di sempre, pieno di entusiasmo e frasi amorose, di ambivalenze e di contraddizioni che diventano addirittura ingovernabili, tanto è l’ardore di questa lettera. In essa, fra l’altro, accenna a quello che lei ritiene essere un rifiuto da parte sua. Questa volta però, l’8 giugno, Rilke le risponde per le rime e sembra finalmente volere uscire dalla metafora in cui lui stesso – peraltro – si è chiuso per una vita intera. Abbandonerà finalmente il mondo degli dei per tornare fra gli esseri umani?
“E così una mia parola gettata lì per caso che tu hai eretto davanti me, ha gettato questa enorme ombra e così ti sei allontanata da me…. Quella frase scritta da me non veniva dall’uomo di cui tu hai parlato a Boris… Troppo preso – ah no Marina, libertà e leggerezza e solo l’imprevedibilità della risposta… E da qualche tempo probabilmente a causa delle mie condizioni fisiche io ho paura che qualcuna delle persone da me amate si aspetti da me una frase fortunata o la stessa perfezione del discorso… Oggi ti ho scritto una lunga poesia, seduto su un muro tiepido fra le vigne… Vedi, sono tornato.”19
Era tutto un equivoco, nessun rifiuto da parte di Rilke e la poesia cui allude è nientemeno che l’ultima delle Elegie, che le regala con una dedica. Leggendo questo passaggio, però, si può capire che quando Marina scriveva a Boris che Rilke non aveva più bisogno di nulla, non gli stava mentendo per gelosia e per volere soltanto per se stessa un rapporto con Rainer: lei era davvero convinta di essere stata rifiutata da Rilke! Il problema è che talvolta, la maledetta realtà si prende le sue rivincite sulle visioni oniriche e sulle suggestioni dell’amour de loinh! Lei incassa il colpo e gli risponde soltanto il 14 giugno: è una lettera di scuse, di grande amarezza, in cui mette di mezzo Pasternak quasi per discolparsi. Eppure, questa del 14 è la lettera in cui Cvetaeva riesce a dire di sé qualcosa che non le riuscirà di dire in molte altre occasioni.
“Io siamo molte persone… forse innumerevolmente molte (moltitudine insaziabile) E una non deve sapere nulla dell’altra, disturba. Quando sono con mio figlio la cosa che ti scrive e ti ama non deve starmi accanto.“
Alla fine, però, Cvetaeva sembra volere abbandonare davvero la metafora. Descrivendo le fotografie che ha ricevuto da lui ne individua una in cui vede questo:
“… Un uomo che parte e che per l’ultima volta …guarda il suo giardino Un uomo che si lascia cadere fra le mani tutto il paesaggio (Rainer portami con te!)...”
Il ti amo che ritorna alla fine della lettera, sembra questa volta rivolto all’uomo. Rilke, dopo l’ultima lettera di Cvetaeva, le risponde con lentezza e lei di nuovo se ne adombra. In una nuova lettera a Rilke del 6 luglio, Cvetaeva parla di letteratura. Soltanto alla fine ritorna su loro due e forse indirettamente risponde a una frase di lui, quando aveva scritto che non sempre riesce a essere all’altezza di quanto ci si aspetta da lui:
“Ma tu sei ancora anche un poeta, e dal poeta si attende de l’inedit …”20
Rilke risponderà il 28 luglio, molto tempo dopo, ma bisogna considerare che nel frattempo si era recato alla stazione di cura di Ragaz, dove lo attendevano i coniugi Thurm und Taxis. La lettera inizia con meravigliosa Marina e sembra fugare ogni dubbio. Riferendosi a Boris ammette che sia stato lui a indirizzarla verso di sé, ma poi “Sei apparsa tu pura e forte...”
Il prosieguo, dopo alcune osservazioni di carattere letterario, parla di nuovo di sé e della condizione in cui si trova. Dice di essere stato costretto ad andare a Ragaz per:
“vedere i miei più vecchi e unici amici (Per quanto tempo ancora? Sono infatti di molti anni più vecchi di me…)
Quell’accenno alla tarda età degli amici e quel Per quanto tempo ancora è riferito a loro oppure è un modo metaforico di alludere alla sua di condizione? Marina risponde il 2 agosto e ribadisce in termini sempre più espliciti di volerlo raggiungere in nome di quel “nuovo io che può realizzarsi soltanto con te…, in te…” 21
Il 14 agosto lei gli scrive una nuova lettera dalla quale si evince che non ha ricevuto la sua del 28 luglio. Rilke le scrive il 19 agosto una lettera di grande amarezza. Le dice di essere meno sicuro di lei che si potranno incontrare, ma non le dice il perché. Le scrive pure che ha cercato sulla cartina quella piccola città dove lei gli aveva proposto d’incontrarsi. Lo vuole o non lo vuole? L’ambivalenza dei sentimenti è forte anche in lui, anche perché nella parte centrale della lettera emerge improvvisamente una preoccupazione che fin qui non era apparsa:
“Il silenzio di Boris mi inquieta e mi amareggia: è possibile che la mia comparsa abbia sbarrato il passo al suo violento desiderio di te? E malgrado io capisca bene che cosa tu intendi quando parli delle due «non patrie» (che si escludono a vicenda), penso che tu sia severa e quasi crudele nei suoi confronti (e severa nei miei), esigendo che io non abbia mai e in nessun luogo altra Russia all’infuori di te! Protesto contro qualsiasi esclusione (essa ha radici nell’amore ma crescendo diventa di legno), mi prenderai così, anche così? “22
Rilke si rende conto per la prima volta della potenziale ambivalenza e anche ambiguità della situazione che si è creata fra loro tre, ma poi di nuovo, con il discorso delle due non patrie sembra riportare tutto nell’ambito letterario. Questa volta è lui che si sente escluso dal rapporto con Pasternàk e attribuisce a lei tale esclusione. Forse sarebbe bastato accorgersene prima e dirlo direttamente a lui, a Boris! Attribuire solo alla severità di Marina l’accaduto è troppo semplice perché implica una sicura e razionale volontà di raggiungere quello scopo; ma dovrebbe essere chiaro che in realtà non vi era in atto da parte di alcuno dei tre un’intenzione del genere. Il fatto è che vivendo dentro la metafora, prima o poi si fa di sé medesimi una metafora! In ogni caso, sembra ormai tardi per qualsiasi cosa. Forse alla fine uscirà la parola decisiva, quando Rilke, riferendosi alla possibilità di un incontro con Marina scrive:
“Non rimandare fino all’inverno”23
ma purtroppo ancora una volta siamo nella metafora perché si tratta della citazione di un verso! Il 22 agosto Marina gli risponde dicendogli che se si vogliono davvero incontrare è lui che deve agire e lo invita a venire nella località che gli aveva indicato. Nella lettera, però, c’è un passaggio che la rende di nuovo ambivalente e indecifrabile:
“Quanto più ci si allontana da me, tanto più si entra in me. Io non vivo in me stessa vivo fuori di me. Non vivo sulle mie labbra e chi mi bacia mi perde...”24
Rilke non le risponderà. Andrà a trovare (ed è il suo ultimo viaggio) Paul Valery a Ouchy, ma non si recherà al 3 di Boulevard de Grancy dove lei lo aspettava. L’ultima cartolina è di nuovo di Cvetaeva, il 7 novembre, con una vista su Bellevue a Parigi e dice semplicemente:
“Caro Rainer! Io vivo qui. Mi ami ancora?”25
Rilke non le risponderà più, scriverà invece al vecchio amico Leonid Pasternak. Perché è arrabbiato con lei? No. La lettera spedita al padre di Boris, infatti, non l’ha scritta lui, ma la sua segretaria: egli sta salutando tutti gli amici, forse non è più in grado di farlo personalmente e quindi per pudore e per non farle capire cosa sta succedendo, non le dice nulla.
L’epilogo
Il 31 dicembre Cvetaeva scrive a Pasternak una lettera che inizia così:
“Boris, Rainer Maria Rilke è morto.”26
Abituati come siamo al linguaggio barocco, questa lapidaria espressione suona come un urlo di dolore e di sgomento: è l’incipit di chi non si aspetta la notizia. I dettagli sulla sua morte, Rilke li affida ancora a Leonid Pasternak tramite la propria segretaria, Marina continua rivolgendosi a lui come se fosse ancora vivo. Boris non risponde alla lettera di Marina sulla morte del poeta. Un mese dopo, anche Cvetaeva riceverà una lettera dalla segretaria di Rilke, allegata a una copia del libro sulla Mitologia greca che il poeta aveva comperato per lei. Pasternàk risponderà alle reiterate lettere di Cvetaeva solo a febbraio e il tono, pur affranto e nonostante scriva che ora entrambi sono orfani, è segnato da una palpabile distanza. Per Pasternàk era la relazione fra loro tre la cosa più importante, ma forse vi è anche dell’altro. Continuarla solo con lei non avrebbe forse fatto risorgere i fantasmi di un possibile incontro reale di cui lui ormai aveva solo paura? Nella lettera del 9 febbraio,27 Cvetaeva sottolinea il tono burocratico della risposta di Pasternak e poi continua a parlare di poesia come se niente fosse. È una lettera lunghissima allegata alla quale c’è una sua poesia scritta nel giugno del ’26 e intitolata Tentativo di stanza. Infine, Cvetaeva accenna anche al requiem per Rilke che ha intenzione di scrivere e che avrà per titolo Novogodnee (Anno nuovo).28 Marina Cvetaeva cercherà di mantenere viva la corrispondenza e la relazione con Pasternak e non soltanto per ragioni letterarie. In fondo, seppure da lontano, lei li amava entrambi quei due uomini e in una lettera del ’30 scriverà a Pasternak una frase quasi analoga a quella che aveva scritto a Rilke nel ‘26 e cioè che Boris era la sola persona con cui avrebbe potuto ricostruire il proprio io sparso e disgregato in tanti pezzi. Pasternak non le risponderà più. Con Novogodnee, che Brodskj considera il vertice della poesia di Maria Cvetaeva,29 si chiude anche la sua stagione poetica: successivamente si dedicherà solo alla riflessione critica, mentre Pasternak inizierà una fase del tutto nuova del suo percorso artistico.

1 Denis De Rougemont, L’amore e l’occidente, Rizzoli, Milano 1998.
2 Cvetaieva, Pasternak, Rilke, Il settimo sogno. Lettere (1926), a cura di Konstantin Azadovskji, Elena ed Eugenji Pasternak. Edizione italiana a cura di Serena Vitale, Editori Riuniti, Roma, 1980.
3 Op.cit. Pag 19 e seguenti.
4 Ivi.
5 Op. cit. pp. 45-6.
6 Ivi.
7 Op. cit. pp. 47-8.
8 Op. cit. pag. 50-52.
9 Op.cit. pp. 52-57.
10 Ivi.
11 Iosif Brodskji, Il canto del pendolo, traduzione di Gilberto Forti, Adelphi, Milano 1987, pag. 238.
12 Op.cit. pp.65-70.
13 Op.cit. pp.71-74.
14 Ivi.
15 Op. cit. pag. 83.
16 Op. cit. pp. 81-84
17 Op. cit. pag. 78.
18 Op. cit. pp..60-64
19 Op. cit. pp. 93-4.
20 Op. cit. pag 136.
21 Op. cit. pp.153-56.
22 op. cit. pag. 160-1.
23 Ivi.
24 Op. cit. pp.162-3.
25 Op. cit. pag 165.
26 Op. cit. pp. 168-9
27 Op. cit. pag. 177.
28 Op. cit. pp. 177-88; l’intenzione di Cevetieva si trova scritta proprio nelle ultime righe della lettera.
29 Il testo di Nuovo anno è pubblicato in Italia in diverse edizioni. Quella che ho scelto è compresa nella raccolta Marina Cvetaeva, A Rainer Maria Rilke nelle sue mani, a cura di Marilena Rea, con testo a fronte, Passigli Editori, 2012, pp. 44-57. Prediligo tale edizione perché raccoglie altre liriche e testi dedicati a Rilke, così da offrire un quadro più ampio del modo con cui Cvetaeva si è rapportata a lui durante tutta la vita.
Introduzione
I testi che seguono furono pubblicati sul numero 23-24 della rivista Poiesis nel 1993. Uno di essi, il primo, fu tradotto da Jean Portante e pubblicato su una rivista francese che non ritrovo. Una soltanto di queste poesie – La piccionaia – è poi confluita nel libro L’epoca e i giorni pubblicato nel 2008 per le edizioni Viennepierre di Milano. Le ragioni per cui un testo entra o non entra in una raccolta sono diverse, il montaggio ha una parte importante nella composizione di un libro, anche se nel pensarci a distanza di anni, non ricordo le motivazioni per cui alcune furono escluse. Le ripropongo nel blog con il titolo originale – Piccoli dilemmi quotidiani – con il quale furono pubblicate su Poeisis.
In ogni carne affondano il coltello
versano il vino con la stessa mano
come distilla terra il fungo amico
e veste da sicario il suo gemello.
Sotto la prima crosta la radice
una semplice patata cresce sotto
e sotto la seconda superficie
l’acqua ci nutre mescolando umori.
L’aria che respiriamo è in alto,
l’orizzonte un po’ più in là …
la nube e la luna di cui tutti
guardano ancora l’incedere grandioso
sono entrambe un po’ più sopra.
Così gli animali transitano
e hanno nel letargo quel profondo
che scava il rifugio e il pudore
oppure dall’alto di una rupe
spalancano una porta all’infinito.
Soltanto noi siamo qui
né in alto né sotto né più in là
ombre che abitano la zona grigia
dove si specchia la luna
in un catino d’acqua sporca.
La piccionaia
Amo di Genova il suo disordine ordinato
L’età sovrapposte come le casse impilate
Di piazza Caricamento, i ristoranti
dai tavoli trasandati, dove da sempre
è seduta una signora che sogna
di un americano che la porterà
a New York in transatlantico.
Ed io che vivo nella pianura nebbiosa
un poco la capisco la signora
e ho scelto di abitare un eremo di vento
trafitto dal sole che ci resta
un piccolo scrigno dove danzano insieme
cornici paterne e maschere africane
un coltello da pirata che mio figlio
mi portò da Mali…e dell’India
conservo un’intera madia, intrisa
di odori speziati e nel suo specchio a notte
danzano tigri luminose e quando piove
il vetro scroscia una foresta pluviale.
Forse non è una vera casa
(è persino imbarazzante portarci una donna)
ma uno di quei luoghi da cui sempre si parte
e il ritorno è festa improvvisata
dove trovano rifugio poeti e marinai del tempo
felici d’esser soli in mezzo al brulichio
di ogni vita, come bambini che ascoltano gli adulti
parlare nella stanza accanto
e si addormentano beati
gravidi di ogni idioma del mondo.
Il migratore
È tornato quest’oggi il migratore,
ha cantato alla ringhiera
ferito dolcemente la mia mano.
Non cercava solo cibo, aveva un suono
un suono tutto suo l’esile grido
inconfondibile e raro … diceva
il verso non sia soltanto umano,
è più vasta la culla del tuo sogno.
Cercatore di funghi
Nella matrice signora originaria
cercare fra gli arbusti e i rami secchi
sentire i piedi, il morbido gonfiore
scostare foglie attento a non far male.
Per ore camminare occhio radente
fino alla visione solitaria …
Simile al suo cercare chi si danna
nel bianco deserto rettangolare
distillando dalla mano la sua acqua …
e a sera chinati insieme a misurare
se nel canestro il mosaico di forme
sia la città del rame o il suo miraggio.


Introduzione
Questo scritto è la rielaborazione di un mio intervento nel dibattito nato su Overleft intorno al cinema del dopoguerra, al quale oltre la redazione partecipò anche Adriano Voltolin, e una mia riflessione precedente sulla canzone italiana. Lo ripropongo in uno dei momenti topici della cultura di massa in Italia.
***
Cameriere e casalinghe di Voghera
Forse ancora oggi non molti sanno che il fotoromanzo nacque nell’immediato dopoguerra proprio in Italia e da qui si diffuse in tutto il mondo. Un libro di Anna Bravo1 ricostruisce puntualmente la storia di questo prodotto made in Italy, niente affatto minore per impatto ad altri ritenuti più paludati e degni d’attenzione. Il libro di Anna Bravo ricorda le riunioni semiclandestine della casa editrice Universo (che con L’intrepido aveva già avvicinato il pubblico femminile al fumetto) e l’uscita – nel giugno del 1946 – proprio di Grand Hotel. Il libro della Bravo è uno strumento ricco e documentato per chi voglia ricostruire al storia di questa vicenda dal dopoguerra in poi che possiamo suddividere in momenti diversi.
La prima fase. La diffusione del fotoromanzo si scontra con la doppia opposizione piuttosto accesa sia da parte cattolica sia comunista, con motivazioni desolatamente ovvie: traviare i giovani spingendoli verso condotte di vita immorali, instupidire il proletariato distogliendolo dalla lotta di classe.
Seconda fase. Nel giro di pochi anni l’atteggiamento del Pci cambia repentinamente. Bravo accenna a un dibattito interno assai riservato, in cui ebbero una parte attiva e alla fine vincente intellettuali come Cesare Zavattini, Damiano Damiani e Oreste Del Buono. Da quel dibattito nacquero imprese editoriali che approdarono direttamente nell’ambito politico durante la campagna elettorale del 1953 (quella della cosiddetta Legge truffa), che fu combattuta anche a colpi di fotoromanzo, con grande panico da parte democristiana che dovette correre ai ripari, vista l’efficacia del genere. Fra le chicche che si scoprono ripercorrendo questa vicenda ci sono anche Andreotti e Scalfaro impegnati nella proposta di fotoromanzi di carattere religioso e, dulcis in fundo, Cesare Zavattini a cui si deve l’idea della rivista Bolero, Oreste Del Buono che per primo si cimenta con una letteratura popolare i cui protagonisti fossero operai e contadini e Damiano Damiani che scrive queste storie.
Tornando a Zavattini, il programma su cui nacque Bolero era molto chiaro: una rivista per le cameriere, rivolta a un pubblico femminile di lavoratrici e casalinghe. Il genere avrà una sua evidente vitalità fino agli anni Settanta e dei primi Ottanta, con storie che affronteranno temi come contraccezione e aborto.
La terza fase riguarda il cinema su cui si sofferma il saggio di Voltolin; ma a questo va aggiunto anche un altro aspetto della cultura popolare di quegli anni e cioè i cambiamenti che avvengono nell’ambito della canzone, della musica cosiddetta leggera ed è proprio su quest’ultima che mi sembra importante soffermarsi.
Prima e dopo la guerra
Seguendo una trasmissione di Rai storia dedicata al ‘900, a partire dagli anni ’20, mi ha particolarmente attirato la colonna sonora, fatta di canzoni dell’epoca, di canti fascisti, di altri brani musicali provenienti dagli Stati Uniti, perlopiù swing. Tale sottofondo musicale mi era noto ma mi ha spinto, il giorno dopo, a una maggiore curiosità e quindi ho trascorso la mattinata ascoltando compilation di canzoni degli anni coincidenti con il ventennio fascista; non i canti del regime ma solo le canzoni. Le conoscevo tutte, direi al 90%, molte avrei persino potuto cantarle, tanto le ricordavo bene e la circostanza può apparire strana, visto che sono nato nel 1947. In realtà non c’è nessun mistero, la ragione la conosco benissimo, anche se mi ha colpito la persistenza così forte del ricordo. Mio padre, un artigiano intagliatore del legno, lavorava in casa e aveva sempre la radio accesa come un sottofondo che accompagna ancora oggi la mia vita. Da alunno delle elementari, fui costretto a una lunghissima assenza da scuola per malattia e posso dire che, insieme ai fumetti e alla dedizione di mia madre quando tornava dal lavoro, fu proprio la radio di mio padre e le sue poche parole ad aiutarmi a venirne fuori. Non avevamo il grammofono e il primo giradischi lo ebbi quando frequentavo già le superiori; dal ’56 – se non ricordo male – arrivò la televisione in casa mia, ma io la potevo vedere poco. Quelle canzoni, in sostanza, potevo averle ascoltate solo alla radio e si sono impresse nella mia memoria, tanto da rimanerci fino a oggi. Il risvolto sociale, che mi appare evidente, è che esse erano il marchio di una continuità nazionalpopolare fra l’Italia fascista e quella repubblicana, fino alla fine degli anni ‘50. Quando iniziò la rottura di questo equilibrio? La domanda mi riporta anche al cinema perché fu proprio in alcuni anni chiave fra la fine dei ’50 e gli inizi del ’60, che tutto cominciò a cambiare e fu proprio il cinema da cui prese inizio una cesura e anche una polemica molto aspra fra gli intellettuali vicini al Pci. In quegli anni, infatti, mentre venivano esaltati Zavattini, Damiani e Del Buono, i registi della seconda generazione neorealista citati da Adriano Voltolin venivano bollati da Aristarco, anch’egli intellettuale di punta del partito, come pornografi dei sentimenti. Come mai?
A mio giudizio le ragioni sono tre, relativamente autonome fra di loro. La prima sta nella diffidenza che la cultura comunista italiana ebbe nei confronti delle avanguardie artistiche e della settima arte, specialmente in quegli anni. Non bisogna dimenticare che la cultura di fondo della dirigenza comunista era profondamente umanistica, molti sarebbero stati dei buoni professori di lettere e di latino. Il nume tutelare di quella cultura era Francesco De Sanctis, reinterpretato da Gramsci.
La seconda ragione sta nella nozione complessa e spesso ambivalente anche in Gramsci, di nazionalpopolare. Il dibattito che precedette la svolta del 1953, con il fotoromanzo, verteva su questo e sul modo di recepire quel concetto. Anche Pasolini, con la sua esperienza di direttore per un anno della rivista Vie Nuove, si pose questo problema e fu in sintonia con Zavattini e gli altri.
Per quanto riguarda il cinema, tutto era diverso perché la sua ricezione da parte della cultura comunista era molto più ambivalente di quanto sembri, come tutte le novità tecnologiche di quegli anni, televisione compresa. Il neorealismo duro dei primi anni del dopoguerra era del tutto conforme alla poetica del realismo socialista reinterpretato in chiave italiana e per questo fu accettato senza problemi; ma già con De Santis regista le cose non sono così semplici come sembrano. Riso amaro suscitò un notevole scandalo nelle sezioni del Pci e Togliatti dovette impegnarsi personalmente in un giro d’Italia nelle sezioni per difendere la pellicola come grande opera sul lavoro. Qual era il motivo dello scandalo? Le cosce delle mondine, che per non bagnarsi gli abiti arrotolavano le gonne per poter svolgere il loro lavoro. Che differenza c’è fra quelle immagini e quelle dei fumetti o fotoromanzi che raccontavano storie spesso anacronistiche rispetto alla vita che facevano i loro lettori e le loro lettrici? La risposta sta nella differenza fra parola e immagine. Le storie popolari di Damiani o le vite di Bolero e Grand Hotel, erano pur sempre letteratura popolare e ubbidivano a un’esigenza di alfabetizzazione di un popolo ancora in larga parte analfabeta che poteva trovare anche in quelle storie uno strumento efficace di acculturazione. Con il cinema del dopoguerra, libero dalle censure e dalla retorica propagandistica fascista, comincia un’altra storia che la cultura comunista cavalcò entusiasticamente con il neorealismo, cominciò a non capire più dalla metà degli anni sessanta in poi finendo per sottovalutarla e poi per subirla. Oppure reagì con una scissione schizofrenica. Da un lato ammiccare agli intellettuali e al pubblico colto osannando Antonioni e fingendo di capirlo, oppure difendendo la tradizione umanistica e popolare fatta di biblioteche delle sezioni tutt’altro che banali per gli anni in cui si formarono e di una letteratura di massa di cui faceva parte anche il fotoromanzo; il tutto però, separato dalla cultura alta che andava per un’altra strada.
Nel mezzo si faceva strada, grazie al cinema, una cultura di massa che preparò molte cose fra cui i movimenti della fine degli anni sessanta, che infatti sorpresero del tutto la cultura comunista: dal quel momento inizia anche il declino politico del partito, nonostante i successi elettorali. Il declino culturale, infatti, viene prima, con buona pace del nesso struttura sovrastruttura, e riguarda proprio l’incomprensione delle dinamiche che andava prendendo la cultura di massa. Ed è qui che entra di nuovo scena una protagonista che sembra minore ma non lo è: la canzone. Pasolini fu un testimone particolarmente importante di questo passaggio. Quando Calvino e Fortini diedero inizio alla polemica sul festival di Sanremo, egli aderì e negli stessi anni, sia Cantacronache, sia altri gruppi si posero il problema di una canzone colta. Un titolo per tutte: Dove vola l’avvoltoio. La polemica però finì nel nulla e il primo a prenderne atto fu proprio Pasolini quando riconobbe che (cito a memoria) niente poteva rappresentare meglio l’estate del 1964 di Sapore di sale di Gino Paoli.
La rottura, però, era iniziata prima: nel 1957 con Come prima di Tony Dallara e reiterata con Nel blu dipinto di blu (1958) cui è associato un ricordo personale, ma che ritengo importante per ragione di costume. Il padre di Dorelli, che aveva cantato con Modugno, era Nino D’Aurelio, tenore il cui nome è oggi sconosciuto ma che allora era un personaggio per Meda, il comune dove ero nato e dove abitavo. Nino morì pochi giorni dopo la fine del festival e il suo funerale fu un evento che portò a Meda insieme a Dorelli, cantanti e relativi codazzi. Il paese si fermò al passaggio del feretro in un silenzio totale. L’immagine di un paese intero bloccato dal funerale di un tenore, seguito da molti altri cantanti e con aspetti di evidente curiosità mondana da parte del pubblico, che nulla aveva a che fare con il lutto, suscitò una predica furente del parroco la domenica. La cosa sorprendente però fu un’altra e cioè che persino a persone discretamente bigotte, fra cui mia madre, quella predica non piacque per nulla: il festival di Sanremo aveva sconfitto il parroco. La cultura di massa si presenta sempre a due o più facce e a volte sono proprio dei cambiamenti in apparenza minori a dare il via a movimenti imprevedibili. Quello che la canzone colta di Calvino e Fortini non riuscì a fare lo fecero personaggi come Fred Buscaglione – Eri piccola così è del 1958. Tua, interpretata da Jula de Palma è del ’59 e suscitò un mare di polemiche a causa dell’interpretazione particolarmente sensuale, tanto che la Rai non la mandò più in onda. Anche Tintarella di luna è del ’59, mentre Il tuo bacio è come un rock è del ’60. Il meglio, però, doveva ancora arrivare. Gaber e Jannacci, Tenco, Bindi, Lauzi, De Andrè e poi Fossati e tanti altri. Da quel momento cominciò davvero un’altra storia, mentre continuava quella del cinema con Il sorpasso; cominciava invece a ridursi l’influenza del fotoromanzo e finiva davvero il dopoguerra.

***

Introduzione
L’oggetto di questa seconda parte verte essenzialmente intorno alla questione del tempo che è sempre centrale nelle opere di Furio Jesi, come si è già visto nella prima parte a proposito delle differenze fra rivolta e rivoluzione. L’accento sarà ora posto sulla festa perché anch’essa, come sostiene Jesi, sospende il tempo storico e ne instaura un altro.
Il tempo della festa
Furio Jesi non ha mai scritto un libro con questo titolo; tuttavia, l’assemblaggio di alcuni suoi saggi, curata da Andrea Cavalletti per Nottetempo, ha una giustificazione, perché in essi vengono esplicitati alcuni passaggi cruciali nel suo percorso e specialmente si gettano le fondamenta per una critica che supera quanto scritto in Spartakus, pur senza rinnegarne l’esperienza. I due saggi più importanti di tale assemblaggio, oltre alla Lettura del Battello ebbro di cui ho già scritto, sono il primo, Conoscibilità della festa, e Cesare Pavese e il mito. Gli altri saggi sulle Elegie di Rilke e l’interpretazione del racconto biblico di Susanna e i vecchioni e quello su uno scritto giovanile di Lukacs, pur interessanti e come sempre pieni di intuizioni, sono di minore importanza per il discorso che si fa qui1. Perché la festa? La risposta è complessa nel senso che si tratta di ipotesi a volte esplicite altre volte che si possono dedurre: vi sono poi dei richiami impliciti al saggio di Benjamin sul Surrealismo e specialmente al concetto di ebbrezza, illuminazione laica, antropologica e materialista.2 Dietro la riflessione di Jesi, ma anche fra le righe del saggio di Benjamin, c’è una domanda nascosta, più evidente in Jesi: cosa unisce la festa alla rivolta e alla rivoluzione? Tutte e tre con le loro diverse modalità spezzano la serialità del quotidiano e hanno a che fare con la sospensione del tempo; tutte e tre sfuggono alla tirannia del tempo storico. Rivolgersi alla festa significa dunque per Jesi tornare a interrogarsi sulle diverse modalità di sospensione del tempo; ma anche di rivolgersi al folklore, alle radici antropologiche di una civiltà e naturalmente alla macchina mitologica, espressione che Jesi userà sempre invece della parola mito. Nel primo saggio, intitolato come ho detto Conoscibilità della festa Jesi inizia ricordando uno scritto polemico di Benedetto Croce, nei confronti di un cronista – tale Conti – che aveva definito l’eruzione del Vesuvio del 1906 con accenti di vera e propria meraviglia. La polemica di Croce viene criticata da Jesi in modo assai sottile, nel senso che, dedicando alla reprimenda del povero Conti una pagina che sembra scritta dal filosofo solo per schiacciare il proprio interlocutore, Croce finisce per dare all’evento luttuoso – l’eruzione vulcanica – il contorno letterario di una pagina talmente ben scritta da suscitare a sua volta meraviglia. Peraltro, lo sgomento di fronte a fenomeni naturali o epidemici particolarmente estremi non è nuova e ha sempre prodotto pagine memorabili. Gli esempi che Jesi fa sono classici che spaziano da Erodoto alla descrizione della peste in Manzoni; ma anche in occasione della recente pandemia di Covid 19 si sono letti brani di grande suggestione, a prescindere dal loro contenuto. Va pure ricordato che il concetto di sublime, elaborato da Edmond Burke, è assai ambivalente come peraltro quello di numinoso, entrambi riferiti a eventi che possono essere sia di festa vera e propria della natura, sia a eventi catastrofici ma dotati di uno strano fascino, proprio per la loro potenza in atto. Feste crudeli le definisce Jesi e possiamo estendere tale concetto alle guerre: Thomas Mann alla fine de La montagna incantata parla del primo conflitto mondiale come una festa di morte. Occuparsi della festa significa dunque immergersi in quel patrimonio antropologico che Benjamin, nel saggio sul Surrealismo, aveva indicato con i termini di illuminazione profana. Se infatti è possibile dichiararsi non cristiani (a dispetto di ciò che pensa Croce), da un punto di vista religioso, filosofico e del pensiero in senso lato, è a livello antropologico che le religioni operano più in profondo. L’illuminazione laica e antropologica materialista che Benjamin attribuisce al Surrealismo, va molto più fondata sulla critica del costume e anche le riflessioni di Jesi vanno in quel senso. Quanto alla festa, essa occupa una parte preminente nell’antropologia profonda dei popoli: il Carnevale, le Feste dei Folli medioevali, le diverse forme di rovesciamento delle gerarchie, il paese di Cuccagna, i Fuochi di sant’Antonio, il culto dei morti. Cosa avviene però con la modernità? Jesi distingue fra dimensione epifanica della festa e conoscenza della festa come processo gnoseologico, grazie all’etnologia e alla ricerca sul campo. Egli polemizza con Adorno, che nella Dialettica dell’illuminismo si riferisce alle feste orgiastiche dei primitivi, facendo notare come questa espressione dia per scontato di sapere cosa fosse un festa primitiva e ironizza su certe descrizioni moderne come quelle citate, che sembrano piuttosto travestire i selvaggi di Rousseau per farli passeggiare nella Vienna di Freud.3 Sono affermazioni che per Jesi si muovono ambiguamente fra scienza etnologica e fantasticherie. In realtà, nella modernità si può solo constatare che il concetto di festa collettiva come si suppone sia stato anticamente il Carnevale è perduto, oppure si trasforma in consumismo spettacolare di massa: pensiamo cosa è diventato l’antico rito celtico del culto dei morti nella riproposizione di Halloween. Gli esempi di feste che costellano la letteratura europea degli ultimi due secoli, dalla Montagna incantata alla Recherche, sono feste crudeli o feste interiori: entrambe le cose in alcuni casi. Oppure, nel caso Musil, la festa diventa una impossibile e grottesca messa in scena che infatti alla fine non ha luogo.4
Jesi non prende in considerazione le feste canoniche dettate dalle scadenze religiose (il Natale cristiano per esempio), ma sottolinea come la posizione dell’etnografo sia quella di studiare la festa dei diversi – siano essi i popoli cosiddetti primitivi, oppure ciò che emerge dagli studi sul folklore – non potendo più partecipare alla festa in senso epifanico, cosa che nella modernità non sembra essere più possibile. In realtà nelle conclusioni Jesi dirà qualcosa di diverso come si vedrà: lo stesso si può dire della conclusione del saggio di Benjamin sul Surrealismo, ma prima di arrivare a quel punto occorre capire meglio la dialettica fra macchina antropologica, festa come evento epifanico e ricerca sul campo. Il folklore, in tutto questo svolge una decisiva funzione di cerniera perché è un ponte, instabile ma pur sempre un tramite, che permette di avere un’idea meno fantasiosa delle feste epifaniche del passato. A questo proposito va detto che la ricerca antropologica ha fatto passi da gigante negli ultimi venti anni. Mi riferisco per esempio a opere recenti come quelle di Graeber e altri.5 Abbandoniamo momentaneamente il primo saggio e rivolgiamoci al secondo.
Festa e sacrificio
Nel saggio su Pavese, Jesi torna alla letteratura e ingaggia con l’opera dello scrittore delle Langhe un corpo a corpo che ha come sempre aspetti di critica letteraria e connessioni remote con la macchina mitologica. Il discorso è assai complesso e parte dal modo che Pavese ha di concepire la natura:
[…] Pavese credeva nel valore dei miti come sistema di rapporti esistenti in natura […] Pavese ha operato come se esistesse in natura un sistema oggettivo di rapporti fra immagini mitologiche che – e si vuole come diceva Hesse “interpretare la natura!” – bisogna rispettare.
Jesi rifiuta tale concetto e rimprovera a Pavese di leggere nella natura la presenza: di un linguaggio mitologico immanente e oggettivo.6 Tale linguaggio, che Jesi attribuisce a Pavese, equivale a ritenere che al centro della macchina mitologica si troverebbe il mito in senso ontologico. Jesi nega entrambe le cose: la natura è una sfinge leopardiana e al centro della macchina mitologica c’è un vuoto. Subito dopo, Jesi entra nel vivo del dibattito su Pavese che aveva in quegli anni molti protagonisti. Egli nega l’appartenenza dello scrittore piemontese al decadentismo e si premura di chiarire la questione rispetto a un proprio saggio che poteva generare equivoci al proposito. Jesi cita Venturi con il quale si era aperta la polemica, ma ricorda pure gli interventi di Pasolini e Moravia. Quella polemica è in parte datata, ma è comunque la spia ancora attuale di una difficoltà reale: la collocazione di Pavese nel contesto letterario italiano a cavallo fra primo e secondo ’900 è difficile da districare, perché la sua presenza è fortemente anomala. Pavese ha di certo nel mito una fonte d’ispirazione, ma si tratta di un modo d’intendere la mitologia che non ha nulla a che vedere con il fascismo e la sua mitologia. In secondo luogo Pavese non ha nulla a che vedere con l’ermetismo. Infine c’è un contrasto evidente fra il suo americanismo e il sentirsi radicato in una cultura contadina e provinciale come quella delle Langhe. Pavese sta dentro una contraddizione, anche nel dopoguerra. Faccio un solo esempio. Si batté nella casa editrice Eianudi per avere fra i collaboratori Angelo Brelich, uno studioso del mito fra i più importanti di quegli anni, ma è pure vero che la concezione del mito di Brelich è assai diversa rispetto a quella di Pavese ma lo scrittore sembra non comprenderlo. Credo che un parziale errore di Jesi sia quello di attribuire a Pavese una consapevolezza etnografica e antropologica che lo scrittore in definitiva non aveva. Il suo modo di sentirsi legato ai riti contadini della sua terra è in realtà assai semplice e anche ingenuo: è un attaccamento viscerale che ha più a che fare con il folklore e che convive però con un culto dell’americanismo altrettanto ingenuo. Pavese, a mio avviso, riuscirà a superare tali aspetti contraddittori solo in poche opere, grandi, ma poche: I mari del sud, I dialoghi con Leucò e La Luna e i falò. 7 In altre parti di Lavorare stanca possiamo trovare dei testi sicuramente forti e apprezzabili e che proprio per questa ragione incorsero nella censura fascista; ma nessuno ha la forza a mio avviso dei tre ricordati in precedenza. Jesi solleva però un problema reale quando attribuisce a Pavese il tentativo di conciliare la modernità con il mito: le modalità scelte porteranno lo scrittore sempre più lontano dal mito inteso come rito epifanico collettivo, per approdare all’interiorizzazione del mito da parte del poeta, che diventa così il solo depositario – nella modernità – di quello che un tempo era un sapere collettivo diffuso. Jesi, al contrario, rifiuta l’interiorizzazione, ma si domanda anche quale sia il mito che la rende possibile e la risposta che si dà è molto netta: si tratta un mito di sacrificio e di morte, il solo che non produce intorno a sé altro se non l’aspetto sacrificale. Per Jesi, dunque, Pavese, pur non essendo un decadente, accetta l’impossibilità del mito come esperienza comunitaria della modernità e la trasforma nella ricerca interiore del proprio rapporto con il mito e con la natura, ma separato da tutto e da tutti. Anche Jesi, come il suo maestro Kerényi, prende atto che nella modernità l’epifania come si è conosciuta in passato non è più proponibile, ma per lui si tratta di quelle forme storiche e antropologiche, che tuttavia non possono essere considerate come eterne e statiche, perché la macchina mitologica non ha smesso di funzionare e di produrre narrazioni mitologiche anche in piena modernità.
La festa nel tempo della modernità
Per Jesi non si tratta di ritornare a una individualità separata, piuttosto di porsi il problema di comprendere in che modo possono esistere ritualità comunitarie anche nella modernità e nella post modernità, le quali, in qualche caso, possono persino recuperare frammenti da salvaguardare delle forme passate. In sostanza si tratta di esplorare il campo vastissimo del folklore ma anche interrogarsi sui tentativi moderni di ritualità collettive. Nel finale del suo saggio Jesi si riferisce prima di tutto al movimento operaio, anche se si limita a poche pagine. Tuttavia, se si considera l’insieme della sua produzione, possiamo ricostruire tutta una serie di esempi che hanno tratti interessanti comuni con quanto Benjamin aveva scritto negli anni ’30. Jesi, in alcuni altri scritti dedicati alle rivolte popolari, sottolinea come uno dei limiti dello Spartachismo, per esempio, fu quello di lasciare ai margini il concetto di festività come modalità di sospensione del tempo, che non può essere disgiunta dall’altra modalità di sospensione e cioè la rivolta. Ebbene, quando Benjamin nel saggio sul Surrealismo scrive che occorre portare alla rivoluzione le forze dell’ebbrezza, cosa afferma se non questo? Jesi, che ben conosceva Benjamin anche se le citazioni sono quasi sempre indirette e sotto traccia, riprende uno dei leitmotiv di quel saggio cui si può aggiungere il concetto altrettanto importante di illuminazione profana e materialista, precedentemente citato.8 Sempre Benjamin, a proposito della ritualità festiva delle manifestazioni operaie, aveva posto l’accento su un famoso episodio, accaduto durante la Rivoluzione di Luglio a Parigi, quando i rivoltosi distrussero tutti gli orologi, simbolo della cadenza industriale del tempo governata dal lavoro salariato. Sempre in Benjamin si trovano alcuni spunti interessanti nel saggio sulla riproduzione tecnica dell’opera d’arte, sui modi di festeggiare il Primo Maggio.
[…] i film di Ejzenštejn, il teatro didattico di Brecht, le feste del primo maggio con gli slogan di Majakovskij, le messe in scena di Malevič e di Mejerchol’d.
Questa citazione si trova nell’introduzione al saggio dal titolo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, sulla riproducibilità tecnica, traduzione e cura di Enrico Filippini, Einaudi Torino 1966, alla pagina 11. Non è la sola in cui Benjamin si occupa delle modalità di una ritualità collettiva nel tempo della modernità. Questa frase è particolarmente significativa perché àncora i riferimenti di Benjamin alle esperienze più radicali dell’avanguardia russa di quegli anni e al teatro di Brecht, ma si tiene a distanza dal realismo socialista.
In conclusione, l’intento di Jesi, come di Benjamin decenni prima, è quello di tornare a significare in modo diverso sia la festa sia la rivolta, sia la rivoluzione, come rito collettivo anche nella piena modernità; ma questo è un capitolo tutto da pensare.

1 Furio Jesi, Il tempo della festa, a cura di Andrea cavalletti, Nottetempo, Milano 2023.
2 L’espressione è usata da Benjamin più volte nel saggio sul Surrealismo e nelle carte preparatorie.
3 Furio Jesi, op. cit., pag.69.
4 Mi riferisco al romanzo L’Uomo senza qualità.
5 Mi riferisco in particolare al libro L’alba di tutto, scritto da David Graeber e David Wengrow , edito da Rzzoli nel 2021.
6 Furio Jesi, op. cit., pp. 122-23.
7 Nel blog diepicanuova, curato da Paolo Rabissi e da me, che presto diventerà un libro pubblicato, I Mari del sud sono uno dei testi manifesto cui è dedicata un’ampia riflessione critica.
8 Il saggio sul Surrealismo è un testo fondamentale di cui consiglio la lettura completa insieme alle carte preparatorie.

Introduzione
Furio Jesi ha attraversato la cultura e la politica italiane come una cometa e come tutte le comete è passato fugacemente per poi riapparire dopo un tempo più o meno lungo. La riscoperta più recente si è consolidata intorno a un aspetto della sua ricerca fra i meno noti. In Sinistra in rete, nel 2023, sono stati pubblicati saggi importanti, uno in particolare dal titolo: Come interrompere una dialettica. Benjamin, Jesi e la rivolta contro il tempo di James Martel – Emanuele E. Pelilli.1 Al centro di questa prima riflessione ci sono però due libri precedenti che costituiscono una sorta di background da cui partire per affrontare poi i temi sollevati dal saggio pubblicato in sinistra in rete e che implica fra l’altro un confronto con alcune opere di Walter Benjamin.
Il primo dei libri è Spartakus. Simbologia della rivolta, a cura di Andrea Cavalletti, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2000. Il secondo è Lettura del Bateau ivre di Rimbaud, con introduzione di Giorgio Agamben e una nota di Andrea Cavalletti, pubblicato da Quodlibet nel 1996. A questi aggiungo anche la recente intervista ad Andrea Cavalletti, che si può ascoltare in rete dal sito Scaldasole Books.
Jesi partecipò attivamente alla rivolta del Maggio francese e ritornò in Italia solo alla fine, quando – per usare le sue parole – “il tempo era ritornato normale”. A Torino partecipò a tutte le lotte in corso e nel dicembre del 1969 finì una parte della sua riflessione – Spartakus – e la scrisse in flagranza. Ritornare alla rivolta spartachista, nella quale di certo Jesi colse alcuni elementi presenti anche nel Maggio francese, gli permise di tornare alla Comune di Parigi – ma in modo traslato come spesso ha fatto. La Lettura del Battello ebbro passa attraverso la critica letteraria per approdare alla messa a punto di un apparato teorico già probabilmente maturo, ma non ancora suscettibile di essere mostrato. In fondo il ‘68, e in particolare quello italiano, fu una lunga rivolta e proprio leggendo Jesi si può cogliere ancora di più il tragico errore di chi pensò che fosse invece il tempo giusto della rivoluzione. Jesi cominciò proprio allora a interrogarsi sulle dinamiche interne della rivolta, dandole uno statuto specifico come nessuno aveva più fatto dopo Sorel. Guardando alle rivolte ci si può sottrarre da una dialettica del tutto confinata nella storia e che assomiglia da un lato al destino, oppure a una macchinetta asettica alla quale si può far dire di tutto e il suo contrario, come Benjamin rappresentò in modo puntuale nella prima delle sue Tesi sulla storia. Tuttavia, ciò non è possibile farlo senza decidere di accettare e fare propria la scommessa che la storia pone davanti a chiunque in certi momenti: la prassi è proprio quell‘insieme di gesti-parole,- altra espressione tipica di Jesi – che bisogna decidere di compiere e di accettare anche nelle loro conseguenze. Qui stanno le ragioni dell‘inattualità di Jesi per un lungo tempo. Superficialmente, esse avevano prima di tutto a che fare con il sospetto che nell’Italia di quegli anni si nutriva nei confronti di chi si occupava di mitologia. Più in profondità, perché nel pieno dell‘autunno caldo e specialmente dopo il 12 dicembre 1969, Jesi indicava – già allora – che invece di occuparsi solo del presente, che egli tuttavia non ha mai esorcizzato e tanto meno rimosso dal suo stesso agire in campo culturale e politico, sarebbe tuttavia stato meglio occuparsi del dopodomani. La storia editoriale e forse le sue scelte hanno nascosto per lunghissimo tempo Spartakus fino al 2000, un anno prima dei fatti di Genova e dell’attentato alle Torri gemelle. Cosa ci può essere di più attuale nell’Italia e nell‘Europa del 2023, di libri che invitano a guardare alle rivolte dell’altro ieri per poter pensare realisticamente l’oggi e il dopodomani?
***
PARTE PRIMA
Spartakus
Jesi, nell‘introduzione, spiega a grandi linee le ragioni dell‘opera, poi entra nel vivo e nel capitolo eponimo stabilisce una complessa analogia fra una citazione tratta dal Docktor Faustus di Thomas Mann e il saggio di Sorel sulla violenza, scritto subito dopo la prima guerra mondiale e che era stato lo spunto da cui anche Benjamin aveva cominciato il suo saggio del ’21. La frase di Mann è questa:
Chi voglia essere partecipe della comunità deve tenersi pronto a sostanziose detrazioni dalla verità o dalla scienza, al sacrificium intellectus… 2
Docktor Faustus fu scritto nel 1943 e pubblicato nel ’47, ma la comunità di cui parla è la società tedesca di trent’anni prima e l’accenno al venir meno di scienza e verità è una riflessione col senno di poi e una polemica in differita contro gli pseudo miti nazisti che iniziarono a diffondersi proprio negli anni successivi il primo conflitto mondiale, rispetto al quale va pure detto che Mann manifestò una certa ambiguità – se si pensa al capitolo finale di La montagna incantata – dove Castorp, pur malato, si precipita nel conflitto come in una sorta di lavacro. Mann usa nel capitolo un tono epico e nella conclusione la guerra diviene sia festa di morte sia malo delirio.3 Jesi, tuttavia, si richiama all’opera di Mann in modo sibillino e traslato, cioè per sottolineare come nella Germania del 1919 i miti che circolavano non erano solo quelli criticati da Mann: Sorel, pur con tutte le ambiguità di quegli anni, è pur sempre un teorico dell’anarcosindacalismo e l’accenno di Jesi al suo libro è un tramite che ci porta nel cuore della sua riflessione. La Spartakusbund nasce nel 1919 e anche Spartaco è un mito e non soltanto un personaggio storico. Con lui arriviamo al secondo punto focale del libro, anche se il suo autore precisa che esso non vuole essere una ricostruzione storica del movimento spartachista e dell’insurrezione di gennaio. In realtà il libro è anche questo e lo è in modo assai calzante e sintetico, ma il suo intento è duplice: da un lato affermare che ogni tentativo di espellere la macchina mitologica dalla storia secondo la tradizione illuminista, è destinato a cadere nel vuoto o a ritorcersi contro coloro che lo affermano. Tuttavia, la dialettica fra mito e storia è secondo Jesi una manipolazione borghese del tempo4 e dunque i due termini, mito e storia, vanno letti prima di tutto nella loro reciproca autonomia. Jesi prosegue proiettando la vicenda dello spartachismo nel passato recente della Germania e cioè:
[…] a un filone della cultura tedesca che può essere colto più agevolmente – almeno per ora –nei suoi momenti cristallizzati: […] l’illuminatenorden che Adam Weishaupt fondò a Ingolstadt nel 1776, assumendo il nome Spartakus e più tardi nel movimento organizzatosi in Assia intorno al rettore Widig e a Georg Büchner nel 1830-40.5
L’intento, costante in tutta la sua opera, è quello di sottolineare sempre come la mitologia nera tedesca, oggetto del suo libro Germania segreta, Cultura di destra e altri, non sia la sola esistente.6 Nel capitolo intitolato La sospensione del tempo storico, Jesi ricostruisce in una paginetta le ragioni della rivoluzione. Lo fa ripercorrendo il pensiero di Marx e sottolineando in particolare la necessità che un progetto rivoluzionario sia basato su un’analisi dei rapporti di forza e delle dinamiche sociali. Esaurito il tema in breve, egli cambia registro:
[…] Questo orientamento politico e la filosofia della storia che vi corrisponde incontrano un grave ostacolo nel fenomeno della rivolta. Usiamo la parola “rivolta“ per designare un movimento insurrezionale diverso dalla rivoluzione. La differenza fra rivolta e rivoluzione non va cercata negli scopi dell’una e dell’altra […] Ciò che maggiormente distingue la rivolta dalla rivoluzione è invece una diversa esperienza del tempo. Se, in base al significato corrente delle due parole, la rivolta è un improvviso scoppio insurrezionale che può venire inserito dentro un disegno strategico, ma che di per sé non implica una strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è invece un complesso strategico di movimenti insurrezionali coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi finali, si potrebbe dire che la rivolta sospenda il tempo storico e instauri repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale per se stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di transitorietà e di perennità di cui consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece interamente e deliberatamente calata nel tempo storico.7
A questa prima affermazione segue un’analisi puntuale, incalzante e appassionata dei dieci giorni della rivolta spartachista del 1919 che fra l’altro dimostra quanto poco sia stata analizzata nelle sue dinamiche interne e in modo così profondo.8 Jesi riconosce il fallimento della rivolta e ne indica le ragioni in modo puntuale e dopo un’altra lunga digressione, ritorna ad essa tramite Brecht: Trommels in der Nacht – Tamburi nella notte è infatti il lavoro teatrale con cui Brecht la rievoca. La prima versione del testo fu scritta in presa diretta sugli eventi, proprio nello stesso 1919, inaugurando un’idea di teatro che ritroveremo puntualmente nell’Agit Prop.
Jesi paragona il testo di Brecht al Docktor Faustus di Mann, sottolineando l‘ambiguità del secondo, ma riconoscendo pure che anni dopo, entrambi decideranno di mettere fra parentesi la rivolta spartachista, pur rimanendo distanti le loro posizioni. Brecht deciderà di non rappresentare il dramma, mentre Jesi – ripercorrendone tutti gli atti – gli assegna l’importanza che ha. Il personaggio chiave dell‘opera è Kragler, un figura assai complessa dal momento che è al tempo stesso un anonimo piccolo borghese, sia una figura della mitologia tedesca, cioè il reduce dato per morto e che al ritorno non viene riconosciuto neppure dalla madre, che pensa di trovarsi davanti a un fantasma. Jesi ricostruisce puntualmente tutti gli atti del dramma e al libro rimando per questo. Ridotto all’osso, lo svolgimento è il seguente. Kragler torna dalla prigionia proprio durante la notte in cui la rivolta spartachista ha inizio e scopre che la sua fidanzata sta per fidanzarsi con Murk, un borghese ben più ricco di lui. Indignato per il torto subito si unisce alla rivolta spartachista. Anna, che aveva accettato di sposare Murk per ragioni d’interesse, quando rivede il suo vecchio amore lo segue di nuovo e i due vagano per la città nel mezzo dell’insurrezione, finché Kragler si convince che essa non ha alcuna speranza di successo e torna a casa con la fidanzata, voltando le spalle agli spartachisti. Brecht, lo si evince dal testo di Jesi, ma anche dalla storia assai travagliata dell‘opera e delle sue rappresentazioni, ebbe sempre un atteggiamento di ambivalenza verso di essa e arrivò poi a non pubblicarla nell’opera omnia. Jesi salva il testo e lo valorizza, ma rimane sulla soglia di una vera riabilitazione e penso sia utile domandarsene la ragione. La lettura di classe del dramma – la piccola borghesia si lascia coinvolgere dal proletariato, ma nel momento dello scontro vero si tira indietro – è altrettanto riduttiva di quella che riconduce tutto al mito del reduce che non viene riconosciuto, anche perché nel dramma di Brecht c’è uno scostamento rispetto alla rigidità del mito e il riconoscimento in qualche modo avviene. L’ambivalenza di Brecht è giustificata nel senso che egli stesso si trova su un crinale pericoloso, che può colludere anche con quella mitologia germanica negativa che produce fantasmi che possono diventare mostri. Sotto traccia, però, c’è una polemica molto contemporanea. Kragler è anche il personaggio che rifiuta quella parte dell’Espressionismo tedesco che era più incline a lasciarsi trascinare dentro la mitologia germanica o a ripiegare in una sorta di soggettivismo intimista a tinte fosche. L’espediente teatrale usato da Brecht è di rappresentarlo come un personaggio comico, ubriaco e un po‘ sconclusionato. Anche questo, però, non risolve il problema. Jesi avverte opportunamente che quando Brecht scrisse I tamburi nella notte, il concetto di straniamento – che diventerà centrale e fondamentale in tutte le sue opere e che sarà l’oggetto di un importante saggio scritto da Benjamin sul teatro di Brecht 9 – non era stato ancora elaborato dal drammaturgo, per cui la figura di Kragler risulta inquinata da una certa dose di simpatia del suo autore nei suoi confronti. Tuttavia a me pare che la questione sia ancora più complessa e che Jesi la conosca benissimo. Brecht si stava interrogando sul senso del comportamento eroico, altro tema nevralgico per la cultura tedesca e non solo. Su questo Brecht fu sempre molto netto: fu lui a dire guai a quel popolo che ha bisogno di eroi e allora I tamburi nella notte ci riportano alla domanda delle domande, la stessa che, sotto traccia, si pone Jesi dall’inizio di Spartakus: il sacrificio di Luxemburg e Liebknecht fu un gesto romantico-espressionista che in qualche modo collude anche con quella zona oscura del mito germanico, oppure fu altro? Brecht non sciolse mai del tutto il dilemma e questo spiega la sua costante ambivalenza nei confronti della sua opera, mentre invece Jesi ha dato una risposta netta, non in polemica diretta con Brecht e neppure con Thomas Mann, ma basata sul rifiuto di stare per forza dentro le maglie strette della dialettica fra mito e storia. Jesi contesta che la fine dei due leader della rivolta sia rapportabile a un atteggiamento romantico-espressionista, ma si pone a lato di entrambi i poli della questione – il mito da uno la storia dall’altro – considerandoli non dentro una cogente e inestricabile relazione che ricorda più il destino che non la dialettica, ma cerca di leggere nella loro autonomia cosa sta dentro l’uno e dentro l’altra per giungere alla sua conclusione:
[…] Siamo perfettamente disposti a considerare la morte di Liebknecht e della Luxemburg, dal punto di vista della più razionale strategia politica, un errore; ma vogliamo distinguere le ragioni della loro scelta di morte da un “malinteso senso dell‘onore“ che fu individuato da alcuni storici subito dopo la seconda guerra mondiale […] si trattò di usare la propaganda – oggi così simile a menzogna – nel suo significato più genuino: nello stesso significato – ci si consenta una digressione di tempo e di luogo – in cui nel Vietnam si è scelto il suicidio col fuoco come simbolo di reazione contro l’aggressione americana. Giocare la propria persona sul limite della morte mentre le vie del quartiere dei giornali di Berlino erano campi di battaglia, significò allora compiere la sutura fra mito genuino, affiorato spontaneamente e disinteressatamente dalla profondità della psiche, e autentica propaganda politica. In questo modo la propaganda fu una manifestazione della verità, o almeno di quella verità in cui credevano le vittime della sua epifania.. 10
Nel capitolo quarto dal titolo Inattualità della rivolta, Jesi tira le fila della riflessione. All’inizio ricorda una frase di Nietsche che, pensando ai tedeschi e alla loro storia, afferma in sostanza che essi appartengono all’altro ieri e al dopodomani ma che non hanno un oggi. Jesi riprende la frase e la colloca in un contesto completamente diverso da quello pensato dal filosofo e cioè:
[…] all’intersezione dell’“una volta per sempre“ e dell’“eterno ritorno“: non tanto del tempo storico e del tempo mitico ma dell’altro ieri e del dopodomani.11
Dopo aver notato che sulla rivolta premevano e si manifestavano forze del passato tedesco, per cui essa non scaturiva solo dalle contraddizioni del suo tempo, Jesi ne deduce la mancanza di una realistica valutazione di contraddizioni e rapporti di forza. In sostanza, ripete che mentre la rivoluzione è un rovesciamento dialettico dell’esistente che corrisponde all’oggi ed è compiutamente nella storia (immagino che la Rivoluzione d’Ottobre fosse sullo sfondo di tale ragionamento), la rivolta:
[…] conserva del passato eredità così pesanti da escludere un vera e propria dialettica […] La rivolta, proprio perché esclude la dialettica delle contraddizioni interne al capitalismo nascente è l’epifania violenta delle componenti reazionarie nelle mani dei rivoltosi, suscita il “dopodomani“ […] ne evoca l’epifania. Quali rapporti possiede quell’epifania con la realtà storica? In quale misura l’epifania del dopodomani è un contributo al rovesciamento del capitalismo?12
Per poter rispondere a tali domande occorre abbandonare il punto di vista storicista, del tutto interno alle contraddizioni dialettiche date ed è proprio questo uno dei temi centrali delle tesi sulla storia di Benjamin. La possibilità di valutare l’utilità dell’epifania del dopodomani:
[…] è insita in una indagine fenomenologica che agisce dall’interno garantendo dall’interno obiettività alla rivolta e alle sue esperienze del tempo […] riconoscere nella rivolta quell’esasperazione della reazione che prepara il dopodomani ben più della rivoluzione. Se ciò che importa è unicamente l’oggi o il domani niente è più riprovevole della rivolta. Ma se il dopodomani conta e conta più dell’oggi e del domani la rivolta è un fatto altamente positivo.13
Questo brano può forse aiutare meglio a comprendere perché il saggio introduttivo a Spartakus s’intitoli Sovversione e memoria. L’operazione che Jesi compie con questo libro si apre a ventaglio su molte questioni, ma prima di tutto ha a che fare proprio con quell’esigenza di compiere un’indagine fenomenologica dall’interno della rivolta. Il libro è prima di tutto questo e non mi sembra di avere letto altrove analisi altrettanto puntuali. Quelle più canoniche e scontate si limitano a prendere atto del fallimento, oppure si trincerano dietro l’omaggio a Luxemburg e a Liebknecht; oppure ancora sottolineano alcune cose ovvie, cui accenna anche Jesi e cioè che furono all’opera anche agenti provocatori. La sensazione è che la rivolta, come più volte accenna anche Jesi, sia stata messa fra parentesi anche da Brecht molti anni dopo, ma senza mai risolvere veramente il problema. Per tale ragione I tamburi nella notte escono ed entrano dalla sua produzione come qualcosa di semiclandestino. Qualcosa di più però era nell‘intento di Jesi e si preciserà risalendo al saggio sul Battello ebbro del 1996.
Il Battello ebbro e Spartakus

Il saggio su Rimbaud fu pubblicato una prima volta nel 1972 su Comunità e poi nel 1996 da Quodlibet. Esso è successivo alla stesura di Spartakus; solo che nessuno poteva saperlo con certezza, dal momento che quest’ultimo fu ritrovato fra le carte del suo autore soltanto nel 2000, vent’anni dopo la sua morte; tuttavia, erano in molti a sapere della sua esistenza e fra le testimonianze c’è anche una lettera di particolare importanza. Le due opere, in ogni caso, si rimandano l’una all’altra in un intreccio che pone molti problemi, anche di decifrazione dei due testi: entrambe infine, rimandano ad altre due opere di Jesi e cioè a Germania segreta e Il tempo della festa. Il saggio sul Battello ebbro è una vetta particolarmente elevata del suo lavoro critico e in particolare un’esemplificazione fra le più originali del metodo di lavoro, sempre indirizzato a trovare connessioni remote fra testo letterario e storia, storia e mito, ma rifiutando al tempo stesso la connessione dialettica fra i due termini che Jesi considera come già si è visto una manipolazione borghese del tempo: tale concetto è ripetuto più volte in forme diverse. Nel caso specifico di questo saggio c’è però un elemento in più, ingombrante e affascinante e cioè che il lavoro critico è su un testo intorno al quale, come Jesi stesso ricorda nei paragrafi introduttivi, è stato costruito, da chi è venuto dopo, un monumento imponente. Avvicinarsi al Battello ebbro vuol dire cimentarsi anche con la critica propriamente letteraria e con tale monumento.
Le date hanno un’enorme importanza nella ricostruzione del percorso intellettuale di Jesi. Nella sua introduzione a Spartakus, Cavalletti ricorda un particolare: fu proprio nella notte fra l’11 e il 12 dicembre del 1969 che Furio Jesi scrisse una lettera a un amico nel quale annunciava che la stesura di Spartakus. Simbologia della rivolta era finalmente concluso. Il giorno dopo a Milano successe qualcosa che cambiò radicalmente la storia italiana recente: la bomba di piazza Fontana. Cavalletti non lo nota, ma tale circostanza casuale ha a mio avviso profondamente a che fare con Jesi e con la sua ricerca, e forse permette anche di capire meglio per quale ragione un libro come Spartakus non fu pubblicato fino al 2000. Le vicende editoriali che Cavalletti riassume puntualmente nella sua introduzione, non sono a mio avviso sufficienti a determinare con certezza le ragioni per cui il libro venne alla luce così tardi. Jesi era già così noto e – anzi – considerato un enfant prodige della critica italiana, che non gli sarebbe stato difficile trovare un editore, dopo la rottura intervenuta con Silva; oppure poteva pubblicarlo egli stesso, come avveniva in quegli anni. Certe edizioni Feltrinelli – i piccoli libri rossi – che erano assai simili ai samizdat clandestini che venivano pubblicati in Unione Sovietica ma anche a Berlino nel 1968, lo avrebbero ospitato sicuramente. Forse Jesi scelse di non pubblicarlo, riflettendo su quanto stava avvenendo in Italia e lasciò fluttuare quel libro, ben sapendo che prima o poi sarebbe stato ritrovato. Quanto al Battello ebbro tutto sembra più chiaro, ma a ben vedere la cosa non è affatto scontata. Non ci sono dubbi sull’autenticità della lettera di Jesi del ‘69, ma non possiamo essere del tutto certi che Spartakus non sia stato modificato successivamente. Poiché in entrambi i testi ci sono parti riportate quasi letteralmente e integralmente in qualche caso, parrebbe scontato che si tratterebbe di una trasposizione dal primo al secondo, ma ci sono buone ragioni per pensare che potrebbe essere anche il contrario.
Il Battello di Rimbaud e il Battello di Jesi
Prima di entrare nel merito dell‘opera, Jesi sgombra subito il campo da un possibile equivoco: la partecipazione di Rimbaud alla Comune di Parigi è probabilmente leggenda, legata a qualche sua frase in cui il poeta esprime un generico entusiasmo per l’insurrezione e l’intenzione di partire per la capitale francese. Se anche non fosse leggenda, tuttavia, l’analisi di Jesi rovescia i termini della questione fino al paradosso: è se mai il testo ad avere partecipato all’insurrezione, ma non il suo autore. Rimbaud fu un profeta della rivolta, ma lo fu per una coincidenza di date e involontariamente, mentre di suo perseguiva altro fin dall’inizio: affrancarsi dall’angusta provincia francese per farsi notare da quelli di Parigi. Jesi s’interroga sulla natura delle visioni che vi compaiono e parla della presenza in esso di due miraggi. Il primo è una sospensione del tempo storico, espressione che Jesi ritiene essenziale per comprendere cosa sia una rivolta, come aveva scritto in Spartakus:
Ciò che maggiormente distingue la rivolta dalla rivoluzione è invece una diversa esperienza del tempo […] Se, in base al significato corrente delle due parole, la rivolta è un improvviso scoppio insurrezionale che può venire inserito dentro un disegno strategico, ma che di per sé non implica una strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è invece un complesso strategico di movimenti insurrezionali coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi finali, si potrebbe dire che la rivolta sospenda il tempo storico 14
L’equipaggio del battello, ucciso dai pellirosse, proietta il mezzo verso un viaggio immaginario, che per Jesi è collegato al mondo dell’infanzia. Se pensiamo a un bambino che gioca e che trasforma qualsiasi oggetto tenga in mano in qualcosa d’altro, ritroviamo alcune delle modalità del viaggio immaginario che Rimbaud fa compiere al suo battello. Il secondo, alla fine del testo, è il miraggio di un mondo rimpicciolito, dove il battello – ridotto alle dimensioni di una barchetta di carta che un bambino libera in una pozzanghera – riporta tutto a una dimensione prosaica e infantile: la visione lascia il posto a un mondo che torna a misura di bambino, ma che riflette anche la delusione di una sconfitta. Il regno della libertà senza limiti è perduto e l’immagine finale non è solo il ritorno a una dimensione rimpicciolita – un mondo di bambini come lo definisce Jesi – ma è paradossalmente anche il suo opposto: il bambino è diventato adulto, ha compreso che il regno della libertà senza alcun limite semplicemente non esiste. L’aspetto bambinesco e infantile, tuttavia, è presente in entrambi i miraggi e le due parole, peraltro, non sono la fotocopia l’una dell’altra: infantile vuol dire qualcosa di diverso dal semplice essere bambino e può benissimo descrivere anche la condizione di un diciassettenne come era Rimbaud quando scrisse il Battello ebbro che, ricorda Jesi una seconda volta, fu un testo d’occasione, scritto per farsi vedere e accreditarsi come poeta presso il mondo degli adulti che contano. Jesi arriva a definirlo una sorte di merce che il bambino-adolescente Rimbaud offre ai parigini e ai posteri che gli costruiranno sopra un duplice monumento: sul testo medesimo e sul poeta come personaggio. Arrivato a questo punto, Jesi s’interroga però sulle visioni che accompagnano il testo e le descrive come luoghi comuni. Il termine è usato in due accezioni diverse: l’una è quella che associa il concetto a qualcosa di prosaico, per esempio le immagini tratte da Magasin Pittoresque, una rivista molto amata da Rimbaud nella quale si ritrovano spunti paesaggistici che poi il poeta riusa nel testo (di cui parla peraltro Rimbaud stesso in Une saison en enfer). La seconda accezione del termine, più complessa, viene trattata da Jesi nel paragrafo 11 e ha a che fare con le immagini che provengono all’autore da non si sa da che cosa o dove. Jesi sta parlando del processo creativo e si chiede se sia lecito affermare che tali visioni giungono al poeta o che addirittura s’impadroniscono dello scrivente: è quello che intendevano i romantici per ispirazione, qualcosa che giunge al poeta da un altrove – Jesi lo definisce proprio un altro mondo – in cui si mescolano luoghi comuni o cose nuovissime, risonanze arcane e immagini che si sono impresse nella memoria e poi sono state dimenticate. Questo è per Jesi proprio il modo di funzionare della macchina mitologica. Dopo avere posto tale analogia, egli s’interroga sulla medesima e scrive:
Credere a ciò equivale a credere che il mito esista autonomamente entro la macchina mitologica […] Non credere a ciò equivale a non credere nell’esistenza autonoma del mito entro la macchina mitologica, equivale a essere persuasi che la macchina mitologica è vuota e che il mito così come l’essenza dei luoghi comuni usufruibili nell’“Alchimie du verbe“, sia un vuoto cui la macchina mitologica rimanda. 15
Nel paragrafo 12, che cito per intero, Jesi tira le fila della sua riflessione:
Pare a questo punto che ci sia un’alternativa: fede e non-fede. E tuttavia, almeno entro i limiti del nostro linguaggio, (dunque entro i limiti in cui la parola “alternativa“ è significante), tale alternativa di fatto non c’è. Credere che il mito sia autonomamente dentro la macchina mitologica – che l’essenza del luogo comune sia autonomamente dentro l’“Alchimie du verbe“ – non può voler dire altro che il mito non c’è – che l’essenza del luogo comune non è: se ci sono, sono in un “altro mondo“: ci non-sono. Anche il più convinto sostenitore della non fede è costretto a consentire a un involontario atto di fede: non vi è fede più esatta in un“altro mondo“ che Ci non-è della dichiarazione che tale“altro mondo“ non è. La particella “ci“ aderisce strettamente al J’aimais di Rimbaud e indica soltanto l’adesione deliberata di contro all’adesione involontaria. Vi è d’altronde una differenza importante fra il negare per affermare e il negare per negare fra il dire che quel mondo“altro“ ci-non è e il dire che esso non è […] Assolutamente inadatta ad essere in qualche modo istruttiva circa quel mondo, poiché il nostro linguaggio resta inerte dinanzi al miraggio del divenire, “la freccia che supera la corda per essere raccolta nel balzo, più di se stessa“ codesta differenza è invece molto istruttiva circa il comportamento degli uomini che essa discrimina. Gli uni, gli uomini del ci-non è possono essere gli uomini della rivolta e certamente sono predisposti a divenirne i profeti ed essere usati come i profeti di essa, e suoi fiancheggiatori che ne promettono la sua ripetibilità; gli altri, gli uomini del non è, hanno dinnanzi solo la rivoluzione o la conservazione se decidono di rinunciare a se stessi e di accettare i rapporti di forza in cui si trovano. Il fascino della rivolta consiste innanzitutto nella sua immediata inevitabilità: essa deve ineluttabilmente accadere. Il tempo è sospeso: ciò che è una volta è per tutto. Così come nell’alchimia, se l’esperimento fallisce ciò significa che non si era sufficientemente consapevoli e puri. Il profeta annuncia la sospensione del tempo, ed anche la ripetibilità della sospensione del tempo. La rivoluzione può esercitare fascino assai minore proprio perché è estremamente arduo ed incerto stabilire quale sia il suo giusto tempo, ed anche perché, non essendo inevitabile, nel giusto tempo, se non ha luogo nel momento giusto non accadrà forse più per un lunghissimo intervallo di tempo.16
Ebbene, questo passaggio così decisivo per mettere a punto il nucleo teorico di cui Jesi si serve nella sua analisi della rivolta spartachista in Spartakus, si trova solo nel saggio sul Battello ebbro, mentre molti passaggi sono riportati alla lettera in entrambi i libri, per esempio quello qui di seguito, assai noto e celebrato:
[…] Si può amare una città, si possono riconoscere le sue case e le sue strade nelle proprie memorie più remote e segrete; ma solo nell’ora della rivolta la città è sentita veramente come l’haut-lieu e al tempo stesso come la propria città: propria poiché dell’io e al tempo stesso degli altri; propria, poiché campo di una battaglia che si è scelta e che la collettività ha scelto; propria, poiché spazio circoscritto in cui il tempo storico è sospeso e in cui ogni atto vale di per se stesso, nelle sue conseguenze immediate. Ci si appropria di una città fuggendo o avanzando nell’alternarsi delle cariche, molto più che giocando da bambini per le sue strade o passeggiandovi più tardi con una ragazza. Nell’ora della rivolta non si è più soli nella città […]17
Torniamo al testo di Rimbaud. Nella sequenza di visioni che costellano il primo dei due miraggi compaiono i fiumi impassibili, le incredibili Floride, le Penisole libere da ormeggi i sogni di notti verdi dalle nevi abbagliate e cioè tutto un campionario in cui si mescolano luoghi comuni banali e suggestioni, per approdare al luogo comune più frequentato dalla cultura europea a partire dalla seconda metà del ‘700: la fuga dall’Europa, verso il suo sud e l‘oriente. Il Grand Tour del battello ebbro, però, va verso le Americhe e questo è per quanto mi riguarda un passaggio decisivo che mi sembra Jesi sottovaluti. Il regno della libertà senza alcun limite, che il battello sperimenta, si trasforma presto nel suo opposto e improvvisamente il testo cambia tono:
[…] Filando eternamente sull’acque azzurre e immobili/, Io rimpiango l’Europa dai parapetti antichi!// Ho visto gli arcipelaghi siderei e isole/Dai cieli deliranti aperti al vogatore:/È in queste notti immense che dormi e t’esili/Stuoli d’uccelli d’oro o futuro vigore? – Ma è vero ho pianto troppo! Le Albe sono strazianti./Ogni luna mi è atroce ed ogni sole amaro […] Se desidero un’acqua d’Europa è una pozzanghera/Nera e gelida quando nell’ora del crepuscolo/Un bimbo malinconico libera in ginocchio/ Un battello leggero come farfalla a maggio […]
Rimbaud fra i miraggi e la storia
Jesi, oltre ai due miraggi, indica l’esistenza di un terzo livello – lui lo definisce con l’espressione significati terzi – ed è proprio su tale terzo livello che si gioca la possibilità di una sintesi ed è anche, per quanto mi riguarda, il punto su cui la mia riflessione diverge da quella di Jesi. Tale terzo livello si gioca sempre dentro la dinamica fra l’aspetto bambino e infantile che percorre il testo di Rimbaud e il suo aspetto adulto. Jesi nota come il viaggio avventuroso del Battello sia dovuto al caso – Sentii che i trainanti non mi guidavan più – e con ironia sottolinea come esso non sia la La corazzata Potëmkin conquistata dal suo equipaggio per dare inizio a una rivoluzione. Jesi inserisce questa rapida notazione per ribadire che mentre la rivoluzione è una sequenza di atti pensati e programmati, la rivolta non lo è: si tratta di un chiaro riferimento di quanto affermato in Spartakus. Se l‘avventura del battello serve a Jesi per introdurre il dispositivo teorico del ci-non è, tuttavia egli ha per me il torto di fermarsi a quello da un punto di vista critico letterario e di saltare subito alle conclusioni:
[…] Nel Bateau ivre il fallimento dell’esperienza del regno della libertà in termini di materia poetica apre per Rimbaud la via di una critica al privilegio della materia poetica, che condurrà all’abbandono dell’attività creativa e all’esperienza abissina: dal luogo comune in sede di poesia al luogo comune in sede di comportamento. Se l’attività poetica di Rimbaud costituisce un momento di rivolta, la sua attività di commerciante e viaggiatore in Africa costituisce un momento di rivoluzione. Si tratta però di una rivoluzione solitaria e pessimistica …18
Tale sintesi non mi convince perché è basata su una totale separazione del testo dall’adulto Rimbaud, che nascerebbe solo a opera compiuta. Jesi stesso ci ha però ricordato come per il poeta quello fu un testo d’occasione scritto perché lo vedessero quelli di Parigi e dunque nel diciassettenne era già attivo – seppure in modo ancora ingenuo – anche l’affarista: non ci sono mai stati due Rimbaud! Ci sono invece a mio avviso tre frammenti nell’opera, che si scostano dal meccanismo delle visioni e dei luoghi comuni e dunque dai significati primo e secondo. Sono tre frammenti che fra l’altro spiegano a mio giudizio la stranezza di questo Grand Tour che invece di dirigersi a sud e a oriente, va invece verso le Americhe. Il primo frammento è proprio all’inizio del testo:
[…] Col mio cotone inglese con il mio grano fiammingo/Non mi curavo più di avere un equipaggio/
Il secondo frammento si colloca idealmente nel mezzo, seppure un po’ spostato verso il finale:
[…] Spinto dall’uragano nell’aria senza uccelli/ – Nè i velieri anseatici, né i Monitori avrebbero/ Ripescato il mio scafo ubriaco d’acqua.
Infine proprio i versi finali:
/Non posso più, bagnato da quei languori e onde/Filare nella scia di chi porta cotone,/Né fendere l’orgoglio dei pavesi e dei labari,/né vogar sotto gli occhi orrendi dei pontoni.19
Nel profluvio di visioni e luoghi comuni compare improvviso in questi frammenti l’orrore della storia: il battello trasporta le merci coloniali per eccellenza e va sulle rotte delle Americhe, perché è là che avvengono i traffici più sordidi, compreso lo schiavismo. Però nel testo, a dispetto di Rimbaud, è la rivolta che vince perché il battello alla fine dice che non può più filare nella scia di chi porta il cotone: certo, è tornato a essere una barchetta di carta liberata in una pozzanghera, ma il testo contraddice le scelte dell’uomo e non le conferma. Rimbaud non era un rivoltoso, tanto meno un rivoluzionario, ma un ribelle senza causa che, avendo in odio i piccoli borghesi di Charleville, scrive un testo d’occasione per farsi notare da quelli di Parigi.
Conclusioni provvisorie e in progress
Spartakus e il saggio sul Battello ebbro si rimandano l’uno all’altro e in fondo ha poca importanza sapere quale dei due venga prima e se il primo sia stato modificato. In entrambi c’è tuttavia un passaggio assai simile che mi porta verso le conclusioni: perché se l’aspetto puramente letterario dell’analisi Jesi si conclude nei modi già detti, il nucleo teorico messo a punto con il Ci-non è, rimane ancora inconcluso e incompleto. Riporto allora due citazioni che si trovano in entrambi i testi, pur con qualche minimo scostamento:
Da Spartakus: La differenza fra rivolta e rivoluzione non va cercata negli scopi dell’una e dell’altra […] Ciò che maggiormente distingue la rivolta dalla rivoluzione è invece una diversa esperienza del tempo. Se, in base al significato corrente delle due parole, la rivolta è un improvviso scoppio insurrezionale che può venire inserito dentro un disegno strategico, ma che di per sè non implica una strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è invece un complesso strategico di movimenti insurrezionali coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi finali, si potrebbe dire che la rivolta sospenda il tempo storico e instauri repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale per se stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di transitorietà e di perennità di cui consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece interamente e deliberatamente calata nel tempo storico
Dal Saggio sul Battello ebbro: La parola rivoluzione designa correttamente tutto il complesso di azioni a breve e a lunga distanza che sono compiute da chi è cosciente di voler mutare nel tempo storico una situazione politica, […] ed elabora i suoi piani tattici e strategici considerando costantemente nel tempo storico i rapporti di causa ed effetto. Ogni rivolta si può invece descrivere come una sospensione del tempo storico. Nello scontro della rivolta si decantano le componenti simboliche dell’ideologia che ha esso in moto la strategia e solo quelle sono davvero percepite dai combattenti. 20
Nel finale del saggio sul Battello ebbro Jesi si rende conto che continuare a ripetere semplicemente che storia e mito, rivoluzione e rivolta sono pur sempre manipolazioni borghesi del tempo, non è sufficiente perché se si rimane fermi a questo si rischia di far ritornare dalla finestra una condizione destinale che si era scacciata dalla porta. Il problema è così affrontato nell’ultimo paragrafo, il tredicesimo. Ne cito solo le parti che si riferiscono al tema del rapporto fra storia e macchina mitologica, perché altre parti in cui Jesi ritorna alla critica letteraria del testo di Rimbaud non aggiungono nulla a quanto detto in precedenza.
L’una e l’altra, […] la rivolta e la rivoluzione, non contraddicono a livello concettuale il modello proposto dalla macchina mitologica. Anzi: nella prospettiva operata si adatta sia all’una sia all’altra e codesto modello finisce per identificarsi con l’a priori che resta quale fondamento solido e oscuro del processo gnoseologico. Di fronte all’essenza del luogo comune – o all’essenza del mito – non vi è autentica alternativa concettuale, bensì soltanto alternativa gestuale, di comportamento, […] che resta comunque circoscritto entro la scatola delimitata dalle pareti della macchina mitologica. Rivolta e rivoluzione a livello concettuale, restano null’altro che diverse articolazioni (sospensione del tempo; tempo giusto), del tempo che vige all’interno di quella scatola .[..] Spezzare codesta radice significherebbe disporre di un linguaggio o di un complesso di gesti tali da affrontare la macchina mitologica su un piano che consentisse di dichiarare al tempo stesso l’esistenza e la non-esistenza di ciò che la macchina dice di contenere […]21
Tale conclusione non ribadisce semplicemente il valore del nucleo teorico del ci-non è, che è pur sempre solo un concetto. La parte finale della citazione chiude una parte del discorso e si apre al tempo stesso su un orizzonte di senso che rimanda alla necessità di un linguaggio-gesto e a un altro libro di Jesi e cioè Il tempo della festa. È un passaggio che per analogia, si parva licet, mi ricorda un altro passaggio e cioè quello che avviene fra i Manoscritti economico filosofici del ’43 che rimangono pur sempre nell’ambito della critica del pensiero e del concetti hegeliani e le Tesi su Feuerbach, purché le si legga sempre per intero e non si usi l’undicesima tesi come una clava da dare in testa a qualcuno. Jesi compie il medesimo passo con una coerenza ardua da seguire, eppure esposta con chiarezza, perché le elaborazioni dei suoi testi maggiori, non nascono solo da una rara capacità di scovare connessioni remote fra storia, mito e letteratura. In questo fu certamente un maestro, ma nel caso specifico dei testi ricordati essi non sarebbero nati se non fossero stati sostenuti anche da una felice combinazione di gesti-parole o viceversa perché la formula può essere usata a partire da entrambi i lati, come viene affermato nel paragrafo 13 del saggio su Battello ebbro. In questo senso ha ragione Cavalletti nell’affermare che quest’ultimo è anche un passo avanti rispetto a Spartakus, ma non nel senso del superamento dialettico hegeliano. Il giudizio di Cavalletti che il saggio in questione sarebbe anche una critica degli spartachisti come si evince nella conferenza di Scaldasole Books non mi convince, se non in parte. Jesi non rivede il suo giudizio, contenuto in Spartakus e per questa ragione lo riporto una seconda volta qui:
[…] Siamo perfettamente disposti a considerare la morte di Liebknecht e della Luxemburg, dal punto di vista della più razionale strategia politica, un errore; ma vogliamo distinguere le ragioni della loro scelta di morte da un “malinteso senso dell‘onore“ che fu individuato da alcuni storici subito dopo la seconda guerra mondiale … si trattò di usare la propaganda – oggi così simile a menzogna – nel suo significato più genuino: nello stesso significato – ci si consenta una digressione di tempo e di luogo – in cui nel Vietnam si è scelto il suicidio col fuoco come simbolo di reazione contro l’aggressione americana. Giocare la propria persona sul limite della morte mentre le vie del quartiere dei giornali di Berlino erano campi di battaglia, significò allora compiere la sutura fra mito genuino, affiorato spontaneamente e disinteressatamente dalla profondità della psiche e autentica propaganda politica. In questo modo la propaganda fu una manifestazione della, verità, o almeno di quella verità in cui credevano le vittime della sua epifania.. 22
Il suo concetto di superamento si smarca sempre dalle ferree leggi della dialettica, perché un superamento reale o avviene grazie a una praxis diversa, cioè a una parola-gesto diversa, oppure è un superamento idealistico che avviene solo nel concetto. Nei testi che sono confluiti in Il tempo della festa, almeno secondo quanto scrivono Cavalletti e Il saggio di Kieran Aarons, Cruel Festivals: Furio Jesi and the Critique of Political Autonomy Jesi criticherà anche la rivolta, ma senza condanne del passato spartachista o dei comunardi, e la ragione la vedo nell’essere lui stesso dentro quella necessità di possedere una parola-gesto che sia esposta e quindi riconoscibile. Questione quanto mai importante per noi che viviamo nel tempo della chiacchiera includente e della sinistra afasica.

1 Il saggio in questione ha il pregio di saltare sopra tutta una serie di problemi, per andare al nocciolo di una questione di grande importanza e cioè il modo di trattare da parte di entrambi la dialettica e il tempo. Anche Benjamin si pose una prima volta questo problema nel più importante dei suoi saggi giovanili, intitolato Della violenza e del diritto, scritto nel 1921. Il saggio può essere considerato come la sua riflessione sulla Rivoluzione d’Ottobre. In esso, oltre a sostenere con forza la piena legittimità della rivoluzione, si poneva tuttavia il problema di non dare per scontata l’esistenza di coppie dialettiche che invece vanno viste nelle loro diverse componenti interne e non nelle immagini sintetiche che se ne danno. La riflessione di Jesi sugli stessi argomenti ha delle analogie con l’opera di Benjamin, che Jesi conosceva molto bene.
2 Spartakus. Simbologia della rivolta, a cura di Andrea Cavalletti, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pag. 14.
3 Thomas Mann La montagna incantata. La mia edizione è quella antica di Dall’Oglio pubblicata nel 1930 , pag. 803.
4 L’espressione è usata diverse volte nel libro e anche in altri saggi
5 Furio Jesi, Spartakus,Simbologia della rivolta, Bollati Boringheiri, Torino 2000, pag. 15.
6 Nel prosieguo del testo Jesi abbonda di digressioni storiche ma anche di riferimenti al teatro proletario di Piscator con accenti che ricordano le esperienze compiute da Benjamin e Lācis a Riga e a Mosca. Questa parte del libro sarà un po’ trascurata per arrivare invece a uno snodo che ci riporta al tema centrale di questa riflessione. Il libro di Jesi, non facilmente reperibile se non in biblioteca, merita di certo una lettura nella sua totalità.
7 Op.cit.pag. 19.
8 Op. cit. pp.18-33.
9 Il saggio in questione s’intitola Che cos’è il teatro epico in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966.
10 Op.cit.pp.15-16.
11 Op,cit. pag. 82. Credo sia utile aggiungere una breve spiegazione di alcune parti di questa citazione, che anche il libro fa. Luxemburg e Liebknecht avrebbero potuto lasciare Berlino in tutta sicurezza e rifugiarsi altrove, ma decisero di rimanere e di correre il rischio della loro cattura e morte, quasi certa viste le circostanze.
12 Op.cit. pag.83.
13 Ivi.
14 Spartakus, simbologia della rivolta, pag. 11 Alla vigilia della sua partenza per Parigi Rimbaud legge il Bateau ivre all’amico Ernest Delahye. Consegnandogli il testo aggiunge: “L’ho fatto perché lo vedano quelli di Parigi“. Op.cit. Pag.13.
15 Furio Jesi, Lettura del Bateau Ivre di Rimbaud, con prefazione di Giorgio Agamben un saggio di Andrea Cavalletti, Quodlibet, pag.28.
16 Op.cit. pp-20-30.
17 Nel saggio su Rimbaud alla pagina 23-4.
18 Furio Jesi, lettura del Bateau ivre, pag. 28.
19 Op.cit. pp. 39-43.
20 Op. cit. Pag. 22.
21 Op.cit.31.
22 Op.cit.pp.15-16.

Ricevo dalle Nina’s Drag Queen il programma della nuova edizione di Fuori Asse, che si tiene, come quella scorso anno, in Triennale. Gli scambi fra teatro e arte circense sono relativamente nuovi e promettono assai bene. L’edizione dello scorso anno fu un indubbio successo, che mi auguro sia ripetuto in questa nuova edizione di cui di seguito vedete il programma.
Fuori Asse Focus 2024 | AI CONFINI DEL CIRCO presenta una selezione di quattro spettacoli di circo contemporaneo a cura degli amici di Quattrox4 programmati all’interno di Triennale Milano Teatro.
Per Quattrox4 il circo è creazione, in transizione tra generi e stili, capace di superare il virtuosismo per aprire a nuovi scenari. Gli spettacoli in programma sono consigliati dagli 8 anni in su.
Giunto alla sua terza edizione, Fuori Asse Focus 2024 | AI CONFINI DEL CIRCO è un format di visione con accompagnamento critico curato da Quattrox4 all’interno di Triennale Milano Teatro: quattro spettacoli di circo contemporaneo, due incontri con gli artist*, una tavola rotonda per operatrici e operatori interessati alle nuove funzioni della critica nel circo contemporaneo. Gli spettacoli in programma esprimono una visione audace del circo contemporaneo come arte di creazione, in transizione tra generi e stili, capace di superare il virtuosismo per aprire a nuovi scenari della performance tra sperimentazione e forme ibride site-specific, muovendosi sul margine tra danza, teatro, installazione e performance art.
Venerdì 19 Gennaio 2024
20:00 LONTANO + INSTANTE di Marica Marinoni e Juan Ignacio Tula (30’+ 30’)
Sabato 20 Gennaio 2024
17:00 ONLY BONES v1.6 di Marina Cherry (30’)
18:00 Incontro con Juan Ignacio Tula e Marica Marinoni (60’)
20:00 C’EST L’HIVER, LE CIEL EST BLEU di Amanda Homa e Idriss Roca (60’)
Domenica 21 Gennaio 2024
11:30 TAVOLA ROTONDA sulla critica nel circo contemporaneo (120′)
15:30 C’EST L’HIVER, LE CIEL EST BLEU di Amanda Homa e Idriss Roca (60’)
17:00 ONLY BONES v1.6 di Marina Cherry (30’)
18:00 Incontro con Amanda Homa, Idriss Roca e Marina Cherry (60’)
19:30 LONTANO + INSTANTE di Marica Marinoni e Juan Ignacio Tula (30’+ 30’)
Triennale Milano Teatro
viale Emilio Alemagna 6, 20121 Milano
Le polemiche indecenti seguite al discorso di Paola Cortellesi alla Luiss, non stupiscono più di tanto. L’università, peraltro, ha compiuto una scelta quanto mai opportuna: mettere in rete il discorso tenuto da Cortellesi. Lo si può ascoltare ma questo servirà a poco e di certo non a coloro che hanno innescato una polemica sul nulla. Mi sono limitato a raccogliere alcuni degli interventi più sensati e ad assemblarli. In fondo alla pagina il link per permette di ascoltare o di leggere il discorso.
Da Donnapop
Prima che lo diciate voi, lo facciamo noi: sì, ci sono argomenti più importanti delle fiabe Disney. No, non abbiamo intenzione di fare la guerra a Biancaneve o Cenerentola. Quello che vogliamo fare, piuttosto, è una riflessione sul modo in cui siamo cresciute e cresciuti.
Paola Cortellesi, ospite dell’università Luiss, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, ha parlato degli stereotipi sessisti nelle fiabe e di come intere generazioni siano cresciute con esempi di donne principalmente belle, ingenue e non in grado di salvarsi da sole. Donne, insomma, che non sono nemmeno la metà della mela, ma forse solo un quarto. Il resto, ovviamente lo fa l’uomo: è l’uomo che le vuole, le cerca, le trova, le sceglie e le sposa. Ma, soprattutto, le salva.
Ecco alcuni passaggi del monologo di Cortellesi: «Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l’avrebbe salvata lo stesso?. Perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia?». E ancora: «Biancaneve faceva la colf ai sette nani». L’attrice e regista, in altre parole, ha parlato della necessità di riconoscere i luoghi comuni e gli stereotipi che hanno costruito la cultura maschilista e patriarcale in Italia.
Il fatto che Cortellesi abbia pienamente ragione e abbia colto nel segno, lo dimostra la reazione di alcuni uomini piccoli, evidentemente spaventati e minacciati dalle parole dell’attrice. Cruciani, ad esempio, ha definito il discorso di Cortellesi una «puttanata colossale». Non solo: come spesso fanno certi uomini, ha tentato anche di depotenziarla e delegittimarla, presentandola come «Paola Cortellesi, famosa attrice, regista, forse produttrice… ormai tutti fanno tutto».
Sì, caro Cruciani, Cortellesi fa tutto e lo fa anche molto bene. Ed è una donna, anche se questo fatto ti infastidisce tanto. Una donna libera, per la precisione.
#donnapop #paolacortellesi #ceancoradomani #cruciani #sessismo #biancaneve
Paola Cortellesi alla Luiss
Ma come si fa a impiantare una polemica sul “genere” delle favole a partire da un discorso che ha l’intelligenza critica, ma anche l’ironia e la leggerezza di Paola Cortellesi, le qualità che hanno fatto tanto apprezzare il suo film? Se abbiamo riconosciuto a Carla Lonzi il coraggio di dire “Sputiamo su Hegel”, perché dovremmo toglierci il piacere di farci una risata su Cenerentola, Biancaneve, le loro malvagie matrigne, i loro principi evanescenti? Purtroppo non stiamo solo perdendo il pensiero critico, ma anche il senso liberatorio della comicità. Al grande successo di pubblico del film della Cortellesi non ha contribuito solo il tema purtroppo sempre attuale della violenza domestica ma il fatto di averlo affrontato con la distanza necessaria per mostrarne l’aspetto grottesco, avvilente e risibile al medesimo tempo.
Grazie Paola Cortellesi.
Ecco finalmente il discorso integrale di Paola Cortellesi alla Luiss.
Grazie a Paola Casella per la segnalazione.
Due giorni di polemiche inutili.
https://tg24.sky.it/spettacolo/2024/01/15/paola-cortellesi-monologo-luiss


Le recenti riflessioni di Massimo Cacciari sul patriarcato stanno facendo discutere. Le argomentazioni del filosofo sono bizzarre e cervellotiche, ma comunque contengono spunti con i quali la discussione è possibile, a differenza di molti altri interventi maschili, perlopiù giornalistici, che oscillano fra ignoranza, dileggio e, passando per il sarcasmo, sfiorano nei casi più efferati un linguaggio che è istigazione a delinquere.
A Cacciari ha risposto Nicola Fanizza nel brano qui di seguito che getta uno sguardo su diversi altri problemi:
Quando Cacciari dice che il Patriarcato è finito con l’avvento del Rinascimento si sbaglia. Di fatto, nel XV secolo, cominciò ad affermarsi la famiglia mononucleare – composta dai soli genitori e figli – in luogo del Patriarcato o famiglia allargata. Lo sviluppo dello spazio sociale divenne il fuoco da cui si originò il Rinascimento, che va inteso come rinascita del soggetto, di un soggetto che dice il vero.
Così, a partire da quel periodo, il soggetto che dice il vero, però, non sarà più, a differenza di quando avveniva nel mondo ellenico, solo l’uomo bensì anche la donna. Non è un caso che quest’ultima, come Sibilla, venga rappresentata dai pittori del tempo non più come un viatico, come ciò che agevola il transito dell’uomo verso la verità, bensì come una donna che pensa, come una donna che dubita, come una donna che dice il vero. Insomma come un soggetto autonomo.
Fu, tuttavia, solo l’inizio. Il Rinascimento – e questo Cacciari non l’ ha capito, è stato e si configura ancora oggi come un’onda lunga, un onda che non si è ancora esaurita. Il Patriarcato, infatti, esiste tutt’ora, è onnipervasivo, pervade e avvelena ancora lo spazio sociale, impedendo alle donne di pervenire alla loro autonomia, alla loro libertà.
A questo intervento sono seguiti altri commenti che si trovano sulla mia pagina facebook: tutti contengono riflessioni importanti e a quelli rimando.
Adele Cambria, in un’intervista di alcuni anni fa e riproposta di recente a Radio Popolare sosteneva che se si parla solo di patriarcato senza aggiungere che esso è in crisi in tutto il mondo, si rischia di cogliere solo un aspetto della realtà attuale e neppure il più importante. Dall’Iran agli Stati uniti, dalle manifestazioni in Europa e anche in America latina, dove le associazioni femminili delle comunità indigene svolgono un ruolo di primo piano anche nel mettere in discussione la natura patriarcale di governi apparentemente progressisti come era quello di Evo Morales.
Il dominio maschile assume in tale contesto caratteristiche nuove: in Italia, una minoranza di uomini, di cui molti giovani, che si muovono come un’avanguardia acefala dentro un mare di complicità indirette, pretende di esercitare un dominio basato solo sulla violenza fisica e la forza; ma non si tratta del ritorno all’orda primitiva come sostiene una parte della cultura di destra, ma di una reazione violenta alla perdita di autorevolezza, potere e privilegi.
Si aprono qui due problemi a mio avviso: uno riguarda la cultura più reazionaria e di destra che sostiene che il patriarcato non esiste più e che trova svariati echi anche in atri settori dell’opinione pubblica. Il contrasto a questa deriva che è mondiale anch’essa nelle diverse forme che assume, rimane fondamentale, ma a patto che si ragioni sui limiti della cultura democratica e di sinistra. Il femminicidio di Giulia Cecchettin segna a mio avviso in Italia una svolta importante anche nella consapevolezza maschile e questo è testimoniato da livore con cui la parte più reazionaria sta reagendo; ma il problema principale rimane l’altro e cioè i limiti della risposta democratica e di sinistra.
Alisa Del Re sul Manifesto del 2 dicembre scorso ha pubblicato un articolo che – a mio avviso – ha un inizio davvero singolare, Cari compagni. La prima cosa che ho pensato è stata: ma a chi si rivolge? Perché se si tratta di un modo di ritornare al conflitto degli anni ’70 che vide a un certo punto la sinistra extraparlamentare di allora entrare in rotta di collisione con i nascenti femminismi, il titolo ha un senso perché quelli compagni lo erano, nel senso che ragionavano almeno in termini anticapitalistici. Compagni oggi che cosa vuole dire? C’è qualcuno che ragiona in termini anticapitalistici? Ho pensato allora che fosse un modo di tendere la mano: finalmente avete capito gli errori di allora e si può tornare a ragionare insieme su qualcosa. La strada è certamente questa, ma il problema sta nel fatto che se si parla a quella generazione, che è anche la mia, si rischia di rimanere confinati nella nostra memoria, legittima, ma poco capace di intercettare le giovani generazioni. L’anticapitalismo, per le ragioni più diverse, sembra fuori dalle agende di tutti i movimenti che tutt’al più si limitano a criticarne gli aspetti più feroci. E laddove sembra esistere ancora, per esempio fra i gruppi iper leninisti, ma senza Lenin, esso si traduce in pratiche oscillanti fra il grottesco e il drammatico. Il problema però rimane: come coniugare nei termini oggi attuali un percorso che sia anticapitalistico ma con l’agenda femminista? Come coniugare diritti sociali e diritti civili? Alcune indicazione nel finale dell’intervento di Alisa Del Re ci sono e per quanto riguarda il ruolo che gli uomini possono avere è a mio avviso il solito, fatto di poche cose: rifiuto delle complicità indiretta, rifiuto del linguaggio sessista anche a costo di rompere relazioni, evitare le cene maschili basate sul pecoreccio, un po’ di fantasia e di immaginazione nell’inventare momenti collettivi di riflessione e testimonianza.


Black Monday in Polonia
Premessa
Il femminicidio di Giulia Cecchettin sta suscitando un dibattito che è il sintomo di una società profondamente malata. Lo sapevamo già, ma ci sono momenti in cui avvengono dei salti di qualità e credo che in questo abbia influito anche la recente diffusione e ancor più il successo di massa del film di Paola Cortellesi C’è ancora domani.
Il dibattito.
Il profluvio di analisi psicologiche e di autoflagellazioni maschili da cui siamo invasi trascura quasi sempre le ragioni strutturali e patriarcali della violenza maschile sulle donne, la cui estensione per età a maschi sempre più giovani chiama in causa tutto il processo educativo.
Mi sembra siano tre le mistificazioni più importanti, di cui una nuova particolarmente pericolosa, perché fatta propria anche da intellettuali non reazionari. La riassumo in poche parole così:
Il patriarcato ha delle regole, mentre quello cui stiamo assistendo è un ritorno all’orda primitiva maschile pre patriarcale. La sintesi: meglio il patriarcato che è pur sempre – specialmente in Europa aggiunge qualcuno – un mondo di regole in cui vi è spazio anche per i diritti delle donne.
Questa sintesi contiene un falso e molte mistificazioni. Scambiare per realtà la fiction antropologica di Freud sull’orda primitiva trasporta in un passato arcaico e originario un processo contemporaneo che ha tutt’altre motivazioni. Quanto alla fiction in sé, le acquisizioni recenti della paleo antropologia dovrebbero consigliare almeno la prudenza quando si fanno certe ipotesi. Mi sembra importante, a questo proposito, la lettura di un libro come L’alba di tutto di David Graeber e David Wengrow. I processi di imbestiamento (anche linguistico, come si evince leggendo certi articoli della destra più feroce) di una parte del mondo maschile sono un fenomeno modernissimo e rappresentano l’aspetto più appariscente di una reazione ben più vasta, che ha declinazioni diverse in contesti diversi ma una causa comune: reagire con violenza ai processi di liberazione delle donne. Faccio alcuni esempi che sembrano in apparenza lontani da noi. A vedere certe fotografie afgane degli anni ’50 e ’60 c’è da rimanere allibiti: donne che frequentavano l’università, abiti per nulla velati ecc. Com’è possibile? Sono sempre esistite delle minoranze emancipate anche in contesti di regole patriarcali severe, ma a un patto e cioè che si trattava di privilegi concessi a minoranze. Le cose sono cominciate a cambiare quando la massa delle donne ha rivendicato i propri diritti. Le repressioni di parte islamica più forti sono avvenute laddove le donne erano state protagoniste: le algerine, per esempio, che avevano partecipato in massa alla lotta di liberazione contro la Francia. In sostanza, se non ci si ribella, c’è sempre una minoranza emancipata che può farcela. Mutatis mutandis è quanto avviene oggi in Italia seppure in forme meno efferate ma altrettanto violente. Chi afferma che il patriarcato è un mondo di regole, dice in realtà un’altra cosa: state al vostro posto e qualcosa vi verrà concesso. Oppure ancor meglio – come accade nel film di Paola Cortellesi: devi stare zitta, ripete ossessivamente il personaggio più odioso del film, il nonno.
La seconda mistificazione mescola insieme elementi psicologici arrivando in qualche caso a definire Filippo Turetta – alternativamente – un malato o un bravo ragazzo. La sintesi è la condanna del delitto ma la negazione del femminicidio. Si punisce al massimo il crimine individuale, ma si negano le ragioni strutturali. Come ha scritto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, Turetta non è un malato ma un figlio sano del patriarcato. La fragilità maschile esiste eccome, ma invocarla in circostanze come queste non significa voler fare i conti con essa, ma cercare delle giustificazioni. In ogni caso, a chi volesse davvero uscire dal modello virilista e confrontarsi seriamente con la propria fragilità, consiglio per l’ennesima volta di leggere il libro di Edoardo Albinati: La scuola cattolica.
La terza mistificazione, di cui sono responsabili prima di tutto le forze di destra, sono i discorsi generici sull’educazione al rispetto, il piano presentato oggi dal Ministro, un guazzabuglio di false buone intenzioni. La versione leghista delle medesime false buone intenzioni consiste nell’affidare tutto alla famiglia. Sappiamo da tempo dalle statistiche che è nelle famiglie che si consumano le violenze di genere più diffuse. La famiglia non è mai stata un luogo idillico, ma non lo è neppure nella versione hollyvoodiana che viene veicolata da fiction statunitensi come Modern family, riverniciate di modernità e di ammiccamenti al mondo LGBTQ. Il familismo italiano, inoltre, ha un bagaglio assai pesante sulle proprie spalle, che non è patrimonio soltanto della cultura di destra, ma deriva anche dalla cesura che negli anni ’70 si produsse fra la sinistra vecchia e nuova e il femminismo. Andare avanti su una strada minimamente consapevole è togliere queste problematiche dall’ambito privato e familista e riportarle nello spazio pubblico, con lotte mirate e determinate per aumentare e sostenere i centri antiviolenza autogestiti, promuovere e consultori presidi territoriali, far funzionare reti di supporto che favoriscano le denunce.
Il film.
La pellicola di Paola Cortellesi merita un discorso critico importante perché si tratta di un film molto significativo e non solo di un’opera che ha saputo parlare a una platea molto vasta e mi piace pensare che l’ondata di sdegno seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin ma anche certi discorsi che si smarcano dai dibattiti più penosi, siano anche il segno che questo film ha seminato una consapevolezza importante in un pubblico vasto, trasversale e non soltanto femminile. Tre mi sembrano i motivi forti della sua narrazione e del montaggio: la capacità di giocare con tutti i cliché che il tema poteva suggerire riuscendo, con alcune mosse spiazzanti, a evitarli tutti ma sempre all’ultimo momento. Dall’uso del bianco e nero, al neorealismo, dalla finzione di far credere a chi vede il film che forse la fuga di Delia sarà con il vecchio carrozziere verso il nord mentre invece quando corre per recarsi al voto e passa davanti alla sua autofficina non si volta neppure verso di essa perché ha da fare qualcosa di molto più importante. Il secondo aspetto è il modo in cui le scene di violenza, solo accennate, si coniugano a un linguaggio musicale che scimmiotta quanto di più ipocrita si nasconde dietro il sogno d’amore. Infine, ma senza rivelare cosa accade per non togliere il gusto di vederlo a chi il film non lo ancora visto, il modo geniale in cui Delia manda all’aria il matrimonio della figlia sfruttando la violenza che il mondo maschile esercita su di loro e rivolgendogliela contro. Quanto all’ambientazione del ’46 e dunque nell’Italia della scelta fra monarchia e repubblica, non condivido quelle critiche che ne fanno una scelta poco comprensibile. Non le condivido perché Cortellesi non parla affatto del 1946 e ancora una volta gioca con il cliché per poi smarcarsi dal medesimo. Il film metabolizza il femminismo ma lo fa in modo traslato: una scena come quella in cui Delia affossa il matrimonio della figlia sarebbe impensabile senza gli anni ’70. Il 1946 è il dito che mostra la luna, il suo film non è il sogno di una cosa del passato (il voto alle donne), ma evoca un domani che ancora non c’è.
Qualche proposta.
La prima
Niente minuti di silenzio ma molto rumore, continuo e possibilmente sempre più forte. Questa mi sembra la prima cosa da dire e fare anche per essere vicini a Elena Cecchettin, che si è esposta con dichiarazioni molto forti.
La seconda
La mobilitazione degli uomini e le sue forme. In passato ho espresso perplessità su manifestazioni di massa di uomini che si sono tradotte in poche iniziative con molte contraddizioni. Tuttavia, l’intervista di Ciccone a Radiopopolare di qualche giorno fa mi sembra importante e quindi se arrivano proposte ben vengano: meglio se sono diffuse sul territorio. Continuo però a pensare che la rottura di complicità indirette con il gruppo maschile sia il modo per far venir meno la solidarietà fra maschi: le cene di soli uomini dove il pecoreccio è dietro l’angolo sono da evitare sempre.
La terza
Utilizzare il libro di Albinati La scuola cattolica per letture pubbliche non stop che continuino per ore, alternandosi al microfono con commenti e altro. Si può fare in teatri, in situazioni di massa o anche più modeste quantitativamente ma diffuse nel territorio.
La quarta
Boicottare in modo sistematico quei prodotti che veicolano messaggi sessisti – sia in forma diretta sia indiretta – nella loro pubblicità. Rispondo all’obiezione sulla impossibilità di farlo, vista il largo uso di pubblicità sessiste, che alcune esperienze fatte altrove invece smentiscono tale impossibilità. Non si tratta di boicottare tutto, ma di scegliere di volta in volta uno o due prodotti e bandirli per un periodo sufficientemente lungo per fare danni. Non bisogna dimenticare che quello da cui siamo oppressi è pur sempre una combinazione di patriarcato e capitalismo e che ciò che spaventa i maschi al governo di tutte le colorazioni politiche è la possibilità di interrompere il flusso delle merci. Altrimenti, anche la denuncia del sessismo nella pubblicità rimane confinato nell’ambito delle opzioni morali senza alcuna conseguenza politica.

Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso